 Nello scaffale: La Roma di Buffoni e la Roma di Praz
Nello scaffale: La Roma di Buffoni e la Roma di Praz
a cura di Luigia Sorrentino
Recensione di Fabrizio Fantoni (nella foto)
Dopo il romanzo “Zamel” uscito nel 2009 per i tipi di Marcos Ultra, Franco Buffoni torna alla poesia con una nuova raccolta – intitolata “Roma” ( Guanda, € 13,50) – tutta dedicata alla Città Eterna: “Che cosa fa Roma stamattina?/ Le luci non si spengono e i rumori/ Tardano, non si fanno sentire/ Che lenti gorgoglii. Dopo la sveglia/ E l’amore non previsto/ In un giorno di festa/ Si è riaddormentata/ Beata./ Roma di corsa, Roma disperata/ E scoordinata, adesso sei la viola/ Che scordata faceva imbestialire/ La cantante al crocicchio pedonale./ E tremava lo chiffon, vibrava d’ira.”
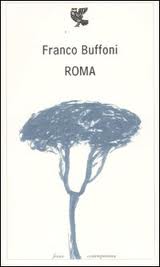 Un libro, questo, che, come scrive Valerio Magrelli nel risvolto di copertina, prende le mosse da “uno spaesamento geografico e antropoligico”, lo stupore provato dall’autore nel trovarsi di fronte ad un ambiente molto diverso da quello a cui le sue origini nordiche lo hanno abituato, il mondo della città mediterranea caratterizzato da una secolare accumulazione di umori, passioni, idee. Un mondo in cui il presente dialoga costantemente con il passato: “Da dove la balaustra prende il mare/ Sfiorando con disperata vanità / D’Ostia gli scavi,/ I resti oggi si scorgono di quello/ Che potrebbe definirsi un edificio/ Abitativo urbano di vaste dimensioni,/Una cafonata imperiale con disegni/ Geometrici a mosaico in marmo policromo,/ Opus alexandrinum a confrontarsi/ Con l’opus novum di un odierno/ Evasore totale”.
Un libro, questo, che, come scrive Valerio Magrelli nel risvolto di copertina, prende le mosse da “uno spaesamento geografico e antropoligico”, lo stupore provato dall’autore nel trovarsi di fronte ad un ambiente molto diverso da quello a cui le sue origini nordiche lo hanno abituato, il mondo della città mediterranea caratterizzato da una secolare accumulazione di umori, passioni, idee. Un mondo in cui il presente dialoga costantemente con il passato: “Da dove la balaustra prende il mare/ Sfiorando con disperata vanità / D’Ostia gli scavi,/ I resti oggi si scorgono di quello/ Che potrebbe definirsi un edificio/ Abitativo urbano di vaste dimensioni,/Una cafonata imperiale con disegni/ Geometrici a mosaico in marmo policromo,/ Opus alexandrinum a confrontarsi/ Con l’opus novum di un odierno/ Evasore totale”.
Il lettore si trova così a seguire l’autore nei suoi percorsi attraverso una Roma sempre diversa, ad un tempo raffinata e popolare, barocca e classicheggiante, cattolica e pagana. Una capitale, in cui ai dogmi della Chiesa si oppone il vagheggiamento di una “Lontana Grecia morta,” dove alla perfezione geometrica del Pantheon, fa da contraltare ” Un autogrill coi suoi bestioni/ Ornamentali attorno”.
In questi itinerari lo sguardo di Buffoni si sofferma, come sempre, sulle vite degli emarginati, di coloro che in ogni tempo, per motivi culturali, ideologici o per estrazione sociale si trovano ad essere esclusi, a condurre un’esistenza isolata e nascosta. E’ la “Roma desertica” di Giacomo Leopardi, suddito dello Stato Pontificio, schiacciato “Dalle mostruose tipologie censorie/ Che fu il governo della/ Reverenda Camera Apostolica” ; o, ancora, la Roma di Galileo Galilei umiliato “Dinanzi a cardinali tronfi e bolsi”; o, più semplicemente, è la Roma degli extracomunitari, delle colf, di coloro che “Vivono in case con pareti sottili/ Rischiarate da immagini di telegiornale/ Quelli dai figli che strillano,/ Scapoli-ammogliati/ La procreazione/ Quella grossa borsa ben tenuta/ Seduta spettarice.”
E di solitudine, parla anche il componimento dedicato alla casa – oggi aperta al pubblico come museo – in cui visse, come un clandestino, il più grande saggista del Novecento, Mario Praz: “Dove quel tavolino raffinato/ Da sessant’anni non viene usato,/ Solo guardato di sguincio o come oggi/ Analizzato./ Della casa d’autore visitabile/ Con quella patina di tempo non vissuto/ Depositato sugli arredi, di caffè/ non più versato e di polvere/ Non aspirata dai soumiers./ Vòlti a tappezzerie non rinnovate/ Persino piatti e bicchieri: lì ad assistere/ Al passaggio di cibi in digestione assunti altrove./ Casa viva? Intatta come morte morta e senza nome.”
Anglista, critico, scrittore e viaggiatore, Mario Praz affiancò alla sua lunga e variegata attività di uomo di lettere quella di collezionista di arredi del primo Ottocento. Una passione spinta fin quasi all’ossessione e di cui Praz parla nel suo libro più famoso intitolato “La casa della vita” ( 1958): un’autobiografia, in cui l’esistenza dell’autore viene narrata – quasi fosse un’immagine affiorante dalle “acque intorbidate” di un “antico specchio” – attraverso gli oggetti via via acquistati per arredare la sua abitazione.
Chi visita l’appartamento, situato al terzo piano di palazzo Primoli, si trova di fronte ad ambienti colmi di mobili, dipinti, sculture, cere, ventagli, porcellane e strumenti musicali, tutti realizzati in “un neoclassicismo domestico e alla mano, che ebbe la sua piena primavera nella Francia di Luigi XVI, la sua calda estate nell’Impero e il suo languido autunno nelle deliziose goffaggini del Biedermeier” . Oggetti scelti non solo per la loro bellezza ma, soprattutto, per la loro forza evocatrice, per la loro capacità di preservare il ricordo di chi ci ha preceduto. Scrive al riguardo Alberto Savinio: “Grande e mutabile è il destino dell’uomo, né di lui soltanto, ma di tutte quelle cose o piccole o grandi di cui ciascuno ama circondarsi quaggiù, e che costituiscono tanti regni minuscoli, sì, ma non men rispettabili dei regni maggiori. Oltre a ciò, la vita di un uomo che cos’è, a petto di quella dei muti compagni dell’uomo; vogliamo dire dei mobili, di tutti quegli oggetti che fedelmente e silenziosamente scortano la vita di un uomo, di una famiglia, di più generazioni? L’uomo passa e il mobile rimane: rimane a ricordare, a testimoniare, a evocare colui che non è più, a svelare talvolta alcuni segreti gelosissimi, che la faccia di lui, il suo sguardo, la sua voce celavano tenacemente” .
Il collezionismo di Praz si rivela, dunque, come l’affannosa ricerca di un tempo perduto che trae la sua origine dallo stretto rapporto che lo vide legato alla madre: la bella e sfortunata Giulia di Marsciano. Discendente da una nobile famiglia decaduta, morta prematuramente quando Praz era ancora un ragazzo, Giulia di Marsciano non potè godere di quel primato sociale di cui si erano avvantaggiati i suoi antenati; e fu proprio il desiderio di riscatto a spingere il giovane e sensibile Praz a ricostruire la dimora patrizia che circostanze avverse gli avevano impedito di ereditare dai suoi avi. Come scrive nella sua prefazione a “Le stanze della memoria” Stefano Susinno: “la casa eccezionale che Giulia di Marsciano non vedrà mai sembra fatta per ospitare un’assenza….””, per rimediare ad un torto subito. In quelle stanze che paiono uscite da una delle conversation pieces da lui tanto amate, si avverte la poesia delle cose che furono un tempo vive e che ora appaiono abbandonate, qui, più che altrove, è possibile udire la mesta musica del passato fatta di solitudine e di silenzio.
Una sensazione di voluttuosa immobilità permea i begli arredi che ornano la casa, arrivando a coinvolgere anche il panorama che si gode dalle finestre dell’appartamento. Mi riferisco alla distesa di tetti – descritta ne “La casa della vita” – che si snoda tra Via dei Soldati e Via della Scrofa: “Tetti di vecchie tegole di color rosa smarrito, coronati qua e la da qualche terrazza, dove, e questa è la cosa più straordinaria, rarissimamente si vede qualcuno. e di solito sono vecchiette che annaffiano i fiori, e uomini anziani che armeggiano a qualche riparazione, ma di giovani ho visto solo, l’anno scorso di luglio, due ragazze che nell’altana accanto alla Torre della Scimmia, si mettevano abitualmente sedute o sdraiate su un muretto e conversavano fino al crepuscolo e, da lontano, piaceva di pensare che potessero essere belle. Dalla parte del Lungotevere, sul Ponte Umberto, le ondate di automobili lanciate a intervalli dal semaforo, e quassù, sopra questa distesa di tetti dal colore delle foglie morte e dei petali di rosa secchi, una pace assoluta, una pace di paese, dove le campane della sera posseggono ancora un senso: un magico tappeto di pace, senz’anima viva ( Dio sia lodato!) sopra l’inferno delle strade”.
Eppure, anche dall’alto di questa specola, da questo luogo immutabile e senza tempo, la città ci appare caotica e disorganizzata come l’ha descritta Buffoni, “Roma di corsa, Roma disperata”.
—-
Recensione pubblicata su “Poeti e Poesia” Rivista Internazionale diretta da Elio Pecora N.20 – Luglio 2010
