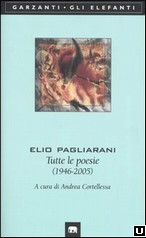 Andrea Cortellessa su Elio Pagliarani.
Andrea Cortellessa su Elio Pagliarani.
Estratto dall’introduzione al volume riassuntivo di Elio Pagliarani Tutte le Poesie (1946-2005) Garzanti, Gli Elefanti, (Milano 2006), a cura di Andrea Cortellessa.
—
Reduci da quali campi?
[…] Questo quasi quarantennale work in progress, La ballata di Rudi [Marsilio 1995], si presenta davvero quale “poesia da recita”. Nel titolo del testo i riferimenti in tal senso alla tradizione, tanto popolare che colta, sono molteplici; e ciascuno di essi non manca di coglierne un aspetto. Intanto, certo, la “ballata” romantica, in versi o prosa ritmata, coltivata in Italia da Berchet, Prati o Carducci (e che più in generale, esemplata sul Bürger, fu da noi per antonomasia associata al romanticismo d’oltralpe, nella sua versione a tinte più fosche e marcate): genere che associa a una pronunciata narratività un massiccio appello all’immaginario (nonché, nelle intenzioni, all’uditorio) popolare. Di nuovo l’Ottocento “basso”, insomma, che sempre interessa Pagliarani. Ma anche, forse, qualche eco della ballata antica, lirica e “alta” anzi “altissima” (ci si ricorda, allora, della presenza di Cavalcanti nella Ragazza Carla e in Inventario privato). Poi senz’altro un Novecento “basso” («la canzone di ritmo lento con un testo a carattere narrativo», la ballad insomma) e, forse soprattutto, “bassissimo” – spicciamente demotico -: il titolo infatti, precisa Francesca Bernardini, «in un’accezione regionale, vale anche alla lettera “giro di ballo”, rimanda cioè all’atto del ballare».
Per l’appunto attorno a una balera in Riviera ruota la prima parte della narrazione, che all’inizio vede abbastanza uniti e coesi i personaggi principali (Rudi e Aldo, seduttori da spiaggia e da dancing, «animatori / di balli sull’Adriatico», appunto; un certo numero di comparse femminili più o meno felicemente accoppiate ora all’uno ora all’altro; a parte, invece, Nandi, che se la spassa un po’ meno perché invece fa il pescatore: fisicamente vicino – lavora sulla stessa spiaggia – ma socialmente, e dunque testualmente, separato, appare in scena solo nella parte IX; infine Armando che di mestiere fa il tassista abusivo, a Milano, dove l’azione si sposta a partire da X). Questi personaggi, però, gradualmente prendono rilievo, ciascuno con le proprie storie, e si ritagliano più o meno lunghi excursus; tanto che già intitolare la “ballata” a Rudi (o «Rudy», com’è scritto il suo nome nelle prime pubblicazioni parziali del testo), lo ha notato Guglielmo Pianigiani, può apparire spiazzante. A fronte anzi del rilievo preso dalla storia del Tassista clandestino Armando (protagonista dalla parte XI alla parte XVII) Rudi passa decisamente in secondo piano: il narratore se ne disinteressa al punto di dare la notizia della sua morte solo in un rapido “a parte” di XXI, in forma di Ipotesi sul nostro.
 Eppure c’è da pensare che per Pagliarani un senso preciso, questa dedica, ce l’abbia; ed è precisamente, mi pare, quello di restare mentalmente e sentimentalmente fedele – lungo tutto l’interminabile tragitto elaborativo del testo – all’abbrivo della narrazione («[…] Rudi su un’altra spiaggia popolare / dà inizio alla ballata»): una narrazione concepita in un’altra Italia rispetto a quella che finalmente, nel 1995, legge questa sua “autobiografia”. Lo dice, in toni che non ammettono repliche, lo stesso Pagliarani nel prendere congedo dalla Cronistoria minima:
Eppure c’è da pensare che per Pagliarani un senso preciso, questa dedica, ce l’abbia; ed è precisamente, mi pare, quello di restare mentalmente e sentimentalmente fedele – lungo tutto l’interminabile tragitto elaborativo del testo – all’abbrivo della narrazione («[…] Rudi su un’altra spiaggia popolare / dà inizio alla ballata»): una narrazione concepita in un’altra Italia rispetto a quella che finalmente, nel 1995, legge questa sua “autobiografia”. Lo dice, in toni che non ammettono repliche, lo stesso Pagliarani nel prendere congedo dalla Cronistoria minima:
certo al tempo della Ragazza Carla non solo l’autore coltivava «svariate idee d’amore e di ingiustizia», ma anche tutto il nostro Paese: non così certamente negli anni della conclusione della Ballata, e anche prima, anche molto prima.
Già nel 1969, all’atto di riportarne un estratto su Quindici, Pagliarani avvertiva questo suo lavoro come annoso e, forse, “interminabile”:
La Ballata di Rudi l’ho cominciata nel maggio del ’61 e non l’ho ancora finita: ma non è che ci lavori tutti i giorni. I brani qui riportati sono stati scritti o impostati fra il ’63 e il ’65, la finzione è che l’ambiente sia il dodicennio 49/60, cioè dalla fine dell’immediato dopoguerra agli inizi della attuale società del benessere.
Una futura edizione critica della Ballata di Rudi sarà non solo un’impresa ardua, ma anche un eloquente spaccato del paesaggio sociale italiano lungo quasi quarant’anni di impressionanti metamorfosi: che il testo registra proprio in virtù del suo stratificarsi “interminabile”, e in effetti interminato (Raboni ha definito la sua forma «organicamente incompiuta»). Come ha detto Giulio Ferroni, forse nessun altro testo mostra la capacità di questo di «intrecciare nello svolgimento del discorso poetico il senso dello scorrere dei tempi, il senso concreto della vita italiana […] dagli anni Cinquanta a oggi. La ballata di Rudi è un libro incredibilmente sintetico e totale, perché in questo gioco di partiture ritmiche mette tutta l’identità del nostro paese: quello che era e quello che è divenuto – nel linguaggio – in tutta questa seconda metà di secolo».
Quella che andiamo descrivendo è, insomma, una dimensione epica. Per questo, fra l’altro, ha importanza il conservarsi costante – pur entro l’evolversi del tempo, dei tempi – dei riferimenti all’origine “mitica” del narrato (Rudi… dà inizio alla ballata); e per questo si accentuano, rispetto al testo “gemello” La ragazza Carla, la dimensione corale (l’alternarsi delle focalizzazioni rispetto all’incentrarsi, lì, sulla protagonista) e l’impersonalità della narrazione (ridotti davvero al minimo sono gli interventi del narratore, come per esempio lo stupendo interludio “lirico” – «rallentato improvviso», lo definisce Ferroni – di A spiaggia non ci sono colori, VI). Quanto all’origine c’è poi da sottolineare come il palinsesto “storico” del racconto affondi – a differenza della Ragazza Carla, tutta schiacciata su una sincronia (cioè su un, pur di poco storico, “presente 1948”) – in un antefatto, un “prima” quasi taciuto ma che illumina di riflessi allegorici l’intera narrazione: in tal senso sono rari ma decisivi gli accenni, nei primi “numeri”, a una coppia di miliardari nel cui “giro” ruotano Rudi e Aldo e dalle cui risorse deriva gran parte del «divertirsi» di quest’umanità di Riviera. Miliardari definiti «polverieri» perché, si capisce, durante la guerra facevano affari trafficando in esplosivi: «C’era la guerra / agli inizi, la polvere da sparo, gli esplosivi \ c’era molta richiesta» (II; si può pensare – per analogia strutturale – al nodo, dissimulato ma decisivo, in Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Gadda, della famiglia di «pescecani», cioè borsaneristi della Grande Guerra, dalla quale provengono gli «ori» dell’assassinata Liliana Balducci…). Più avanti, nell’episodio XIV, tornerà a lampeggiare la memoria traumatica della guerra: se di una ragazza ricoverata a «Villa Grazia» – la casa di cura per malattie mentali alla quale «ogni sabato mattina» si dirige il tassì di Armando – si dice che «è un’ebrea / reduce da Buchenwald». Mentre fra le ipotesi sul nostro – su quali siano state cioè le ragioni della morte di Rudi «nei primi anni Sessanta, in Svizzera, durante una cura del sonno» – c’è «chi dice che era già stato segnato dalla guerra / per via di un paracadute che non si aprì nel lancio, / quindi morfina come cura prima, eccetera».
 È nella catastrofe della guerra, insomma, che affonda le sue radici il disagio che – psichicamente strisciante – turba incrina e squassa, infine, l’apparente spensieratezza di questi personaggi; un disagio che, col passare del tempo e degli episodî, s’allarga sempre più sino a colpire, nella parte successiva all’orgiastico esplodere ritmico del Trittico di Nandi, tutto il contesto della vita associata – da Pagliarani raffigurata nelle sue mistificazioni mediatiche (l’alta moda, sineddoche della più degradata esteriorità che ottunde e “addormenta” le coscienze, nell’estratto dalla Bella addormentata allegato come episodio XXV), nell’imperio della disumanizzante burocrazia tecnocratica (Un computer come giudice), nel conflitto tra l’ortodossia clericale impersonata dal «cardinal Ratzinger» e certi ritornanti tentativi della scienza, stavolta in àmbito genetico, infine di nuovo nel disagio giovanile (come spesso, in Pagliarani, segnalato dai disturbi all’alimentazione). Il conclusivo Rap dell’anoressia o bulimia che sia, infatti, si ricollega ad anello proprio al palinsesto allegorico della guerra e dei suoi effetti: «Fra parentesi?: all’inizio di questo rendiconto se c’era una ragazza / stramba, senza ragione apparente, si trattava di reduci quasi sempre da campi / di concentramento, da quali campi sono reduci ora?»
È nella catastrofe della guerra, insomma, che affonda le sue radici il disagio che – psichicamente strisciante – turba incrina e squassa, infine, l’apparente spensieratezza di questi personaggi; un disagio che, col passare del tempo e degli episodî, s’allarga sempre più sino a colpire, nella parte successiva all’orgiastico esplodere ritmico del Trittico di Nandi, tutto il contesto della vita associata – da Pagliarani raffigurata nelle sue mistificazioni mediatiche (l’alta moda, sineddoche della più degradata esteriorità che ottunde e “addormenta” le coscienze, nell’estratto dalla Bella addormentata allegato come episodio XXV), nell’imperio della disumanizzante burocrazia tecnocratica (Un computer come giudice), nel conflitto tra l’ortodossia clericale impersonata dal «cardinal Ratzinger» e certi ritornanti tentativi della scienza, stavolta in àmbito genetico, infine di nuovo nel disagio giovanile (come spesso, in Pagliarani, segnalato dai disturbi all’alimentazione). Il conclusivo Rap dell’anoressia o bulimia che sia, infatti, si ricollega ad anello proprio al palinsesto allegorico della guerra e dei suoi effetti: «Fra parentesi?: all’inizio di questo rendiconto se c’era una ragazza / stramba, senza ragione apparente, si trattava di reduci quasi sempre da campi / di concentramento, da quali campi sono reduci ora?»
Nel già citato episodio II fa la sua prima comparsa – apparentemente incongrua – la memoria del «quartiere di Goffredo di Buglione / davanti a Gerusalemme» (al quale si associa la «tenda sulla spiaggia» del «vecchio miliardario», «con pennacchio sventolante»). Tornerà molto più avanti (XX): quando l’ormai da tempo inurbato Rudi, trafficone e trasformista, per via di certi suoi traffici finanziari col Vaticano si farà addirittura Cavaliere di Malta (e vengono accuratamente descritti tutti i suoi mascheramenti)… Acutamente ha sottolineato questi due passaggi Marianna Marrucci, rinviando alla Gerusalemme liberata tassiana e vedendovi, dunque, un richiamo all’epica della tradizione; ma un richiamo parodico: perché ben diversi da quelli sanguinosamente propugnati dai crociati sono i “valori” dei quali si fa portatore Rudi. In effetti il suo ruolo è letteralmente quello del “portatore di valori”: ormai si guadagna da vivere, infatti, come mediatore di investimenti finanziari. Col boom degli anni Sessanta è, quella degli investimenti “facili” che però possono scialacquare in un attimo risparmi tesaurizzati per generazioni, una sfera che s’introduce nel vissuto degli umili personaggi della Ballata – come «la Camilla», che «adesso […] gioca in Borsa» – con tutta la sua carica straniante e derealizzante: «c’è il Toro ora in Borsa, non c’è l’Orso, spiegava l’altra sera Rudi al night» (XIX). Ci si ricorda di un capolavoro cinematografico del 1962, L’eclisse di Michelangelo Antonioni: nel quale correlativo oggettivo dell’alienazione che divora i sentimenti dei protagonisti è, specie nella sproporzionata, formidabile digressione narrativa che occupa il centro del film, proprio la Borsa.
Del resto finisce per farsi “portavalori” anche il «tassista clandestino» Armando: quando viene coinvolto (dal tenebroso, ermetico «avvocato» che ogni sabato mattina si fa accompagnare a Villa Grazia) in un losco affare sudamericano che alla fine si rivela, per l’appunto, un traffico di «valuta» (XVI). La parentesi “alchemica” del Trittico di Nandi trova dunque, con la fabula della Ballata, un collegamento allusivo, analogico: il denaro, simboleggiato dall’oro (la convertibilità oro-dollaro – passaggio epocale decisivo, in termini economici, del secondo Novecento – verrà meno il 15 agosto 1971 per decisione di Richard Nixon), viene rappresentato nella sua sostanza volatile proprio mediante l’atto della sua fusione. Da questo momento in poi si smaterializza ogni valore e, con esso, perde visibilità anche quanto alla produzione dei beni è, o era, collegato: cioè, appunto, il lavoro.
Se il tema di fondo della Ragazza Carla era proprio il lavoro, la sua dimensione alienante ma anche la possibilità di riscatto da esso costituita, e se la sua materia era dura e compatta quanto fisicamente duro e gravoso l’impegno quotidiano di Carla Dondi, La ballata di Rudi ci racconta – in estrema sintesi – proprio come sia venuta meno, negli anni e nei decenni, l’ambivalente durezza di quel mondo: e come a essa si sia sostituito, gradualmente e insensibilmente, un fluido e quasi spettrale scambio di risorse immateriali. Questo passaggio epocale traduce e trascina con sé anche tutta una serie di modifiche, oltre che immateriali assai tangibilmente materiali, che catastroficamente segnano il paesaggio visibile oltre a quello profondo (cioè morale e mentale). Tali modificazioni Pagliarani le ha riassunte nella voce redatta per il già ricordato Autodizionario degli scrittori italiani:
 Nel frattempo però il suo paese natale […] non c’è più, è scomparso: come se gli avessero tolto una sedia di sotto il sedere: Viserba era sorta nella seconda metà dell’Ottocento perché ci avevano impiantato la corderia (lavoravano soprattutto il lino), e si fermava il treno, e poi era nata l’industria dei bagni […] Adesso non c’è più soluzione di continuità tra Rimini e Viserba, è tutto un Rimini nord, tutto alberghi e pensioni, una zona balneare un po’ più popolare di Rimini centro, con ignoranza e presunzione rubiconde di benessere.
Nel frattempo però il suo paese natale […] non c’è più, è scomparso: come se gli avessero tolto una sedia di sotto il sedere: Viserba era sorta nella seconda metà dell’Ottocento perché ci avevano impiantato la corderia (lavoravano soprattutto il lino), e si fermava il treno, e poi era nata l’industria dei bagni […] Adesso non c’è più soluzione di continuità tra Rimini e Viserba, è tutto un Rimini nord, tutto alberghi e pensioni, una zona balneare un po’ più popolare di Rimini centro, con ignoranza e presunzione rubiconde di benessere.
La fine di un paesaggio condiviso è anche, si capisce, la fine di un condiviso patrimonio di esperienze e “valori”, appunto, che l’Italia del cosiddetto benessere, «adesso che si affoga nella roba» insomma, ha dimenticato e irriso. Per questo la dimensione epica – in Pagliarani come, più in generale, nella letteratura della modernità – non può che essere interdetta: intravista, tentata (proviamo ancora), sfiorata a tratti: mai conseguita appieno. Come ha scritto Marianna Marrucci, «è in gioco una tensione a tramandare un patrimonio narrativo comune, che non trova, però, una soddisfazione. Mancano i presupposti storico-sociali e culturali perché il modello del narratore epico sia davvero riproponibile; è possibile soltanto una sua attualizzazione in una forma, in qualche modo, infetta».
Epico insomma è, più che il genere letterario, il modo della narrazione. In questo La ballata di Rudi si può accostare a un altro grande testo moderno, Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo, parimenti stratificatosi nel tempo (a partire dagli stessi anni Cinquanta nei quali si comincia a raggrumare la materia della Ballata) e che nel tempo ha infatti accompagnato, coi propri mutamenti testuali, le mutazioni di un amatissimo paesaggio italiano: qui la Riviera Adriatica, lì lo Stretto di Messina. In entrambi è presente una comunità di pescatori (in D’Arrigo i «pellisquadra»; in Pagliarani «i braccianti del mare», che lavorano al ritmo dettato da Nandi) alla quale è delegata la conservazione di un contatto collettivo, irriflesso ma vivissimo, con l’universo atemporale e “mitico” – giusta vulgata junghiano-ferencziana – simboleggiato, appunto, dal mare. Alle spalle, del resto, si colloca un grande archetipo comune come Moby Dick. Ma soprattutto, in entrambi i casi, questo stesso fondo immutabile si scopre d’improvviso minacciato, invece, da una simile mutazione violenta (in tutti e due i testi, infatti, legata al passaggio della guerra). In Horcynus Orca l’infezione, il passaggio della morte-in-vita – il mostro marino che dà il titolo al romanzo -, è allegoria della «fine di un mondo divenuto sterile», ha scritto Walter Pedullà; ma ancora più evidente è, tale dimensione, nella Ballata di Rudi. Che ha il proprio refrain in un timore paradossale quanto attualissimo (memoria remota degli ultimi versi di Finale, nella Terra Promessa di Ungaretti: «Morto è anche lui, vedi, il mare, / Il mare»). Nel meraviglioso episodio IX, A tratta si tirano, in scena sono appunto i «braccianti del mare»; il loro lavoro è «danza notturna di schiavi», sì, ma anche accordo autentico d’una comunità (la quale riconosce in Nandi, appunto, un sapere tradizionale e senza tempo: «perciò quando Nandi dice butta giù bisogna buttarle giù subito / le reti»). È insomma «ostinazione»
che rinnova delusione senza rassegnazione che non ha senso pensare che s’appassisca il mare
Ma è proprio qui che si emette una sentenza atroce: «adesso che si affoga nella roba» (ha tanto più rilievo, allora, che – come ha sottolineato Francesco Muzzioli – la clausola venga aggiunta da Pagliarani, rispetto a una prima versione dell’episodio apparsa nel ’65, solo all’altezza del ’73), proprio adesso
invece ha senso pensare che s’appassisca il mare.
Il refrain viene inserito da Pagliarani anche in clausola alla versione che del Trittico di Nandi “monta” nella Ballata: «Epperò ha senso pensare che s’appassisca il mare». (Anche in questo caso si tratta di una variante di gran peso: tra la versione del ’77 e quella del ’95.) Ma l’ultimo gesto, quello che con un unico, interminabile verso a quattro “gradini” conclude e dà senso all’interminabile per antonomasia, la Ballata appunto, suona come un ennesimo, interminato rilancio:
Ma dobbiamo continuare
come se
non avesse senso pensare
che s’appassisca il mare.
.
Siamo in troppi a farmi schifo
Il falso benessere – icasticamente emblematizzato da anoressia e bulimia – è, l’abbiamo visto, tema principe nell’ultima parte della Ballata di Rudi. Ed è tema squisitamente pasoliniano. Nel (bellissimo) componimento in memoria del vecchio-giovane maestro di Officina – scritto nel ventennale della sua tragica morte, nel ’95 – Pagliarani mostra nei suoi confronti tutta la propria ambivalenza (la rabbia, sua come di tanti altri italiani, a leggere il famigerato attacco degli Scritti corsari: «Che paese meraviglioso era l’Italia durante il periodo del fascismo e subito dopo!») ma anche, alla fine, tutti i suoi rimorsi:
La rabbia che mi facevi con l’esempio dei contadini friulani
che stavano meglio prima, negli anni Trenta/Quaranta
l’angoscia della tua voce
incrinata spezzata da un vento gelido di morte che mi pareva a effetto […]
potrò perdonarti di aver detto la verità, che questo benessere è una rovina
che tu avevi prevista, che l’uomo più sta bene più è egoista
potrò mai perdonarmi
che quel grido quel vento altro che a effetto, altro che artificiale
erano le tue stimmate
era nelle tue viscere
ti era consubstanziale.
 Non a caso ha voluto accludere Pagliarani, alla nuova edizione dei suoi Epigrammi che è a tutt’oggi l’ultimo libro che abbia licenziato (Piero Manni 2001), una nota che – se in termini meramente formali potrebbe apparire fuorviante – da un punto di vista morale ha tutto il valore di un riconoscimento postumo il cui senso, a questo punto, non può sfuggirci: «Dopo aver compiuto e pubblicato questa ricerca, mi accorsi che la mia parte di lavoro potevo e dovevo definirla un omaggio a Pasolini». Non tanto riferendosi, dunque, ai (dai suoi così diversi) epigrammi della Religione del mio tempo, quelli che procurarono il successo di scandalo ma anche la fine di Officina; bensì, propriamente, a quel “dire la verità” dell’ultimo Pasolini “corsaro” e “luterano” che a Pagliarani dové sembrare una via più diretta e contundente, rispetto alla complessa e sfaccettata allegoria della Ballata di Rudi, per segnare a dito le storture della mutazione italiana, «antropologica» e non solo. Ma anche perché quella “verità” si poteva e doveva dire, da parte di Pasolini come da parte sua, in virtù di una necessità assoluta, quasi èmpito fisiologico. Così si conclude, infatti, il componimento del ’95:
Non a caso ha voluto accludere Pagliarani, alla nuova edizione dei suoi Epigrammi che è a tutt’oggi l’ultimo libro che abbia licenziato (Piero Manni 2001), una nota che – se in termini meramente formali potrebbe apparire fuorviante – da un punto di vista morale ha tutto il valore di un riconoscimento postumo il cui senso, a questo punto, non può sfuggirci: «Dopo aver compiuto e pubblicato questa ricerca, mi accorsi che la mia parte di lavoro potevo e dovevo definirla un omaggio a Pasolini». Non tanto riferendosi, dunque, ai (dai suoi così diversi) epigrammi della Religione del mio tempo, quelli che procurarono il successo di scandalo ma anche la fine di Officina; bensì, propriamente, a quel “dire la verità” dell’ultimo Pasolini “corsaro” e “luterano” che a Pagliarani dové sembrare una via più diretta e contundente, rispetto alla complessa e sfaccettata allegoria della Ballata di Rudi, per segnare a dito le storture della mutazione italiana, «antropologica» e non solo. Ma anche perché quella “verità” si poteva e doveva dire, da parte di Pasolini come da parte sua, in virtù di una necessità assoluta, quasi èmpito fisiologico. Così si conclude, infatti, il componimento del ’95:
(Solo dopo aver trascritto epigrammi da Savonarola
La carne è un abisso che tira in mille modi.
Così intendi della libidine dello Stato /
mi resi conto che dialogavo ancora con te).
Un’ulteriore conferma – che sia questo il debito maggiore di Pagliarani nei confronti di Pasolini – deriva dal fatto che, appunto nell’edizione del 2001, a quelli Ferraresi tratti appunto dalle prediche di Savonarola (pubblicati una prima volta, sempre da Manni, nell’87) abbia aggiunto – oltre a nuovi episodî savonaroliani (fra i quali il gustosissimo Della manna di Maastricht, mormorazioni, che torna – in modo devastante – sul tema degli eccessi di nutrizione) – Sette epigrammi dai detti conviviali di Martin Lutero: i quali si appropriano con toni viscerali e specificamente “ventrali”, appunto, dell’ètimo di tempestante intransigenza che proprio Pasolini ha associato alla qualifica di luterano: col titolo del suo libro “semipostumo” del ’76, Lettere luterane appunto. […]
Quello cui siamo di fronte […] è un vero e proprio cut-up allusivo e straniante, che – rispetto agli inserti anche più bruti della Ragazza Carla o di Lezione di fisica – delega per intero alle risorse decontestualizzanti del montaggio l’inversione parodica, e dunque il rovesciamento di senso, dei testi originali. Perché ora, tranne la veemente sovrapposizione ritmica (ha detto bene, in forma d’aforisma, Muzzioli: per Pagliarani «citare significa concitare») e qualche minimo ritocco a essa funzionale, la materia verbale risulta essere integralmente quella platonica, savonaroliana, luterana […].
Oggi come ai tempi della Ragazza Carla, insomma, ci resta solo questo cielo che «è nostro ed è morale», «che non promette scampo dalla terra, / proprio perché sulla terra non c’è / scampo da noi nella vita». Ma, dopo mezzo secolo di rospi ingoiati, a Pagliarani il fegato dètta un’ultima parola che è come un pugno in faccia. A tutti, a tutto. Naturalmente anche a se stesso: «Non so se avete capito: / siamo in troppi a farmi schifo».
L’addensarsi negli ultimi libri di precisazioni d’autore denota anche, credo, una volontà da parte sua di ristabilire una corretta successione, entro la propria produzione, delle reali fasi di concepimento e stesura (anche rispetto alla presente edizione, la quale non può non ordinare i suoi libri secondo le date d’edizione). Il completamento e la pubblicazione tardivissimi della Ballata, nonché il successo del libro (contrassegnato da un Premio Viareggio alla carriera) e la nuova attenzione critica conseguita, infatti, hanno sortito l’effetto paradossale di retrodatare, per così dire, la lezione di Pagliarani: riconducendola alla maniera narrativa ed epico-teatrale della Ragazza Carla e del secondo «romanzo in versi» (pur con tutte le differenze che si sono sottolineate). Mentre – almeno a partire dagli Esercizi platonici, abbiamo visto – la sua maniera è oramai un’altra, diversissima. E tutt’altro che priva d’effetto, sia detto per inciso, presso i giovani sperimentatori a cavallo del Novanta.
Uno di questi è senz’altro Tommaso Ottonieri: che in un suo vulcanico libro saggistico del 2000, La Plastica della Lingua, collega suggestivamente proprio la pratica del cut-up (accostata a quella, assai diversa, di Nanni Balestrini; ma non sarà un caso se, fra i Novissimi del ’61, proprio lui sia quello al quale Pagliarani è, da sempre, più legato) a quelle che definisce «forme epiche nella modernità in declino» («proviamo ancora con l’epos», insomma). Se la Ballata si conclude con un rap, dunque, è perché «ogni pratica hip-hop (e di cut-up), voce localizzata d’un soggetto collettivo, si definì essenzialmente in quanto epos». Anche il Pagliarani tardo, insomma, che pure pare così indistinguibile dalla pronuncia di una soggettività insofferente e persino scalmanata, sarebbe insomma, e più radicalmente di sempre (per l’estremismo del suo montaggio assoluto), “parlato” da una coralità senza voce: da un popolo che manca.
Come in fondo “Rudi” è incarnazione figurale – silhouette in forma di personaggio – della comunità di pescatori entro la quale vive e balla, cioè lavora: e intorno a essa di un’umanità avventizia, espropriata: un’umanità la cui esistenza “balla” perché non ha più una terra salda sotto i piedi. Intorno, insomma, balliamo tutti quanti noi.
—
Estratto dell’ultima parte dell’introduzione al volume riassuntivo di Elio Pagliarani Tutte le Poesie (1946-2005) Garzanti, Gli Elefanti, (Milano 2006), curato da Andrea Cortellessa.
