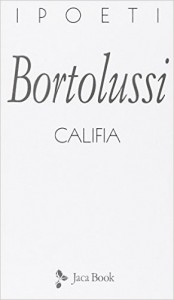 Califia è un libro che la nostra poesia d’oggi aspettava. Necessario, augurale. Bortolussi qui fonde lirica ed epica in un poema potente, di ampia e profonda risonanza. Califia è il primo nome dato alla California da Cortés, toccando le rive di quella terra, convinto che fosse un’isola: la battezzò così in onore di una leggendaria regina di donne guerriere in un’isola immaginaria dell’oceano indiano.
Califia è un libro che la nostra poesia d’oggi aspettava. Necessario, augurale. Bortolussi qui fonde lirica ed epica in un poema potente, di ampia e profonda risonanza. Califia è il primo nome dato alla California da Cortés, toccando le rive di quella terra, convinto che fosse un’isola: la battezzò così in onore di una leggendaria regina di donne guerriere in un’isola immaginaria dell’oceano indiano.
Califia è una sorta di “viaggio a Occidente” mentale e poetico, un “tutto” poematico e in parte drammaturgico, un’immersione nel profondo di una terra vista e vissuta come luogo di meraviglie e ierofanie, in cui mito e contemporaneo si fondono: il surfer, il povero migrante messicano vittima sacrificale dal coguaro, la musica West Coast anni Sessanta il grande regista Billy Wilder che assume la voce di Coyote, nella realtà atemporale, incantante di questa Atlantide americana. Le Metamorfosi di Ovidio, lo sciamanesimo degli indiani d’America, l’ombra di Hart Crane, il poeta del ponte di Brooklin, la lezione di Ritsos, Walcott, pochissimi altri autori “poematici” del nostro tempo, animano, in un respiro internazionale, una versificazione pacata e ardente, ventosa e narrante: un’indicazione di rotta per i poeti delle nuove generazioni: “-perché come mi ha dettato questa terra,/come di questa terra hanno scritto i suoi poeti,/ io sarò il viaggio, il viaggio sarà me.”
ROBERTO MUSSAPI
Forse questo andare senza muoversi,
liberato da trappole di tempo e di spazio,
finirà per rispondere meglio agli sparsi residui
del mio afflato esploratore –
e arriverò meglio, con più precisione di una stringa
di coordinate numeriche, a una destinazione
che per ora sento bello non conoscere.
E se nello slancio del cammino, nel volo,
dovessi virare senza averlo deciso
dalla Ciudad de la Iglesia de Nuestra Señora de Los Angeles
alla Manhattan settembrina di O’Hara,
e se dal ponte di Crane dovessi tuffarmi
fra i grandi squali bianchi delle Farallon,
non ci sarà nessuno a dirmi che è impossibile
o anche solo a suggerire che è improbabile
– perché come mi ha dettato questa terra,
come di questa terra hanno scritto i suoi poeti,
io sarò il viaggio, il viaggio sarà me.
Qui la terra è fatta per essere percorsa
all’infinito, senza lasciarsi abbagliare
da miraggi di destinazione o attendere
il verde superfluo dei semafori
– segui docile le curve di Mulholland
sulla striscia serpentina dell’asfalto
dove i sonagli vibrano dalle pareti calde di chaparral,
rallenti e svolti alla traversa che più sembra
promettere un arrivo e ti ritrovi
sulle colline delle figlie di Mnemosine
(non sono più soltanto nove, ti è difficile contarle,
se ne aggiungono di nuove a ogni nuova produzione):
la ladra cerbiatta è sfuggita alle sirene della fama
in qualche gola meno slanciata della sua,
ma a illuminare le sere di abbandoni
ci sono le altre, nascoste dietro i titoli di testa:
cangianti, multiformi, luminatrici di schermi
e di pensieri.
Oggi sembra che nasca tutto qui,
che da qui si debba riprendere ad andare,
da queste, fra queste pietre di millenni,
enormi scorie in attesa del Big One
piantate nella sabbia che Oceano mescola e setaccia
come a cercare l’oro del tempo
o il segreto di come sopravvivere all’oggi.
Altri tempi, diversi, hanno battezzato questo luogo:
Malibu, là dove risuonano i frangenti;
El Matador, l’uccisore di tori che ora si rifanno
caricando la costa a corna basse
con questa grande mareggiata da sud-ovest.
Arrivarci sembrerebbe difficile,
proibito addirittura, se non fosse per l’idea
che l’oceano da sempre detta agli uomini,
veri o di carta, che ci hanno fatto amare questo mondo:
partire sempre, senza domandarsi verso dove:
partire verso il dove.
Bruciano le ferite della terra che conducono al mare,
e la domanda si fa più rovente ancora della fiamma:
quali pensieri, se chiamarli tali è possibile,
avranno sfiorato per qualche irrimediabile secondo,
distratte dal ricordo del tuffo perfetto e tagliente
nella superficie specchiata della cava
la sera prima o quella prima ancora nell’estate,
le menti raccolte in ordine sparso nella cerchia
attorno a ciò che non poteva che apparire proibito?
Quale seduzione della corsa incoata all’azione
può averli spinti a strofinare il legno secco sulla pietra,
a rigirarlo fra le palme quasi unite delle mani
fino a vedere l’istante di luce, fino a udire
lo schiocco irritato che chiunque aveva loro insegnato
a rifuggire? Ma forse ha poco senso interrogarsi,
mentre si sorvola la distesa in fiamme
scorgendo in basso il profilo d’ombra delle ali
che scorre quasi inutile, leggero
quasi avesse paura di scottarsi,
sui motivi dei figli che come quello che fu il primo,
Fetonte di Apollo e Climene, si abbagliano alle scintille
dell’impresa e non vedono, già vive ma bluastre,
quasi trasparenti di calma e discrezione,
le prime delle lingue roventi che verranno:
forse il tracciato di stoppie nere e di carbone
che la terra ha sempre ereditato è parte,
condizione del suo ripresentarsi, il giorno dopo.
La colazione di Afrodite al Neptune’s Net
Sono pochi i testimoni nella rete di Nettuno
quando percorre di taglio l’ultima onda,
sfiorandone con le dita la parete verde
mentre l’altra mano, tesa all’infuori,
sembra imporre una pausa di attesa
alla vita che incrocia al di sotto, non vista;
pochi la vedono scivolare di lato, lustra
del suo stesso elemento, e in un solo gesto
abbracciare la lunga tavola di legno bucato
(è una kook box Hawaiian Hollow del ‘41,
rossa, pinna singola, due strisce avorio e arancione)
e sollevarla dalla schiuma che ricama County Line
come se il vecchio Tom Blake nel crearla avesse provato,
per ingraziarsi la cliente immortale che si aggirava
intenta fra cataste, banchi, pialle e vernici,
a forgiare il modello perfetto, capace di imporre
la sua sagoma sull’onda ma pronta a lasciare
all’acqua il proprio peso, docile sotto quello divino.
Non indossa il nero a proteggere le forme
della propria perfezione, tanto che nel momento
che l’occhio impiega a riconoscere realtà
in ciò che sembra immaginare la chiara nudità
della figura appare completa, e tanto più
numinosa quanto più esposta alle commosse
attenzioni dell’astro, agli arabeschi di pigmento
disegnati sul candore inumano della pelle,
alle fragili incrostazioni saline che tracciano
piccole repliche d’onde su una peluria
altrimenti invisibile, donandola all’occhio
abbagliato di chi non riesce a distoglierlo.
Avanza così verso la lingua sterrata davanti
alla veranda, la tavola ancora redolente di mare
lungo il fianco ondulato a clessidra dal capriccio
delle forme appena nate e rimaste nel tempo,
unità di misura dell’incanto che appartiene
da sempre a chi la vede arrivare, controluce.
Di fronte all’ingresso, accavezzate all’invisibile,
si pavoneggiano le creazioni biruote dei giganti
in pelle nera, irsuti di petto e ventre sfrenato,
le teste a prima vista rovesciate tanto è perfetta
la simmetria di assenza e abbondanza pilifera,
l’unisono rombo dei motori il loro saluto di rito;
nello spiazzo di lato alla cucina, insieme
ai cassonetti preda di quadrupedi notturni,
un’ombra così vasta e materica che potrebbe
far pensare al Minotauro soffia un refolo grigio
di Camel senza filtro verso la grazia bianca
in cammino, come a volerla carezzare con prensili
appendici di fumo: ma la brina continua a coprirla,
carezza insistita dei sargassi, e fa scivolare innocuo
tutto ciò che prova ad avvolgere stringere ghermire
colei che ora si offre di spalle, guizza le scapole
come creature nascoste sottopelle, si passa le dita
sui capelli accesi di rame e intagliando
un ultimo profilo indelebile nell’aria si lascia
inghiottire dal buio fragrante che le è noto,
e che ogni mattina la regala all’umano.
L’innato autolesionismo del plantigrado
You’re not human tonight, Marlowe.
Raymond Chandler
I.
Il giorno sembrava uno come tanti,
il vento caldo si era speso nello sforzo vano
di riportare in città la sabbia di Padre Deserto,
riuscendo a irritare perfino le fate morgane
ormai stanche, tremule di dubbi e pentimenti,
e il sole celato dietro le fronde del Chateau
pareva quasi offeso, come sfiorato dall’idea
di mai più sorgere dai monti né calarsi in mare,
tracciando un arco nuovo. A pochi metri,
nel rettangolo azzurro di svaghi e bracciate,
padre e figlia giocavano al tè delle cinque
nel cloro sotto la luce screziata in superficie,
i loro corpi bianchi spezzati e ricomposti
in gesti nuovi, il mulinare lento delle gambe
come un’antica ripresa a passo-uno.
Oltre la curva del sentiero il profumo di eucalipto
consolava l’autore disilluso di turno,
e nella stanza/ufficio una mosca giocava esperta
con i miei ultimi brandelli di pazienza,
ronzando di sprezzo per la decadenza del detective
da stella dell’indagine a volo di falco
fra canyon e turrite magioni a orso sornione
d’albergo, procione rovistante nei rifiuti,
parassita ciondolante fra stanze e corridoi.
Basti questo, in sede di presentazione,
per dipingermi nello stato meno disposto
all’emozione: nulla, pensavo, sarebbe riuscito
a riscuotermi da una primavera in cui
per la prima volta mi sentivo stanco e vecchio.
II.
Ma a quanto pareva non avevo fatto bene i conti
con me stesso: dalla somma totale mi era sfuggito
qualche sparso fattore decimale, una frazione o due,
forse l’eccezione alla regola algebrica del sé:
il moto reattivo del capo nell’udire una frase,
lo scatto d’orgoglio del mento sollevato al ricordo
di quando mi trovavo nel punto più alto di Mulholland
e dominavo la distesa di liquide luci e cartongesso.
Nei conti, se mai li avevo fatti,
non avevo neppure inserito la variabile,
non ancora impazzita ma ben lanciata sui tornanti
del senno perduto, che la frase sarebbe uscita
dalle labbra di una rossa di miele d’acacia,
di cui il plantigrado è famosamente ghiotto;
e che le stesse labbra, pronunciata la richiesta d’aiuto,
si sarebbero atteggiate a calamita finché
non vi avessi apposto le mie di cavalier stanziale,
per infine staccarsi e intonare un numero di stanza.
Scordavo, seguendola come orso balcanico al guinzaglio,
che miele ai piedi di queste colline è sinonimo
di trappola più ancora che sulle alture inabitate.
Era infatti dei loro, la rossa viscosa di succori
e sguardo verde; ma non badai al segnale
universale di pericolo, scegliendo di correrlo
o meglio dalla corsa facendomi scegliere,
bendato da ciò che vedevo e da nient’altro
– e a loro finii per essere condotto.
III.
Se quello era il luogo in cui nascevano i sogni,
doveva essere perseguitato dall’insonnia:
nulla di più lontano da ciò che ti proietti
appena prima che lo spettacolo cominci,
di ciò che immagini prima ancora delle immagini.
Parola loro: “L’incarico che fa al caso suo”.
Parola mia silente: un’impresa impossibile
nella terra dove tutto è possibile – tranne forse,
visti i tempi, e i volti, e il linguaggio corporeo
dell’onnipotenza sconfitta, ciò che sembrava perduto
e che avrei dovuto per mandato ritrovare.
Storie smarrite, storie esaurite, storie arrese e spente:
il panico si era diffuso nella città di luci e lustrini
come fuoco acceso dal briccone dei venti,
ma senza fare terra bruciata, piazza pulita,
salutare distesa di ceneri da cui nasce il nuovo;
aveva seminato una calma piatta d’inazione
e abbandono, il lato opaco della dubbia moneta,
l’arroganza: si stendeva sui finti vicinati
degli studios come lustra macchia di grezzo
sull’oceano, tarpando di nero le ali di chiunque
tentasse un volo di scene, battute, dissolvenze.
Storie scomparse, prosciugate come gli agrumeti
di Pomona e Pasadena sacrificati all’inumana sete
della Signora degli Angeli: e yours truly,
pena un’improvvisa siccità di secondi e terzi atti,
avrebbe dovuto sguainare artigli e astuzie
e riportarle a chi le immaginava proprie,
badando bene a salvarne gli inizi, i finali
e già che c’era anche le soffici parti intermedie.
IV.
Avessi avuto capacità di divinare, la stessa
che sembrava disertare i numi degli uffici
dove l’aria si faceva rarefatta, mi sarei ritratto
fra le mura diroccate del Chateau, sollevando
il ponte levatoio di una scusa: sciatica, Tourette,
disturbo bipolare, avevo l’imbarazzo della scelta.
Per chissà quale atavico motivo non lo feci;
mi tenni i malanni che già sgomitavano
in cerca di primato e vi aggiunsi
la massima afflizione del detective,
il caso maledetto. E quando finalmente,
privo delle risposte pretese, presentai rapporto,
già sapevo che ne avrei risposto di persona
a un tratto non grata, e che come da copione
in questa città non avrei più lavorato.
Per i miei peccati ero incappato senza volerlo
nel vero, nel segreto nascosto nel pieno del sole
a occidente: se le storie non abitavano più qui,
non significava che fossero perdute:
stanche di ripetersi, prive ormai di voce,
si erano arrese e consegnate al vento, alle onde,
alle rocce, alle fughe da vertigini dei passi,
alle verginali aperture dei canyon;
non erano più qui ma tutt’attorno,
presenti a chiunque sapesse riconoscerle nel giorno.
I numi essendo numi, non reagirono da umani:
dalla cima del loro monte di acciaio e cristallo
mi bandirono con l’accusa di furto di fabula,
seguito dalla rossa sciolta in miele:
il miele che ora, erto su nuove zampe posteriori,
sono coartato a lappare senza tregua
– ormai storia anch’io fra tante, voce
fra voci che dicono a chi sente:
“Ascolta quello che ho da raccontare”.
____
Stefano Bortolussi, poeta, romanziere e traduttore, è nato a Milano nel 1959.
Ha pubblicato tre romanzi, Fuor d’acqua, (peQuod 2004), uscito prima ancora negli Stati Uniti con il titolo Head Above Water (City Lights Books 2003, traduzione di Anne Milano Appel), Fuoritempo (peQuod 2007) e Verso dove si va per questa strada (Fanucci 2013) e tre raccolte di poesie (fra cui Ipotesi di caldo, Book Editore 2001), la più recente delle quali è Califia (Jaca Book, 2015).
Il suo poemetto “Il moto ondoso del cercare” è stato incluso nell’antologia Bona Vox, curata da Roberto Mussapi (Jaca Book, 2010).
È co-autore di due serie di libri per ragazzi (Le indagini di Dick Rabbit e Le avventure di Miss Marmot, Dami Editore/Giunti).
