La poesia continua; non può non continuare: sembra che continuare sia il suo più essenziale e forte e profondo messaggio. Ogni qual volta che se ne senta più scorata la presenza, più perdute sembrino tutte le ragioni perché continui, ecco che, dalla crepa più arida dell’interruzione, sopraggiunge, all’istante, la poesia a dire di noi, a dire qualcosa che continua sottotraccia, che si credeva smarrito e obnubilato da infinite soglie di stupide deviazioni.
È con questa impressione sulle labbra che mi accingo a parlare di due giovani libri di due altrettanto giovani autori che emergono, negli ultimi mesi del 2015, con il loro esordio nel campo aperto della poesia italiana. Sto parlando di Vangelo Elementare (Raffaelli, Rimini 2015) di Gianluca Furnari (nato nel 1993) e di Adesso è tornare sempre (Le farfalle, Catania 2015) di Pietro Cagni (nato nel 1990): due libri completamente diversi eppure complementari, due libri che, pur nati entrambi alle pendici dell’Etna, sembrano aver percorso all’ombra di un diverso lutto fondativo distanze siderali, l’uno lontano dall’altro, per incontrarsi, infine insieme, in una pozza vibrante d’entusiasmo e presenza.
Vangelo Elementare è diviso in quattro sezioni diseguali, che costruiscono un preciso percorso allegorico all’interno di un universo arcaico e senza tempo, denso di suggestioni vichiane e antropologiche, in cui un’umanità primitiva – e non ancora «perduta», perché originaria – nasce alla consapevolezza di sé grazie al canto: «Ma con il canto inventavamo il tempo\ senza nemmeno crederci. Eravamo\ i sogni delle umanità future,\ i pionieri di un mondo appena apparso,\\ la prima generazione dei viventi» (p. 14). L’incontro sorgivo fra il linguaggio della poesia e la comunità umana è fulcro attorno al quale ruota il diorama del libro: il poeta si fa plurale e abbandona l’«io» per un «noi» e si rivolge continuamente, ansioso, verso un «tu» sfuggente, bruciante («eri un rogo, eri un coro, eri l’istante», p. 17), capace di offrire «il braccio\ tra gli eucalipti» e di insegnare «un senso del durare» (p. 15), mentre era impossibile non riconoscere che i suoi «occhi cantavano» mentre incideva «strane equazioni dentro il cuore» (p. 17). L’incontro fra questi uomini «mezzi vestiti e nudi» e il linguaggio della poesia, questa fusione fra metrica e coscienza, però, sottende una lotta, una lotta brutale per la sopravvivenza, allusa nella figurazione del libro da un mondo dove «il buio si addensava in forme ostili» (p. 21): «trascinavamo i nostri corpi chiari\ temendo che fuggissero all’alba» e molti di questi primi umani «cedevano quasi ad ogni radura\ distrutti dalla notte» (p. 19). Eppure l’uomo aveva trovato il canto, il canto come forma del proprio racconto di senso, arma più splendente di tutte: «Eravamo invincibili nel canto\ come rivolta noi dominavamo\ la forza formidabile dei nomi» (p. 19). Tutta la prima parte del libro è un inno a questo vibrante cammino anadromo verso un’umanità consapevole ed eroica perché conosce la virtù della propria finzione. Il libro di Furnari non è di certo un ingenuo o gratuito abbandonarsi ad un mero gusto primitivista; la riscoperta della «forza formidabile dei nomi» è infatti vissuta come gioia fintanto che può, oggi, fornire uno strumento con cui spingere l’animo dei contemporanei a plasmare le forze ostili della realtà: «Vale la pena rifare il cammino tra l’eco e il canto\ finché l’origine dell’eco ci innamora,\ se pure non c’è canto in fondo all’eco\ se il canto è quell’impervio resistere dell’aria» (p. 23). Da qui – forse – il titolo della prima sezione, Imperfetto ludico, in cui si accenna, da un lato, al percorso a ritroso nel passato, dall’altro al suo carattere finzionale, ludico appunto, illusorio, senza che però sia dimenticata la capacità antropoietica di ogni lusus.
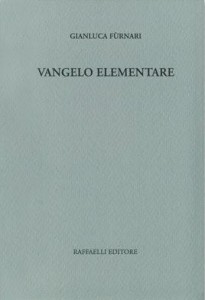 Nella seconda sezione, Quarta vigilia noctis, il libro incontra una svolta tematica. Senza abbandonare il soggetto plurale della prima e senza che il linguaggio fin qui appreso muti (e questa smisurata fiducia – sia detto per inciso – è forse l’unico segno della giovinezza di questo libro, straordinariamente maturo per composizione e capacità figurative), l’umanità incontra l’ineluttabilità della morte: «eravamo addestrati\ a ogni stagione, non a quell’estate\ freddata» (p. 29). Il destinatario qui si fa maschile: è un «padre», «dirotto, crepitante», a cui ogni umano non può che rinfacciare «tutte le poesie» solo per «allinearle, provarne la tenuta», mentre lo si incontra «in ogni camera della memoria» (ivi). Se la morte non stravolge il lessico del libro, né tramortisce la sintassi, focalizza però il centro motore dell’intera raccolta: il suo rapporto vitale con il passato, vissuto e attraversato come lascito etico, ovvero resurrezione visibile dentro le azioni umane che reincarnano l’eredità dei padri in rinnovate forme: «Ma intanto recitando lungo i ponti\ la tua falcata, padre, ma portando\ la tua paternità dentro ogni gesto,\ salderemo i tuoi amori- \\ quella sera\ te li restituiremo già vissuti» (p. 33).
Nella seconda sezione, Quarta vigilia noctis, il libro incontra una svolta tematica. Senza abbandonare il soggetto plurale della prima e senza che il linguaggio fin qui appreso muti (e questa smisurata fiducia – sia detto per inciso – è forse l’unico segno della giovinezza di questo libro, straordinariamente maturo per composizione e capacità figurative), l’umanità incontra l’ineluttabilità della morte: «eravamo addestrati\ a ogni stagione, non a quell’estate\ freddata» (p. 29). Il destinatario qui si fa maschile: è un «padre», «dirotto, crepitante», a cui ogni umano non può che rinfacciare «tutte le poesie» solo per «allinearle, provarne la tenuta», mentre lo si incontra «in ogni camera della memoria» (ivi). Se la morte non stravolge il lessico del libro, né tramortisce la sintassi, focalizza però il centro motore dell’intera raccolta: il suo rapporto vitale con il passato, vissuto e attraversato come lascito etico, ovvero resurrezione visibile dentro le azioni umane che reincarnano l’eredità dei padri in rinnovate forme: «Ma intanto recitando lungo i ponti\ la tua falcata, padre, ma portando\ la tua paternità dentro ogni gesto,\ salderemo i tuoi amori- \\ quella sera\ te li restituiremo già vissuti» (p. 33).
Le ultime due sezioni, Non bastavano i giorni e La parola non nuova, rinnovano lo slancio dell’intero libro che persegue la battaglia dei vivi armati del canto contro il buio, il buio più nero dell’inconoscibile: «Ma venne il buio, con le carovane\ e i reparti avanzati dei dormienti:\ allora, al primo grido,\ snudammo quelle voci, combattemmo» (p. 49). A tratti il buio prende le forme proteiche dell’acqua sulla quale una luce «appena umana» (p. 44) è forza elementare capace di sorprendere, di salvare, di distruggere, comunque di ammaliare l’umanità e di spingerla all’azione; azione che, in Furnari, è sempre occasione di rinnovato canto: «L’opera della luce sugli stagni\ erano segni, rime elementari:\ così al nostro comando si accendevano\ quando vi passavamo a torso nudo;\ era il linguaggio mai perfezionato\ che la notte tentava con sé stessa–\ come mani quei segni ci assalivano» (p. 45).
Nelle ultime pagine, Vangelo elementare trova alcune poesie fra le più intense di tutto il libro. Se nel suo stile vi sono indubitabilmente accenni epici ed eroici, la poesia che qui si propone è ben lungi dall’ambire ad un retrivo ideale di accecata potenza del linguaggio sulla realtà; sembra invece richiamarsi ad un’idea di poesia che, conscia di sé e della sua inevitabile natura di téchne, non rinunci alla possibilità di infiammare gli animi, di spronarli al confronto con la vita, travestita nel suo lato nascente e fertile, ambivalente, di certo non solo negativo: siamo lontani, ideologicamente, dal modello novecentesco che una parziale lettura della poesia Montale ha imposto e più prossimi invece all’afflato incendiario e metafisico di una certa poesia di Luzi. È come se Furnari sentisse che la nostra condizione di contemporanei ci ponesse in un aldilà della storia, un futuro preistorico che sembra più prossimo a noi di quanto il Novecento ci abbia saputo indicare; e che richieda, infine, una riscoperta postura della parola, arcaica e paradossalmente a venire, tecnica ma non fredda, che abbia del fossile e del meteorite insieme: «Occorreranno tecnici del canto\ quando ogni altro mestiere avrà fallito,\ profili certi, competenze liriche\ per rimettere a nuovo la sostanza»; e pochi versi più avanti: «[…] lasceremo\ il mondo dopo averlo fatto lucido;\\ ma fissando il collasso, congelando\ noi stessi dentro l’opera di luce» (p. 54).
Se questa la proposta ideale, la lingua di Furnari, tralasciato ogni vezzo sperimentale e facile caduta in una banale oscura introversione metaforica, sembra aver assorbito completamente il lessico poetico contemporaneo, lungo la linea della poesia lirica degli ultimi 40 anni, da Milo De Angelis e Giuseppe Conte fino ai più recenti episodi; una parola «che racconti tutto\ che semplifichi tutto», «molto simile al vento, ma più simile\ a sé stessa, in sé stessa confidente» (p. 55). Il paradosso di questo libro – limite e pregio insieme – sta tutto qui: annuncia la soglia di un mutamento, ma vivificando e infiammando la lingua della nostra attuale tradizione, gettandoci dunque in un ambiguo contropassato prossimo. Assisteremo con fiducia agli sviluppi di questa poesia, così forte e problematica fin da questo suo esordio.
 In tutt’altro clima ci immerge la lettura di Adesso è tornare sempre di Pietro Cagni. Fin dal titolo della prima sezione, Tu, che sei festa e terra, siamo gettati dentro un dialogo serrato fra un «io» e un «tu» di dichiarata memoria pavesiana (si veda soprattutto p. 16). Entro una sintassi scarna e franta, frammenti di un vissuto mai maiuscolo, ma minimo e feriale, si coagulano verso sintagmi di una densità straniante che nondimeno non possono non dichiarare la presenza dell’altro. «tu ci sei»: questo il primissimo verso della raccolta, cardine assoluto del libro, lento germe di un movimento che, vorticando sull’«io», porterà, nell’attesa della terza persona singolare e del «suo scoppio del cuore», alla scoperta degli «altri», ultima parola del libro, fine del movimento conoscitivo di questo intenso esordio.
In tutt’altro clima ci immerge la lettura di Adesso è tornare sempre di Pietro Cagni. Fin dal titolo della prima sezione, Tu, che sei festa e terra, siamo gettati dentro un dialogo serrato fra un «io» e un «tu» di dichiarata memoria pavesiana (si veda soprattutto p. 16). Entro una sintassi scarna e franta, frammenti di un vissuto mai maiuscolo, ma minimo e feriale, si coagulano verso sintagmi di una densità straniante che nondimeno non possono non dichiarare la presenza dell’altro. «tu ci sei»: questo il primissimo verso della raccolta, cardine assoluto del libro, lento germe di un movimento che, vorticando sull’«io», porterà, nell’attesa della terza persona singolare e del «suo scoppio del cuore», alla scoperta degli «altri», ultima parola del libro, fine del movimento conoscitivo di questo intenso esordio.
All’interno di questo cerchio pronominale, il libro di Cagni procede con il fiato trattenuto, con inarcature e controllati sbalzi sintattici, che insistono sulla seconda persona: «sei tu pallida e a\ brandelli» e, poco più avanti, «il tuo corpo è […] pozzo per bere a piene\ mani, buco che sei\\ t’abbandoni, lo lasci\ sul tuo sorridere infinito» (p. 13). Le persone grammaticali non sono fisse, ma sembrano oscillare, scambiarsi i ruoli, così come la topografia di questo libro che scorre dalla Sicilia a Milano, da Bologna all’Indiana, alla Slovenia per tornare sempre nello stesso luogo emotivo; e se nella prima e nella seconda sezione il «tu» ci appare «magrissima» (p. 21), «bellezza che ti spegni\ nei silenzi» (p. 15), corpo di giovane donna frammentato in mille dettagli, nella terza prende fattezze maschili: questa volta un «tu» che rimane «intatto perdono\ delle nostre deboli ciglia» (p. 35), un «tu» di cui si deve accogliere la «mancanza», mentre il suo «nome insperato» «sugli occhi continua\ a dilagare» (ibidem).
Al di là della circolarità pronominale, ciò che preme a questa poesia è di rimanere rasoterra, stretti alla «vita da niente» (p. 14) e al suo miracolo di persistenza e profondità creaturale (su questo aspetto, si veda la recensione di Pietro Russo qui: http://www.criticaletteraria.org/2015/12/pietro-cagni-adesso-e-tornare-sempre.html?m=1). Il mondo di Pietro Cagni appare percorso da una forza che spacca ogni essere, lo umilia, ma non cancella, anzi ne riafferma la «meraviglia» di fronte a questo «tu» che ci dice che siamo: «è lo stesso taglio degli occhi\ delle ragazze\ e della stazione centrale\\ ma altri pensieri, più piccoli\ spezzano la linea delle labbra\ le sillabe, il nome\ i tuoi capelli meravigliosi» (p. 19). È il mistero dell’essere individuale che spinge questa poesia a non cancellare il mondo; è l’impossibilità di comunicare nel linguaggio la potenza eccedente di chi è e di chi non è più che spinge al frammento, ad un’onirica scomposizione analitica del reale; se da un lato, lascia l’amaro in bocca, dall’altro non può che essere l’unico canale possibile per approssimarsi all’intera caratura di chi vive: «come io ho te davanti agli occhi\ a indicare il luogo, l’ora che è aspra\ la persona, la sua vena, la persona\ sorgiva, amara, sfondata, la persona, la persona» (p. 31). Altrove nel libro si giunge a dare istruzioni a quest’assenza, si chiede di coniugare la mancanza, di dargli fondamento e forma («queste strade non sono vuote\ avranno fondamento», p. 39), perché essa non è che un apparire altrove e in altro modo di quello stesso principio che con tanta certezza ha fatto esclamare il primo «tu ci sei». Sono pagine fra le più belle del libro: «questo freddo\ non è il tuo, a noi è preziosa figura\\ dagli casa, adesso, dimora» (p. 40); oppure «dopo sei mesi di te non rimane\ nemmeno il tuo scavarci in petto. Amore\ che sei silenzio e gomiti sullo stomaco\ scavi ora il tuo corpo, il morso degli occhi\ sei tu il tempo, sei tu l’ora che viene» (p. 42).
 Non è un caso allora che si affaccino, discrete, entro le pagine di questo libro, alcuni riferimenti alla fede cristiana. Dio (unica parola maiuscola in tutto il libro) appare come principio, vita vivente da cui non può che sorgere altra vita e dignità: «non mi ha creato la morte\ lo sai, il tuono della terra\ sarà per me la tua voce\ non so se è giorno, accesa\ la carne, Dio lascia ancora\ che mi guardi» (p. 27). È un Dio come presenza costante e ingiudicabile, sguardo oltre ogni sguardo umano possibile, sguardo trasumanante: «Se ti guardassi\ come ti guarda Dio\ moriresti di meraviglia» (p. 18). Dall’altro è fantasmatica fonte generatrice, che di fronte ai morti fa esclamare: «Signore, dona loro la tua larva quotidiana\ ma tienili, perché lasciano la presa\ o si stringono\ in quel momento nella tua» (p. 36). In altre poesie, emerge nella figura di un «cristo» minuscolo, corpo analogico il cui peso rappresenta il peso del dolore: «rimangono le caviglie\ nel tuo abbraccio\ i cavi della testa, dita sfatte\\ cristo pesa sessanta chili, o cinquantanove» (p. 30). Appare in rumeno, come esclamativo, «sul luogo dell’incidente», al culmine di un dolore: «dumnezeu, dumnezeu! sono lontane\ le mie viscere, come navi sul fondo» (p. 50). E infine appare al confine con la Slovenia, a Pesek, come sigillo dei sigilli, buio oltre ogni conoscenza: «io sono vostro\ come sono di Dio\ fondale oscuro dei rami e delle voci» (p. 51). Ma è forse nella forza di una poesia fra le ultime del libro, scalena e per questo densa e aperta e bellissima, che la figura di Dio emerge con più forza, proprio perché taciuta e resa energia trasformata in altro. Dopo «una preghiera» e un «pranzo\ con pane ingrommato», dopo aver ammesso la cecità di ogni sapere in una straniata balbuzia metrica («io non so\ niente, che cosa\ fa la vita tua e mia, che\ cosa potrebbe mancare»), appare «un poeta» che guarda dei bambini sull’altalena, ridendo, dopo averli fatti oscillare «fino quasi\ a stancare»; di lui, i versi scrivono: «ma più che questo\ li guardava, aveva\ l’universo addosso» (p. 55).
Non è un caso allora che si affaccino, discrete, entro le pagine di questo libro, alcuni riferimenti alla fede cristiana. Dio (unica parola maiuscola in tutto il libro) appare come principio, vita vivente da cui non può che sorgere altra vita e dignità: «non mi ha creato la morte\ lo sai, il tuono della terra\ sarà per me la tua voce\ non so se è giorno, accesa\ la carne, Dio lascia ancora\ che mi guardi» (p. 27). È un Dio come presenza costante e ingiudicabile, sguardo oltre ogni sguardo umano possibile, sguardo trasumanante: «Se ti guardassi\ come ti guarda Dio\ moriresti di meraviglia» (p. 18). Dall’altro è fantasmatica fonte generatrice, che di fronte ai morti fa esclamare: «Signore, dona loro la tua larva quotidiana\ ma tienili, perché lasciano la presa\ o si stringono\ in quel momento nella tua» (p. 36). In altre poesie, emerge nella figura di un «cristo» minuscolo, corpo analogico il cui peso rappresenta il peso del dolore: «rimangono le caviglie\ nel tuo abbraccio\ i cavi della testa, dita sfatte\\ cristo pesa sessanta chili, o cinquantanove» (p. 30). Appare in rumeno, come esclamativo, «sul luogo dell’incidente», al culmine di un dolore: «dumnezeu, dumnezeu! sono lontane\ le mie viscere, come navi sul fondo» (p. 50). E infine appare al confine con la Slovenia, a Pesek, come sigillo dei sigilli, buio oltre ogni conoscenza: «io sono vostro\ come sono di Dio\ fondale oscuro dei rami e delle voci» (p. 51). Ma è forse nella forza di una poesia fra le ultime del libro, scalena e per questo densa e aperta e bellissima, che la figura di Dio emerge con più forza, proprio perché taciuta e resa energia trasformata in altro. Dopo «una preghiera» e un «pranzo\ con pane ingrommato», dopo aver ammesso la cecità di ogni sapere in una straniata balbuzia metrica («io non so\ niente, che cosa\ fa la vita tua e mia, che\ cosa potrebbe mancare»), appare «un poeta» che guarda dei bambini sull’altalena, ridendo, dopo averli fatti oscillare «fino quasi\ a stancare»; di lui, i versi scrivono: «ma più che questo\ li guardava, aveva\ l’universo addosso» (p. 55).
Quando la poesia di Pietro Cagni osa di più, si sbilancia e rischia il fallimento, superando un certo candore, o meglio recuperandolo alla fine di un viaggio a perdere e a perdersi, lì si intravedono le possibilità di sviluppo di questa poesia a cui auguro di crescere in ampiezza, senza perdere in densità: il precipitare sbalordito dentro un mistero che intride già questo suo esordio.
____
Da: Vangelo elementare, di Gianluca Furnari, Raffaelli, Rimini, 2015
Anche i salici, certo, hanno una fede:
li trovavamo sulle conche d’acqua
col cuore rovesciato verso il sole.
Ci eravamo adunati: i lupi bianchi,
l’accolita dei puri: il nostro credo
era quel colloquiare tra noi stessi.
Ma con il canto inventavamo il tempo
senza nemmeno crederci. Eravamo
i sogni delle umanità future,
i pionieri di un mondo appena apparso,
la prima generazione di viventi.
*
Forse anche noi dichiareremo rotta,
padre, una sera, forse sentiremo
noi come te le viscere costrette.
Forse neppure noi lo capiremo
che quello è il passo falso, che è la falla
che dà su un’altra vita (o molto meno) –
ma intanto recitando lungo i ponti
la tua falcata, padre, ma portando
la tua paternità dentro ogni gesto,
salderemo i tuoi amori –
quella sera
te li restituiremo già vissuti.
*
Occorreranno tecnici del canto
quando ogni altro mestiere avrà fallito,
profili certi, competenze liriche
per rimettere a nuovo la sostanza –
così risponderemo noi all’annuncio,
ridaremo contegno ad ogni cosa
prima di seppellirla – neve, amori,
parole – lasceremo
il mondo dopo averlo fatto lucido;
ma fissando il collasso, congelando
noi stessi dentro l’opera di luce.
____
Gianluca Fùrnari è nato a Catania nel 1993 e abita a Santa Maria di Licodia. Laureato in Lettere con una tesi sulle “Rime d’amore” di Torquato Tasso, studia Filologia Classica all’Università di Catania. La sua raccolta d’esordio, “Vangelo elementare” (Raffaelli, 2015), è risultata finalista al Premio Rimini 2015. Suoi testi sono apparsi sull’antologia “Post 900 Lirici e narrativi” (Ladolfi, 2015) a cura di M. Fantuzzi e I. Leardini. È membro e collaboratore attivo del Centro di “Poesia Contemporanea” di Catania.
_____
Da: Adesso è tornare sempre, di Pietro Cagni, Le Farfalle, Catania, 2015
vita da niente
e una maglietta
di fiori, la più bella
ti tiene, uno
la mano, lo sa
che sotto non hai niente
gambe, cosce vuote
eppure
rimani, tu
come bel tempo
*
rimangono le caviglie
nel tuo abbraccio
i cavi della testa, dita sfatte
cristo pesa sessanta chili, o cinquantanove
quindi sei arrivata, accadi come
è accaduto l’ufficio, magra
inizi ad accadere
sulle ciglia lunghissime degli occhi
*
ho bologna addosso
ed è già troppo, ho detto
una preghiera e pranzo
con pane ingrommato
ho addosso
i ragazzini, che di sera
si nascondono l’un l’altro
tu non torni vero?
io non so
niente, che cosa
fa la vita tua e mia, che
cosa potrebbe mancare
un poeta faceva giocare
i bimbi all’altalena
saltare giù e toccare
il cielo coi piedini, e
rideva: bravi così
più difficile ora
o no, è facile
ancora, fino quasi
a stancare. ma più che questo
li guardava, aveva
l’universo addosso
___
Pietro Cagni (Palermo, 1990) vive e lavora a Catania, dove si è laureato in lettere classiche con una tesi sulla Commedia. Ha promosso le due edizioni di “Poesia inChiostro”, un progetto dell’associazione universitaria La Traccia in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche. In seguito ha fondato, insieme ad alcuni amici, il Centro di Poesia Contemporanea di Catania. Adesso è tornare sempre, Le farfalle, 2015, è la sua prima raccolta.

