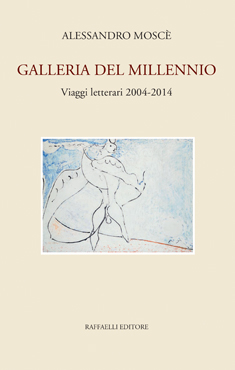Appena edito da Raffaelli Editore, Galleria del millennio raccoglie le riflessioni letterarie e le interviste che Alessandro Moscè (Ancona 1969) ha riservato alle opere di critici, poeti e narratori concentrate nel decennio 2004-2014, inedite o pubblicate su quotidiani come “Il Corriere Adriatico” e “Il Tempo” e su periodici come “L’Azione”, “Atelier”, “Poesia” e “Prospettiva”.
Proprio perché non programmatico, ma agito nel tempo, frutto di un lavoro quotidiano e corollario di una più ampia attività produttiva che ha visto Moscè attivo nel campo della narrativa e della poesia, oltre che su un lavoro critico orientato anche al progetto monografico e antologico, questo libro, aprendo una finestra sul mondo contemporaneo, ci svela anche un ritratto del suo autore, dei suoi temi privilegiati e di una poetica che orienta le varie forme del suo impegno. Lo sguardo di Moscè, lungi dal prefiggersi lo scopo inattuabile di catalogare tutto il pubblicato, non rimane neutro, ma naviga nel mare magnum approdando laddove incontra i temi preferiti, i libri degli interlocutori più stretti o quelli da loro amati e segnalati, gli autori su cui da sempre medita e quelli che invece ha conosciuto nel suo lavoro di giornalista e di operatore culturale. Non è un caso che, dopo aver intitolato Il viaggiatore residente (Cattedrale 2009) un suo saggio narrato, Moscè definisca “viaggi” questi interventi di critica il più possibile militante, che si muovono su più fronti di ricerca ma allo stesso tempo stanno, come il viaggiatore che risiede, dentro un confine metaforico d’indagine interiore, di costante tensione conoscitiva che punta al suo svolgersi più che alla meta. Come nel saggio narrato, anche in Galleria del millennio è facile incontrare un metodo d’indagine che Moscè ha fatto proprio, quello di una critica che chiede alla narrativa mezzi e strumenti per irrobustirsi e rinnovarsi. Lo stile che ne scaturisce, pur utilizzando i moduli delle annotazioni tecnico-letterarie, non rinuncia a narrare, ora a ri-narrare il libro che presenta e ora a raccontare l’individuo che lo ha scritto. A tratti impressionistico, il linguaggio della prosa critica di Moscè accompagna suggestioni alle osservazioni ed è mimetico laddove sembra che metabolizzi nel proprio sintagmi delle altrui scritture. Costante in ogni intervento, il capoverso unico fa pensare quasi a un bozzetto pittorico, che rinuncia volentieri ai nessi logici tipici dei testi argomentativi, per svolgersi in maniera più istintuale, come lasciando scorrere sulla pagina il derivato scritto di una coscienza critica che fluisce nel suo pensiero quotidiano.
Viaggiando tra i nomi e i testi recensiti, emergono temi e filoni che rappresentano i nuclei fondanti della poetica e del lavoro di Moscè. C’è innanzitutto, in più passi e fortemente ribadita, l’annunciata appartenenza a una linea letteraria che si distacca tanto dall’avanguardia quanto dalla fiction di matrice prettamente letteraria e che è quella che Carlo Bo definirebbe “letteratura e vita”. Cito Moscè: «La letteratura su cui indago da anni è la letteratura dell’esperienza, racchiusa in un caleidoscopio di soggetti, scenari, ambienti, di atmosfere, squarci e affreschi, in uno stile che metabolizza l’umano escludendo una prassi gergale, misurata a tavolino, di stampo sperimentale». L’aderenza al vero, infatti, scongiura anche un linguaggio astruso e processato dalla ragione, per abbandonarsi a ciò che di schietto e quotidiano sopravvive invece al gergo di un capitale che livella tutto. La crisi del mondo globalizzato, ancora, è parimenti sofferta e si svolge con particolare acutezza nelle riflessioni su Pasolini come specchio della crisi del mondo capitalistico. Per Pasolini, sottolinea più volte Moscè, la civiltà dei consumi è uno strumento fascista di potere e di consenso, che in linea generale produce una crisi di valori in ogni campo, ma che soprattutto, in senso più mirato, ha innescato la decadenza dell’editoria contemporanea, il suo impoverimento e la sua indifferenza verso la produzione più vitale degli autori non commerciabili. Su questa linea si colloca, in maniera consequenziale, anche una più ampia riflessione sul ruolo e sul valore della critica, spesa al fianco di altri operatori, interlocutori e amici, con la vera e propria moneta dello scambio. Ogni intervento che recensisce il lavoro dei critici colleghi, infatti, è chiaramente problematico e sottende la domanda che la critica rivolge a se stessa: è ancora possibile in un mondo di scritture globalizzate e mercificate un mestiere del genere? La risposta si annida in più luoghi: nella duttilità di Franco Cordelli; nell’allarme lanciato da Franco Brevini di una critica che rischia di lasciare il posto alla cronaca dei libri e al gossip; nella creatività di Paolo Lagazzi che scrive su Bertolucci un saggio vivo come una confessione fatta a un amico; nella fedeltà di Massimo Onofri a certi argomenti, trattati senza la presunzione di un cesello definitivo ma con la serietà dell’impegno e della scelta; nella provocatoria applicazione di Massimo Raffaeli a una moltitudine di testi e linguaggi con il lascito di frammenti e descrizioni partecipi; nello sforzo di professori come Alberto Bertoni per rinnovare una metodologia troppo a lungo seduta su cattedre inaccessibili; o nelle intuizioni intelligenti di Filippo La Porta capaci di cambiare la lettura del reale.
Il gusto di questi “interventi partecipi” non è solo personale. Non rinuncia al meglio delle scritture altre, infatti, magari più distanti dalle poetiche private, in specie quelle dei padani, da Celati a Tondelli, da Guido Conti a Cornia, da Cavazzoni a Davide Barilli, passando per Tonino Guerra. E tiene d’occhio i romani, tra cui Edoardo Albinati ed Emanuele Trevi, non rinunciando nemmeno a uno sguardo europeo. Tuttavia dà la sua preferenza certamente al filone autobiografico, in specie per la poesia sulla linea di quella “onesta”, usando la definizione di Saba, alla ricerca di valori totali sopra il contingente, rinvenuti prima di tutto nelle scritture dei simili e vicini: i marchigiani. Quest’ultimi, baluardi di una regione intatta, «una terra al plurale che […] conserva una natura e una dimensione contemplativa», eredi di un leopardiano interrogativo “esistenzialismo”, che si annida in piccole vite dense di grandi sogni, sono gli autori presentati con maggiore partecipazione: Luigi Bartolini l’anticonformista; Paolo Volponi lo scrittore della residenzialità; Angelo Ferracuti il promotore dell’obiettività; Umberto Piersanti il poeta della memoria; Remo Pagnanelli il testimone di un dolore dignitoso; Francesco Scarabicchi il cantore della domesticità; e, tra tutti, Franco Scataglini, riflesso dell’amata Ancona che pure gli fu ingrata, il modello dal profondissimo afflato esistenziale. Questa predilezione regionalista, lungi dall’essere banale campanilismo (difficile concetto tra l’altro in una regione plurale e introversa come le Marche) è la strenua convinzione con cui Moscè, residente da sempre a Fabriano, rivendica un’appartenenza, che è insieme dichiarazione di poetica e tensione umana e intellettuale verso un desiderio: poter attribuirsi dei maestri. Questi, ancora più necessari osservando un paese che non sa più trarre nutrimento da quei pochi che potrebbero dirsi tali, non si esauriscono nei testi. Si tratta di intellettuali con cui Moscè intrattiene un rapporto prediletto, maestri non solo letti e meditati, ma incontrati e vissuti, come Alberto Bevilacqua e Umberto Piersanti. In specie nell’ultima sezione del libro, questa intuizione della condivisione, della testimonianza diretta, si fa costante e Moscè, che da sempre cerca l’uomo dietro lo scrittore, ci suggerisce il valore di frequentarlo uno scrittore, laddove è possibile, di interrogarlo di persona, di camminare con lui nei suoi luoghi di elezione come fa con Piersanti, o di trattenerlo tra i propri affetti veri. Scrive di Bevilacqua: «Eravamo amici, ci sentivamo spesso, lo avevo invitato a Fabriano in più occasioni, andavo a trovarlo a Roma». La lezione di Marc Augé: laddove il mondo sgarbato disperde, atomizza, divide, è necessario recuperare quegli spazi della quotidianità dove è consuetudine ritrovarsi.