 La Fondazione Il fiore ha pubblicato nel 2016 “Nella punta là in alto dei Climiti”, studi su Elena Salibra con Nove poesie inedite.
La Fondazione Il fiore ha pubblicato nel 2016 “Nella punta là in alto dei Climiti”, studi su Elena Salibra con Nove poesie inedite.
La poetessa e il critico: la poesia nel suo farsi
di Marco Santagata
Come molti dei presenti in questa sala ho avuto il privilegio di godere dell’amicizia di Elena Salibra. Una amicizia vera, di quelle confidenti e profonde. Credo però di essere, se non il solo, uno dei pochi ad avere avuto il privilegio di intrecciare un dialogo, non è eccessivo dire quotidiano, con Elena poeta. Non posso dire di aver visto nascere un poeta, ma di aver seguito passo passo la sua maturazione, fino alla conquista di una cifra espressiva originale, questo lo posso dire. Non ho visto nascere Elena poeta perché il mio rapporto con la sua poesia è cominciato con la pubblicazione della sua prima raccolta, Vers.es, nel 2004, mentre la sua produzione lirica è cominciata molto prima. Elena non era una dilettante: prima di dare alle stampe i suoi versi aveva attraversato un lungo tirocinio, in silenzio, o quasi. Quasi, perché di recente Enzo (n.d.r. il marito di Elena Salibra) mi ha fatto dono di una plaquette di poesie pubblicata nel lontano 1988 e nel donarmela mi ha detto che Elena si era raccomandata di non farmi sapere niente di quell’opuscolo. In effetti, mai Elena mi aveva accennato a questa o a altre pubblicazioni. Una lezione di serietà che dice molto su quanto fosse forte in lei la vocazione poetica e quanto acuta la consapevolezza di come la parola genuina possa scaturire solo da un lungo percorso di ricerca. Quella di Elena è una lezione particolarmente preziosa oggi, un’epoca nella quale i poeti dilettanti sono migliaia. Un’epoca nella quale tantissimi sono convinti che basti esprimere le proprie sensazioni, i propri sentimenti, le proprie considerazioni su sé stessi e sul mondo in una forma che arieggia quelle poetiche per potersi definire poeti e pochi, al contrario, sono consapevoli di quanto studio e di quanto esercizio richieda la scrittura poetica, che di tutte è la più ardua.
Dal 2004 il dialogo con Elena è stato pressoché quotidiano. Il dialogo era tra autore e lettore. In concreto: Elena mi mandava le stesure delle sue poesie chiedendomi un parere; io rispondevo con osservazioni puntuali. In sostanza dicevo ciò che mi piaceva, ma, soprattutto, ciò che non mi convinceva. Poi ne parlavano a quattr’occhi. Mai abbiamo mescolato il dialogo sulle poesie con discorsi sul nostro comune lavoro di docenti universitari: quel terreno non tollerava intrusioni. Di ogni componimento le stesure erano molte. La mia era una pedagogia di tipo maieutico: mai mi sono permesso di dare un suggerimento. Dicevo ciò che a mio parere non andava ed Elena, se era d’accordo nel ritenere che effettivamente non andasse, trovava un’altra soluzione. A volte ci voleva molto tempo per arrivare a una forma accettata, ma sempre ci arrivava da sola. Ogni volta restavo ammirato della sua capacità inventiva. Aveva un dono della lingua inarrivabile, e alla lingua professava un culto quasi sacrale. Pedagogia maieutica, la mia, ma non accondiscendente. Siccome prendevamo entrambi molto sul serio quel discutere su immagini, ritmi e parole, le mie osservazioni potevano essere aspre. Chi avesse assistito ai nostri dialoghi forse si sarebbe stupito, si sarebbe chiesto che razza di rapporto fosse il nostro. Avrebbe dovuto capire che in quei momenti il rapporto non era fra lei e me, era fra me e un testo. La libertà di giudizio, non frenata da considerazioni affettive o anche solo di buona educazione, era assolutamente indispensabile per non tradire la serietà di quel lavoro. Mai Elena ha protestato di fronte alle mie critiche, a volte ai miei sarcasmi: non protestava perché si annullava nello scritto. Lei pure esercitava pienamente il suo giudizio come se parlasse del testo di un altro.
Vi farò un paio di esempi per farvi capire meglio come si svolgeva la nostra collaborazione. Li prendo dalla penultima raccolta di Elena, La svista, del 2011, una raccolta che segna una svolta nella sua produzione e che, a mio avviso, la consacra come poetessa riuscita.
Il penultimo testo, che dà il nome alla raccolta, nella prima versione era molto più lungo. Io lo criticai molto, e proprio per questo ricordo che il mio giudizio fu assai negativo quando mi sottopose una seconda redazione che ricalcava sostanzialmente la prima.
Eccola:
– non hai visto la rima in fondo alla poesia
ti sei fermato prima
– non hai visto la svolta al crocevia
hai continuato dritto – strade su strade
poi un po’ a sinistra fino al muro
della casa accanto
– non hai visto il birillo in mezzo alla via
ci sei andato contro guardandomi
in tralice
imbocca altrove la scorciatoia laterale
lì dove il dolore c’è
ma non si vede [sei in un intrigo
di parentesi di punti di lineette
di corsivi]
– in mezzo al calendario non hai visto
quella domenica di fine luglio
con la nota in calce.
che quel giorno non era possibile
prendere l’appuntamento l’hai
saputo dopo … alle domande
non hai risposto. solo uno stupore
improvviso e un percorso frettoloso
tra portoni e finestre. ora l’inverno
ti riporta indietro. riparti dall’inizio
cominciando dalla casa
da un quadro all’altro
dalla sala alla cucina
da porta a porta
stai attento ai dettagli
fai un paragone con lo spazio
e il tempo in generale.
hai voglia di contare i minuti
e i centimetri di troppo. rimettiti
in cammino … nell’ora che la tua
fuga si colora di me.
Le dissi, all’incirca: “decidi, vuoi scrivere una poesia o un racconto? I materiali che ho letto li puoi sviluppare in poesia o amplificare in racconto, ma siccome tu sei una poetessa, fanne una poesia”. Due giorni dopo mi presentò una seconda versione, asciugata, quasi della stessa misura di quella a stampa (24 versi contro i 35 delle prime due redazioni) e a quella a stampa quasi identica:
– non hai visto la rima in fondo alla poesia
ti sei fermato prima
– non hai visto la svolta al crocevia
hai continuato dritto –
poi un po’ a sinistra fino al muro
della casa accanto
– non hai visto il birillo in mezzo alla via
ci sei andato contro
imbocca altrove la scorciatoia lì
dove il dolore c’è
ma non si vede
– in mezzo al calendario non hai visto
quella domenica di fine luglio
con la nota in calce.
che quel giorno non era possibile
prendere l’appuntamento l’hai
saputo dopo … alle domande
non hai risposto. solo uno stupore
improvviso e un percorso frettoloso
tra portoni e finestre. ora l’inverno
ti riporta indietro. riparti dall’inizio
contando i minuti
e i centimetri di troppo. rimettiti
in cammino … nell’ora che la tua
fuga si colora di me
Il salto di qualità è impressionante. Tuttavia non mi convinceva ancora il finale. Devo dire, in generale, che sulle chiuse la nostra polemica era continua. Elena aveva un dono straordinario per gli attacchi, ma poi era come se la sua energia si indebolisse con il procedere, e alla fine, per chiudere, cercasse una soluzione ‘facile’, tra virgolette. “Nell’ora che la tua / fuga si colora di me” era una soluzione facile. Sapeva di poesia, e la vera poesia deve sapere di verità. Sapeva di poesia perché in realtà era senza un vero significato, e la vera poesia deve attribuire significato a ogni minimo elemento testuale. Dopo molto discutere, Elena si persuase. Pochi giorni dopo mi presentò il nuovo finale. La soluzione escogitata era di una facilità disarmante, e per questo tanto più bella: aveva semplicemente cassato gli ultimi due versi.
Molto abbiamo discusso anche sul finale dei campi elisi, l’ultima poesia della racconta. Questo testo ha avuto una gestazione lunga e tormentata, passata attraverso una decina almeno di redazioni. Nella penultima gli ultimi versi recitavano così:
muoviti che fai…- sbarrato dai massi
dell’altura ormai senza respiro
mi raggiungi. tutto è
come prima –lo so- rotoliamo
inciampando sui sassi del ghiaione.
resisti disfatto al mio incalzare …
ti ritrovo nei giorni della merla …
che risorgi e ti sciogli al tepore
d’una primavera un poco
anticipata …
Fra le varie cose, in modo ruvido e sicuramente sarcastico le dissi che “al tepore di una primavera un poco anticipata” avrebbero potuto sciogliersi Liala o qualche altra scrittrice di romanzi rosa, ma non Elena Salibra. Nella versione a stampa quel finale è scomparso:
muoviti che fai … – impedito dai massi
dell’altura ormai senza respiro
mi raggiungi. tutto è
come prima –lo so- rotoliamo
inciampando sui sassi del ghiaione.
tu esanime resisti al mio incalzare …
Ed è pure scomparso, sostituito da “esanime”, l’aggettivo disfatto, che Elena sentiva come dantesco, ma che aveva il difetto di dare troppo corpo, troppa presenza al soggetto a cui è rivolto il discorso a danno del parlante.
Ecco, i nostri dialoghi si svolgevano grosso modo così. Grazie a loro ho avuto il privilegio di assistere non alla nascita di un poeta, ma a come un poeta che già si era presentato in pubblico con una produzione di valore abbia, in poco tempo, bruciato le tappe e attinto un livello di assoluta eccellenza. Non posso qui delineare un percorso della poesia di Elena. Mi fermerò solamente su due aspetti.
Nella prima raccolta, Vers.es, e, in parte, anche nella seconda, Sulla via di Genoard, Elena sperimentava un linguaggio complesso, fatto di tecnicismi, di termini matematico-scientifici, di vere proprie formule matematiche e di molte citazioni. In più ricorreva a una sintassi contratta, lasciando che il discorso fluisse e nello stesso tempo di rattrappisse in parentesi, spazi bianchi, a capo, versi scalati. Una ricerca originale che però, al fondo, denunciava una sorta di pudore o, per dire meglio, di paura: la paura di mostrarsi. Vincere la vergogna è la cosa più difficile per chi scrive. La letterarietà era anche uno schermo, il modo di dire suggestivo, affidato all’analogia, consentiva di evitare la dizione diretta, di denudarsi. Con la svista il suo stile cambia. Il dettato si fa più comunicativo, la sintassi più distesa, l’istanza a raccontare più forte. E’ l’approdo a una più vera autenticità. Il soggetto si mostra, e mette in mostra un io ammalato. La malattia, paradossalmente, è l’evento che spinge Elena a mettere da parte gli schermi e a parlare di sé. Parla di sé, della sua malattia, del futuro negato, ma chi legge sente che sta parlando del grande mistero della vita e della morte, del destino di tutti noi. I vertici sono attinti quando il discorso autobiografico è totalmente oggettivato in un discorso che parla di altro; il massimo di autenticità corrisponde così al massimo di straniamento. Una delle sue poesie più belle, che non a caso apre l’ultima delle raccolte poetiche, Nordiche, racconta di un crostaceo, una cicala, prima messa ancora viva in frigorifero e poi uccisa nell’acqua bollente e condita con una salsa rossa di pomodoro: una ricetta, nient’altro che una ricetta, ma una ricetta crudele:
dentro il cartoccio si avvoltolava
la cicala muovendo le antenne.
la chiusi in frigo nello scaffale
in alto. con un salto cercò spazio
altrove. la ritrovai la mattina
accanto alla pentola di coccio
con i fagioli a mollo ancora viva.
di morire non era capace.
per un’agonia veloce – consigliava
l’artusi – è meglio usare olio bollente
un battuto d’aglio prezzemolo quanto
basta. contorse la cicala il guscio
a scaglie si crogiolò nel calore
ma rimase indenne.
quando sopravvenne il sugo rosso
sangue allora gli riuscì d’annegare
e mi lasciò sola col cucchiaio stretto
nella mano …
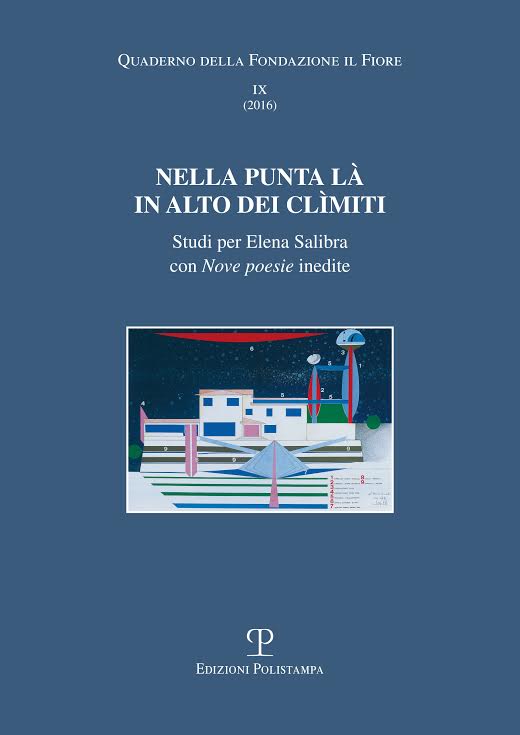 A uccidere è il soggetto parlante, un soggetto che possiamo identificare con Elena stessa, ma è chiara la sensazione che la morte della cicala prefiguri proprio quella di chi sta parlando. Niente, tuttavia, rimanda alla malattia, nessun segnale linguistico la evoca. Chiunque legga questa poesia, anche senza niente sapere dell’autrice, ignorando del tutto che essa era gravemente ammalata quando l’ha scritta, non potrà fare a meno di percepire che nella morte di quella cicala si rispecchia il destino degli uomini. Parlando di sé Elena parla di tutti, la poesia stessa non è più sua, è nostra, un pezzo della nostra esperienza.
A uccidere è il soggetto parlante, un soggetto che possiamo identificare con Elena stessa, ma è chiara la sensazione che la morte della cicala prefiguri proprio quella di chi sta parlando. Niente, tuttavia, rimanda alla malattia, nessun segnale linguistico la evoca. Chiunque legga questa poesia, anche senza niente sapere dell’autrice, ignorando del tutto che essa era gravemente ammalata quando l’ha scritta, non potrà fare a meno di percepire che nella morte di quella cicala si rispecchia il destino degli uomini. Parlando di sé Elena parla di tutti, la poesia stessa non è più sua, è nostra, un pezzo della nostra esperienza.
La malattia ci ha tolto una carissima amica, ma ci ha lasciato una poetessa che con i suoi versi resta con noi e resterà con chi verrà dopo di noi.
Nota a margine. Il testo, contenuto nel volume, è stato pronunciato da Marco Santagata a Siracusa il 25 marzo 2015.
Premessa di Maria Giuseppina Caramella
PARTE I – POESIA E CRITICA
Stefano Carrai, I due tavoli – Marco Santagata, La poetessa e il critico: la poesia nel suo farsi – Ernestina Pellegrini, Ritratto in due tempi – Cristina Cabani, Le diverse scrivanie: studiosa, docente e poeta – Anna Chella, «Era uno sfizio il mio non far tornare / mai i calcoli…»: il gioco dei numeri – Mara Boccaccio, Nella casa rosa: alcune soglie liriche – Valentina Fiume, «Una ridda di parole dipinte» – Enrico Tatasciore, Una poesia in movimento: Il martirio di Ortigia e oltre – Damiano Moscatelli, Tempo dell’io e tempo in fuga ne La svista – Diego Salvadori, Le prospettive intrecciate: spazi, corpi e presenze ne La svista – Silvia Morotti, «Sul fondo della barca»: da La svista a Nordiche – Enrico Testa, Verso Nord – Emma Di Rao, L’io di Nordiche: né Ulisse né Tiresia – Mario Graziano Parri, Perché non scrivi versi? – Emilio Rentocchini, Divagazioni in margine a Nordiche – Luigia Sorrentino, Sulla poesia di Elena Salibra – Mario Gerolamo Mossa, «Sono io qui a guardare dall’alto l’aula spoglia» – Giuseppe Nava, Elena Salibra interprete di Pascoli.
PARTE II – NOVE POESIE
Vincenzo Manca, Breve nota su Nove poesie – Elena Salibra, Non desiderare la lingua d’altri
PARTE III – RICORDI E TRADUZIONI
Franco Mosca, In ricordo di Elena Salibra – Davide Caramella, Il mio rapporto con Elena – Luciana Salibra, I luoghi di Elena – Giacomo De Nuccio, La fiducia aiuta a crescere – Anna Barsotti, La passione e il gioco – Massimo Bacigalupo, Leggendo Stevens con Elena Salibra – Tre poesie di Elena in Thai tradotte da Giulio Pavesi e Kemika Tanpudsa
