
di Tommaso Di Dio
L’ultimo libro di Milo De Angelis, Incontri e agguati (Mondadori, 2015) ci costringe nuovamente a fare i conti con uno degli autori che più hanno influenzato la scrittura e l’idea stessa della poesia negli ultimi 40 anni di letteratura italiana. Ogni autore che oggi intenda scrivere, sia in prosa che in versi, non può non essersi misurato e finanche scontrato con il suo paradigma. Ogni sua singola poesia che giunga ai nostri sguardi finisce ormai per apparirci epifenomeno di una medesima matrice: una fibra che si è incistata nella sintassi di fine Novecento e ha cominciato a vibrare, fino a raggiungere un calor bianco che continua a emanare una radiazione peculiare e ossessiva, continua, assillante. A conti fatti, non c’è mai un nuovo libro di De Angelis; ogni libro ripropone sempre il medesimo appuntamento, il medesimo strappo, giunge all’ultimo: mostra una fase, la frazione di un’onda straordinariamente coesa, che procede costante da Somiglianze ad oggi. A questo stadio (come fu per Zanzotto), ogni singolo verso termina e trova eco nell’Opera, in quel triangolo buio e ribollente, tutt’altro dall’inerte monumento, quel pozzo di continui attingimenti che, come un infinito intensivo, testimonia di una ferita aperta fra noi e la vita, fra noi e la scrittura.
Fin dal titolo, il libro di De Angelis ci chiama ad intendere la poesia secondo le categorie della relazione e della violenza. A me pare che bisogni leggere le due parole scelte come titolo più come una dittologia che come una coppia di termini fra loro giustapposti: l’uno è l’intensità dell’altro, l’uno descrive e rivela l’altro. Il libro Incontri e agguati racconta per via di scorci – eppure mai così congiunti narrativamente – il rapporto di somiglianza violenta che siamo chiamati a conoscere quando entriamo nel regno della scrittura poetica. Per De Angelis, la poesia non è tiepido calcolo linguistico, neppure astratta e nemmeno organica ricerca di un piano di dialogo fra noi e quel nido di serpi a cui siamo soliti dare il nome di realtà; dentro il suo dettato tutto appare rigoroso, decisivo: scollamento e poi sbalordito contatto – ovvero: iato – fra ciò che vive e quelle forze oscure che animano ciò che vive. C’è nella sua scrittura l’insistere di una pressione; si può percepire, ad ogni verso; insiste una forza, larga e fulminea, che da dentro preme ogni cosa che appare del mondo e giunge a toccare l’epidermide di chi ha perso, una volta per tutte, il nome di Dio: «Vicino alla morte tutto è presente/ non c’è infanzia né paradiso/ tu cadi in un urlo segreto/ e non parli/ cerchi un arcano/ e trovi solo materia, materia/ che non trema e ti guarda impassibile/ e avvicina muta i due estremi» (p. 25). La prima parte del libro può lasciare interdetto il lettore, per la costruzione narrativa, per le cadenze morbide, inusuali nella poesia di De Angelis; soltanto ad un’ennesima lettura, se ne coglie il valore iniziatico, di percorso di spoliazione e approssimamento. Infine sorge una grande inquietudine quando ci si ritrova al cospetto di versi che ti costringono, con tale ingannevole seduzione, alla vicinanza di quel limite estremo che in Occidente chiamiamo morte. Dice la scrittura: «Vieni, amico mio, ti faccio vedere,/ ti racconto» (p. 9); più avanti incalza: «[…] Ascolta,/ vienimi vicino» (p. 23); il tutto per porre più prossimi all’oscena parola, al canto muto e scabro che, nell’orecchio dell’uomo «invaso della domande» e posto al bordo di se stesso, terribilmente intima: «Sarai una sillaba senza luce» (p. 17), «formerai a poco a poco la parola niente» (p. 18).
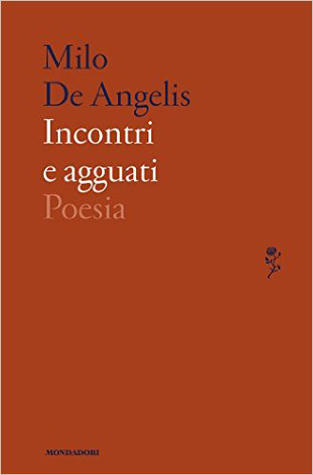 Una volta attraversata la landa della prima sezione e scoperto il naufragio della vita umana, si è accolti in un’area di incontri col mondo. E il mondo nella poesia di De Angelis si configura sempre come una serie discontinua di rapporti ultimativi, una relazione fra esseri in cui l’uno è specchio dell’altro e il cui riflesso scoccato è l’intensa coscienza che si è stati, in un attimo, nel luogo d’abolizione d’ogni tempo, prossimi all’agnizione di essere parte di una ciclicità inesausta. Nella seconda sezione, ad ogni verso, siamo posti di fronte ad un fantasma, apparizione fosforescente – non si sa se ombra di vivo o di morto – capace di rendere conto del limite e dello iato. Il primo è l’incontro con la carne della propria carne, quel figlio (o quel se stesso come figlio: poco importa) che diventa, in una delle poesie più compiute mai scritte da De Angelis, ennesimo frammento abbandonato al mondo, ennesimo buio a cui non si sa dare riparo né consolazione, ma solo costatarne lo stigma: il «vuoto mai estinto nella fronte». Il viaggio attraverso le apparizioni, memore di un topos che trova da Dante a Gozzano e Sereni strepitosi interpreti, si rivela densissimo, capace di ripercorrere, attraverso le tappe dell’uomo, le tappe del poeta, in una fusione così postuma da indicare la via ai futuri interpreti. Ritroviamo la donna che lotta «sul prato con i maschi/ in una giovinezza di soli istanti», come quella dal «viso/ sbagliato» che si apriva «le vene/ tra un grammo e un altro grammo»; oppure, in un altro più terribile agguato, ci viene di fronte Mario, «sdraiato tra i macchinari del respiro», inerme e «sbarrato dalle labbra»: «verità che ha perso il cammino/ nel rettangolo scosceso di una piastrella» (p. 35). Ognuno di queste figure racconta e rispecchia la grande ossessione, l’inconsolabile, disperatamente cercata e rincorsa nel delirio di corsie e moscerini, scacciata dalla Polfer e infine abbracciata per un attimo nello spasmo della fendimetrazina: «Ti ritrovo alla stazione di Greco/ magro come un rasoio e ulcerato da un chiodo/ che tu chiamavi poesia poesia poesia» (p. 43). La poesia di Milo De Angelis sembra così ritrarre se stessa: chiodo che scava nello stesso punto, da anni, e preme, con un dolore che sa farsi metrica, nitore crescente.
Una volta attraversata la landa della prima sezione e scoperto il naufragio della vita umana, si è accolti in un’area di incontri col mondo. E il mondo nella poesia di De Angelis si configura sempre come una serie discontinua di rapporti ultimativi, una relazione fra esseri in cui l’uno è specchio dell’altro e il cui riflesso scoccato è l’intensa coscienza che si è stati, in un attimo, nel luogo d’abolizione d’ogni tempo, prossimi all’agnizione di essere parte di una ciclicità inesausta. Nella seconda sezione, ad ogni verso, siamo posti di fronte ad un fantasma, apparizione fosforescente – non si sa se ombra di vivo o di morto – capace di rendere conto del limite e dello iato. Il primo è l’incontro con la carne della propria carne, quel figlio (o quel se stesso come figlio: poco importa) che diventa, in una delle poesie più compiute mai scritte da De Angelis, ennesimo frammento abbandonato al mondo, ennesimo buio a cui non si sa dare riparo né consolazione, ma solo costatarne lo stigma: il «vuoto mai estinto nella fronte». Il viaggio attraverso le apparizioni, memore di un topos che trova da Dante a Gozzano e Sereni strepitosi interpreti, si rivela densissimo, capace di ripercorrere, attraverso le tappe dell’uomo, le tappe del poeta, in una fusione così postuma da indicare la via ai futuri interpreti. Ritroviamo la donna che lotta «sul prato con i maschi/ in una giovinezza di soli istanti», come quella dal «viso/ sbagliato» che si apriva «le vene/ tra un grammo e un altro grammo»; oppure, in un altro più terribile agguato, ci viene di fronte Mario, «sdraiato tra i macchinari del respiro», inerme e «sbarrato dalle labbra»: «verità che ha perso il cammino/ nel rettangolo scosceso di una piastrella» (p. 35). Ognuno di queste figure racconta e rispecchia la grande ossessione, l’inconsolabile, disperatamente cercata e rincorsa nel delirio di corsie e moscerini, scacciata dalla Polfer e infine abbracciata per un attimo nello spasmo della fendimetrazina: «Ti ritrovo alla stazione di Greco/ magro come un rasoio e ulcerato da un chiodo/ che tu chiamavi poesia poesia poesia» (p. 43). La poesia di Milo De Angelis sembra così ritrarre se stessa: chiodo che scava nello stesso punto, da anni, e preme, con un dolore che sa farsi metrica, nitore crescente.
L’ultima sezione di questo breve ed essenziale libro, si intitola Alta sorveglianza e ci conduce nel cuore del carcere. Strutturato come un poemetto in XXIV frammenti più una fluida coda di 4 strofe, essa ancora ci porta direttamente al centro dell’ossessione di una vita. Dopo un itinerario nei ventricoli architettonici e morali del carcere di Opera, incontriamo un uomo e la sua voce, imprigionati per aver ucciso la donna che amavano e che ora è fatta onirismo della mente soggiogata dalla colpa: «Era l’aggravarsi/ di ogni atto nel buio di se stesso». In questo cronotopo, la scrittura di De Angelis si rispecchia e si dichiara ancora più precisamente, fino a confondere il luogo reale con lo spazio simbolico, l’Opera di una vita di poeta con la struttura carceraria di Opera: «Opera sei dappertutto e non so dove sei». Torna in queste pagine l’ombra e la voce di Clorinda uccisa da Tancredi e torna l’ossessione crudele ed estatica che fece scrivere a Francesco Petrarca i contorni della sua prigione nel metro aureo e invincibile del sorriso di Laura. Al centro cavo della retina, al punto morto della visione, c’è, infatti, una donna senza nome né fisionomia, radiante metaforico, indicata con il molteplice uso icastico del participio passato: ecco il «diadema del sangue/ codice lunare nelle guglie della sera», la «donna sterminata», «l’ultimata». Come un Orfeo imprigionato, amante di un amore reso infinito perché colpevole, la voce del carcerato ci parla e descrive nelle fattezze di una donna uccisa e morta il miracolo grande e oscuro dell’esperienza della letteratura; sono versi straordinari: «Campane mute e capovolte/ ora circondano il corpo/ intorno al collo un filo di perline/ aveva l’ansia di una daina/ aveva intuito e provò a fuggire/ ma il piede in corsa mosse una valanga/ e iniziò il minuto esteso/ della morte» (p. 62). Ogni poesia in Milo De Angelis trattiene quel brivido omicida di una giovinezza stroncata nella fuga, quell’odore animale e sacro di una caccia mortale; esso ci ricorda come il testo, ogni testo di poesia, non sia altro che scalpo della vita: in ogni nome essa ricerca il glorioso trofeo che si propone di vincere la morte e, al contempo, ecco che proprio ogni nome non è altro che colpevole fantasia della mente, «un annuncio oscuro di linee», «un’esecuzione» della realtà dell’esperienza.

Milo De Angelis, Credits Ph. Viviana Nicodemo
Urge infine domandarsi perché la poesia di De Angelis è stata ed è così fondamentale per chiunque oggi intenda scrivere in versi. Ci sono diverse ottime scritture nel panorama letterario, eppure nessuna sembra così rappresentativa, emblematica, fertile come questa. Come un enigma la cui verità è il suo stesso porsi in forma di domanda, la poesia di questo autore rappresenta per molti dei poeti di oggi, ormai, l’unico sprone a continuare la ricerca di una lingua e di una forma che sia all’altezza della tragedia del vivere, a non recedere, a non credere che la percezione della vita sia tanto assuefatta da aver dimenticato la possibilità di essere in tutta la sua ampiezza e intensità, nella gioia come nel dolore, evento e non descrizione di un evento. «Dunque, amica mia, sei tu la gioia senza dio» (p. 50): versi così nitidi e così potenti non sono soltanto un’indicazione di stile; coglierli in questo senso è, a mio parere, un drammatico errore, forse un’imperdonabile ingenuità. La poesia di De Angelis si offre come un preciso dispositivo di vigilanza e al contempo concreta unità di misura per vagliare quanto la scommessa della poesia abbia senso nel nostro tempo. Essa infatti non si offre come un ardito regesto di tropi, né come un bel linguaggio da cui trarre consolazione anestetica. Essa indica un modo di stare nella lingua (che è il modo precipuo della poesia) e dunque nell’umano: un compito infinito, che non può dirsi esaurito mai, di trovare nella scrittura la parola che esaurisca il linguaggio e ne mostri l’essere ultimo, l’estremo, il bordo aperto e permeabile verso l’esterno che sempre giunge prossimo.
De Angelis ci mostra, ad ogni raccolta, che la poesia è quell’irrinunciabile fatto antropologico con cui entrare e scavare nel senso caotico di una vita che ancora intenda farsi spezzata armonia della finitudine, senza mai dare ad intendere di spartire colla propria contemporaneità se non quello che in essa sia essenziale alla comprensione della condizione umana. Non c’è aneddoto nella sua poesia, non c’è perdita di tempo. In questo senso la sua poesia non è ambigua (la sua precisione è proverbialmente millimetrica), né tanto stolida da differire i termini di una ricerca che, invece, in ogni poesia e in ogni verso, sa farsi totale dedizione alla comprensione del nostro vivere, soltanto – e soltanto se – essa sappia trasformarsi in ossessione matematica del canto.
