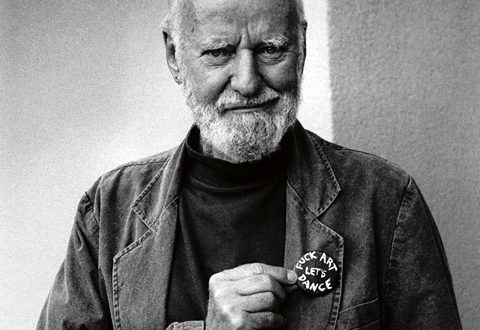
Lawrence Ferlinghetti (Foto d’archivio)
di Vernalda Di Tanna
Sconcertante, iconoclasta, dissacrante e melanconico, Lawrence Ferlinghetti delinea i capisaldi della sua poetica in quarantanove poesie raccolte in “A Coney Island of the mind” (1958), acme della sua produzione. Ferlinghetti prende per mano i suoi lettori, come se fossero dei bambini-adulti che hanno smarrito il senso della realtà più autentica: prontamente li accompagna in una sorta di giro turistico per le strade di San Francisco, città che assurge a simbolo di quella che è la capitalista e consumista “società del benessere” statunitense. Spenta e vivace, dalle luci al neon fino ai grattacieli, San Francisco espone cartelloni pubblicitari rivolti ad un pubblico di massa. Persino in un luogo sereno come il Golden Gate Park si annida una “spaventosa depressione”. L’autore fa della città e dei suoi (poco empatici) cittadini un circo, un grottesco cabaret, sineddoche dell’intero Stato nordamericano. Invece, il suo artigianale e spontaneo mestiere di poeta lo identifica con quello di un acrobata che ha il compito di indovinare la verità, prima di poter raggiungere la Bellezza, avanzando in bilico sul tagliente sguardo del suo pubblico. Ferlinghetti afferma di non essersi “mai sdraiato con la bellezza” in vita sua, ma “di esserci andato eccome a letto” generando le sue poesie. Su uno sfondo panico, immerso nella natura che l’autore immagina come un Paradiso, diversamente da Dante, “in cui la gente sarebbe nuda/ […]/ perché vuol essere/ un ritratto delle anime/ ma senza angeli apprensivi a dir loro/ di come il regno dei cieli sia/ il ritratto perfetto di/ una monarchia”. Le poesie dell’Ultimo dei Beat edificano, come afferma l’autore stesso, “un Coney Island della mente”, “un circo dell’anima”.

2018, Traduzione di Moira Egan e Damiano Abeni
In bilico, dunque, nel giocoso spazio di luci ed ombre che lo animano, il poeta afferma che “anche se i nostri campi erano strade” i suoi sogni sono integri nei sotterranei della sua memoria; cioè nella sua infanzia vissuta in un mondo che è ancora quello illustrato “nelle maggiori scene di Goya”, scene ricche di “bambini e baionette”. Il mondo in cui Gesù è stato “appeso e basta sul Suo Legno” non è diverso da quello contemporaneo in cui “Cristo è smontato/ dal Suo Legno nudo/ quest’anno/ ed è scappato in un posto dove/ non c’erano alberi di Natale senza radici”. Il mondo che denuncia Ferlinghetti è un mondo dove vige ancora la segregazione razziale. L’unico elemento che è mutato coincide solo con il paesaggio, costituito da “autostrade a cinquanta corsie/ su un continente di calcestruzzo/ scandito da melliflui manifesti pubblicitari/ che illustrano imbecilli illusioni di felicità”. E ancora, “la scena mostra meno carri di condannati a morte/ ma più cittadini scoppiati/ in auto dipinte/ […] che divorano l’America”. Oltre alle diverse rime e allitterazioni, oltre ad una sfumatura di carattere simbolista (ereditata dalla lettura di Apollinaire e Verlaine), spicca più di tutto una forma sincopata, una disposizione delle frasi spezzate, in altalena, quasi a raffigurare il filo e l’andamento del poeta-acrobata. Tuttavia, si ha l’impressione che in Ferlinghetti sia il contenuto a prevalere sulla forma, a causa sia del linguaggio che di alcune situazioni di stampo quotidiano. Eppure, non scade mai nella banalità. Il poeta è un determinato “super-realista” in continua attesa di un “rinascimento dello stupore” che dovrebbe verificarsi grazie alla forza visiva e uditiva della poesia veicolata dalla parola. Ferlinghetti, come poeta, vuole cambiare il mondo, semplicemente perché è convinto di poterlo fare e che tutti i poeti ne siano capaci. Vuole offrire ai suoi lettori occhi nuovi. Lui per primo impone al lettore il suo punto vista, sagacemente, denudandosi, per indossare la prospettiva di un cane che “trotterella” per le strade di una San Francisco fatta di “uomini sandwich e […]/ girasoli morti e telefoni vivi/ politicanti addomesticati con le fruste di partito in/ mano” che si esibiscono “sugli anelli dei loro circhi”. Infine, dopo numerosissime citazioni di autori come Thomas, Yeats, Miller, Keats e Whitman, risulta che per Ferlinghetti “questa vita non è un circo in cui/ i timidi cani ammaestrati dell’amore/ stanno a guardare/ mentre il tempo sfodera/ la sua frusta scaltra”. Dunque, Ferlinghetti, assieme a poeti che la pensano come lui, non resterà a guardare, ma denuncerà sempre ogni sopruso e ogni forma di censura e coercizione. Con “A Coney Island of the mind”, ma anche con le sue opere successive, ora sublimate in un unico volume intitolato “Greatest Poems” (Mondadori, 2018), che fa il verso alle ‘greatest hits’ della musica pop/rock, l’anarchico Ferlinghetti si propone di risvegliare le coscienze di tutti. E in maggior parte quelle dei poeti che giacciono sopite nella loro accademica culla. Così, Ferlinghetti continua ad aspettare, sulla soglia dei suoi cent’anni, “che qualcuno/ scopra per davvero l’America/ e […]/ che l’Aquila Americana/ dispieghi per davvero le ali/ e si metta nella giusta via e voli dritto/ e che l’Era dell’Ansia/ muoia stecchita”.
(I versi qui riportati sono tratti dalla traduzione di Damiano Abeni e Moira Egan)
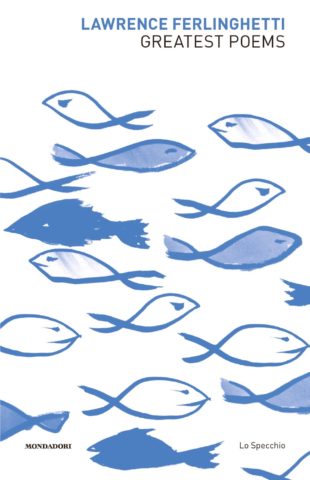
2018, Traduzione di Leopoldo Carra
