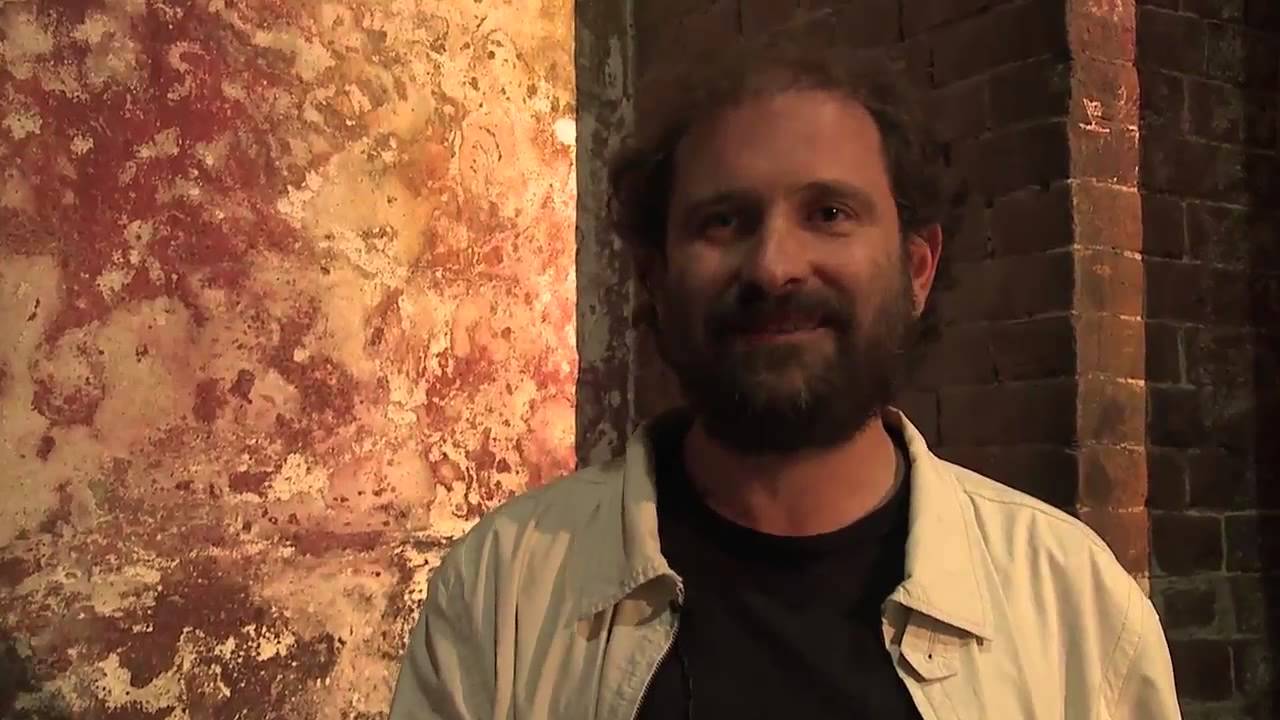
Emiliano Ilardi
LA MEDIASFERA DIGITALE DI FRONTE ALL’EMERGENZA.
di EMILIANO ILARDI
Tra le tante caratteristiche che rendono il disastroso terremoto di Lisbona del 1° novembre 1755 la prima catastrofe genuinamente moderna della Storia, vale la pena di isolarne una perché, a più di 250 anni di distanza, risulta ancora utile per comprendere come funziona il rapporto tra evento catastrofico ed evoluzione dei media.
La notizia del disastro lusitano si diffonde in tutta Europa a una velocità mai vista prima e dà vita a un primo embrione di villaggio globale e di opinione pubblica di massa. Così scrive Goethe nelle sue memorie:
Ancor maggiore fu l’effetto delle notizie che si diffusero rapidamente, prima in modo generico, poi corredate di dettagli terrificanti. Poi vennero i timorati di Dio con le loro prediche, i filosofi con i loro argomenti consolatori, e non fecero mancare paternali allo spirito. Questo insieme di elementi concentra l’attenzione del mondo, per un certo lasso di tempo, tutta in quel punto, e gli animi, sollecitati dalla disgrazia accaduta altrove, furono tanto più sopraffatti dall’angoscia per sé e per i propri cari quanto più affluivano da ogni parte informazioni, sempre più numerose e circostanziate, sulla diffusione degli effetti di quell’esplosione. Mai forse, in precedenza, il demone del terrore aveva avvolto tanto velocemente e potentemente la terra nel suo brivido.[1]
L’industria culturale nascente riceve un fortissimo impulso dal disastro di Lisbona. Vengono stampati in pochissimi anni migliaia di riviste, fogli periodici, gazzette, bollettini e almanacchi dedicati all’evento che diventa la prima bomba di panico mediatica della modernità. Si afferma il libro illustrato perché tutti, anche i non alfabetizzati, vogliono sapere cosa è successo a Lisbona. Tali pubblicazioni dureranno per un secolo. La catastrofe crea quasi dal nulla l’editoria istantanea, accelera l’espansione della stampa quotidiana e il passaggio da un sistema editoriale basato sulla Storia (il libro) a uno basato sulla cronaca (il giornale); mostra che non solo i mercati cominciano a globalizzarsi ma anche, grazie a nuovi media, le paure collettive.[2]
Almeno all’inizio, quindi, non sono tanto i media a moltiplicare l’effetto catastrofico; è invece la catastrofe che fa esplodere l’attività dei media, li mette alla prova al massimo delle loro possibilità, li fa progredire, li spinge a trovare nuove soluzioni comunicative. È come se i media a un certo punto del loro sviluppo abbiano bisogno di una catastrofe per fare il punto della situazione, prendere coscienza delle proprie potenzialità e stabilire i rapporti di forza. E capiscono, proprio a partire dall’esperienza di Lisbona, che soprattutto con disastri ed emergenze riescono a imporsi come grandi narratori-organizzatori-gestori dei grandi eventi e cerimonie collettivi.
Secondo il sociologo urbano Mike Davis, il magnate dell’editoria W. R. Hearst (quello di Quarto Potere) è riuscito a sbaragliare la concorrenza e imporre una nuova maniera sensazionalistica di fare giornalismo sfruttando le grandi catastrofi californiane di inizio Novecento (il terremoto di San Francisco del 1906 e l’epidemia di peste che colpisce Los Angeles nel 1924-25) e le guerre (la guerra con la Spagna del 1898 e la Prima Guerra Mondiale).[3] Orson Welles negli anni Trenta testa il potere di manipolazione dei nuovi media elettrici come la radio mettendo il pubblico radiofonico di fronte alla possibilità di un’invasione aliena. Anche il cinema, fin dall’inizio, userà la catastrofe per estroflettere appieno le sue potenzialità tecnologiche (ad esempio le sperimentazioni sugli effetti speciali necessari a raccontare disastri di grandi dimensioni, come in King Kong o in Via col vento), comunicative e simboliche partecipando alla grande guerra dei media su chi dovrà essere preposto a raccontare le grandi cerimonie collettive; o magari inventarle.
Infine, strettissimo, sarà il rapporto tra catastrofe e sviluppo della televisione come medium della simultaneità, quello capace di immergere il pubblico negli eventi storici fondamentali in versione live. Il 17 gennaio 1991 alle 2:38 ora di Baghdad il mondo intero assiste al primo bombardamento della Storia trasmesso in diretta televisiva, quello che dà avvio alla Prima Guerra del Golfo. La CNN vince la guerra dei media informativi proprio perché possiede le migliori tecnologie e la migliore organizzazione per trasmettere eventi live. Per più di un mese un pubblico globale è spettatore giornaliero di ciò che avviene in Iraq; un format che, da quel momento, sposta le trasmissioni e i palinsesti televisivi sempre più verso la diretta, che ispira i reality show che si diffonderanno pochi anni dopo, e che prepara le audience alle modalità comunicative dei nuovi media digitali.
Il primo grande momento di scontro tra mass media e media digitali avviene l’11 settembre 2001 con l’attentato al WTC di New York. In quel caso è ancora la televisione, per l’ultima volta, a prevalere: chi apprende la notizia su internet, infatti, immediatamente accende la TV unico medium, all’epoca, che poteva emettere immagini in diretta in alta definizione. Ma già a partire dallo Tsunami asiatico del 2004 le cose cominciano a cambiare e ad equilibrarsi. Con il terremoto giapponese del 2011 (in pieno boom di smartphone e social network) inizia ad essere difficile distinguere tra media di massa (che trasmettono anche in rete) e media digitali (spesso fonte dell’informazione giornalistica mainstream) e si entra in quella che Henry Jenkins ha definito “cultura convergente”.
Se quanto scritto finora è vero, allora non sembra azzardato presumere che la pandemia di Covid-19 che stiamo vivendo rappresenti una sorta di formidabile stress test per tutti i media che compongono la mediasfera digitale che abitiamo. I grandi HUB tecnologici che dominano la attuale platform society si rendono conto delle loro effettive affordances, fanno il punto della situazione e stabiliscono anche ruoli e rapporti di forza al suo interno. Ma anche i pubblici prendono coscienza delle opportunità e degli effetti negativi che può produrre una vita trasferita in buona parte online.
L’attuale epidemia ad esempio sta permettendo a sviluppatori e software house di verificare l’usabilità delle piattaforme di videoconferenza, di e-learning, di smart working, e dei nuovi ambienti sociali, formativi, lavorativi, relazionali che costruiscono. Dall’altra parte l’emergenza fa appunto “emergere” tutti i problemi legati al digital divide (figlio di ineguaglianze economiche), all’inefficienza delle infrastrutture tecnologiche e alla loro proprietà (pubblica o privata?), al trattamento dei dati personali, al deficit di competenze in ambito digitale della pubblica amministrazione, etc.
In questo contesto non va dimenticato che, essendo i media estensioni delle nostre facoltà percettivo-cognitive-relazionali e di azione nel mondo, anch’esse sono sottoposte a un violento stress-test dovuto a una repentina riorganizzazione di tutti gli ambiti della prossemica. Sono venti anni che le società occidentali usano internet, ma solo adesso con l’emergenza Covid-19 stanno rendendosi conto dell’ambiguità in cui sono precipitati i concetti di distanza e vicinanza. Distanziamento fisico e distanziamento sociale non coincidono più nella mediasfera digitale. È ancora corretto affermare che la didattica online sia “a distanza”? O si tratta invece di una nuova declinazione del concetto di “presenza” che dobbiamo imparare a conoscere e interpretare?
Insomma, per utilizzare una terminologia mcluhaniana la pandemia ha portato in primo piano tutti i possibili effetti dei media che prima agivano sullo sfondo, in maniera carsica, e non immediatamente percepibile. Sarebbe bene non sprecare questa terribile opportunità di autocoscienza individuale e collettiva offerta dalla catastrofe; e soprattutto bisognerebbe evitare di trasportare la discussione all’interno della solita e infruttuosa dicotomia apocalittici-integrati il cui unico risultato sarebbe quello di bloccare qualsiasi possibilità di avanzamento nella conoscenza delle trasformazioni mediali in atto.
_____
[1] Johann Wolfgang Goethe, Dalla mia vita. Poesia e verità, a cura di A. Cori, Utet, Torino 1966, p. 289.
[2] Andrea Tagliapietra, La catastrofe e la filosofia, in Voltaire, Kant, Rousseau. Sulla catastrofe: l’illuminismo e la filosofia del disastro, cit.
[3] Mike Davis., Geografie della paura. Los Angeles: l’immaginario collettivo del disastro, Feltrinelli, Milano 1999.

Non c’è una parola di troppo. Perspicuo e acutissimo: mostra la reciprocità fra emergenza e rappresentazione mediatica, sia in prospettica teoretica che storica.
Una chiave preziosa che ci aiuta a comprendere un po’ meglio il mondo (reale-virtuale) in cui ci troviamo.
Non c’è una parola di troppo e l’analisi è ben scritta e sorretta. E mi piace anche il richiamo a non far ricadere il dibattito nel circolo vizioso “apocalittici / integrati” . Nonché la indicazione sullo sviluppo della conoscenza delle trasformazioni mediali. Ma la domanda che pongo è radicale : questa nuova frontiera della “presenza” (virtuale) come si coniuga con radicali bisogni e desideri umani ? Quale il destino dei corpi ? Come “rianimare” l’Eros
( che Byung Chul Han e Alain Badiou dicono “agonizzante”)? Ovviamente “se” si desidera “rianimarlo”. Dimenticare “il bacio alla francese” e abituarci al “bacio mai dato” ?
Bello vedere come la storia modifica i media e non solo il viceversa, che invece è stato ribadito tante volte da McLuhan in poi. Complimenti.
Io penso che la reciprocità tra eventi e media, qui messa in luce anche in prospettiva storica, aiuti a comprendere meglio il mondo in cui ci troviamo ed eventualmente a cambiarlo.
Mi ricordi un’affermazione di Simone de Beauvoir scritta, se non sbaglio, nella sua autobiografia volume uno “Memorie di una ragazza perbene”: “cosa vorrei come donna? conoscere il mondo ed esprimerlo”. Sarà dura cambiarlo.
Se il Covid 19 è considerato uno stress test per l’organizzazione sanitaria e per saggiare le capacità di resilienza della massa sociale, l’excursus storico che il prof. Ilardi espone associando la storia delle catastrofi allo sviluppo dei media, apre altri ambiti di riflessione affatto trascurabili, specie riguardo la questione della “distanza” e della “presenza”, fisica o a distanza. Ambiti di interrogazione attualmente impellenti per chi, me compresa, pone al centro della sua opera l’incontro con l’altro. Sarà uno stress test anche per tutto ciò che Buber, Merleau-Ponty, Bachelard, Stein, ci hanno insegnato sulla dimensione corporea/empatica insita nel rapporto io-tu?
Giustissimo Tiziana, i suoi riferimenti sono importanti e hanno regalato emozioni intensissime… sicuramente il covid-19 è apparso come “uno stress test” sulla capacità di resilienza della massa sociale. E questo apre un dibattito interminabile, ma anche un vuoto insanabile. Il vuoto che ha lasciato in noi l’esperienza pandemica vissuta – in alcuni casi – attraverso i media. Lo stress è stato enorme, ha cambiato la percezione dell’altro… su questo dovremo interrogarci negli anni a venire.
Ringrazio tutti/e per i commenti e le osservazioni alla mia breve riflessione.
Come alcuni di voi hanno fatto notare, anch’io credo che il principale problema sia quello di capire l’evoluzione dei concetti di distanza e presenza che la pandemia ha portato in primo piano. Ovviamente sono almeno 15 anni che i media digitali stanno riconfigurando la nostra maniera di concepire e vivere gli spazi e le distanze, ma appunto la pandemia ha tolto il velo e ce li ha mostrati in tutta la sua evidenza. Io credo che questo tema vada affrontato senza pregiudizi o assoluti ideologici.
Permettetemi di farvi un esempio basato sulla mia esperienza lavorativa. Sono 15 anni che mi occupo di e-learning e del rapporto tra didattica e tecnologie digitali; e sono 10 anni che insegno in un Corso di Laurea di un’università pubblica, erogato in blended learning (30% in presenza – 70% online). Sono stati anni di ricerche, sperimentazioni, errori, correzione di errori, etc. Negli ultimi 2-3 anni le cose hanno cominciato a funzionare bene e posso tranquillamente affermare che una didattica, che sappia integrare online e presenza in aula, offre migliori risultati rispetto a una didattica solo in presenza o solo online. Certo, ci vuole fatica e un po’ di curiosità, i docenti devono avere il coraggio di mettere in discussione le loro metodologie didattiche, lo Stato deve mettere a disposizione infrastrutture funzionanti e personale formato, ma secondo me ne vale la pena.
Attraverso un’efficace integrazione tra online e aula, la distanza tra docente e studente diminuisce; lo studente ha una piattaforma didattica in cui interagisce continuamente con il docente (che non è più lontano, seduto in cattedra), partecipa a lavori di gruppo, condivide materiali, osservazioni ed esperienze, riceve una valutazione continua e formativa, e non meramente quantitativa alla fine del corso, gli si insegna a considerare l’errore come un passo necessario alla formazione e non come mero elemento di valutazione. L’e-learning non si può ridurre a una semplice questione tecnologica, non è semplicemente la lezione online, non è un mero trasferimento della didattica in presenza sulle piattaforme, ma è una maniera di ripensare il concetto di didattica e del rapporto tra docente, discente e spazio di apprendimento.
Vi ho fatto l’esempio della didattica perché è quello che ha creato più polemiche durante questi mesi di pandemia con prese di posizioni totalmente pregiudiziali (penso a Cacciari, Asor Rosa, Agamben per fare i nomi più famosi), spesso senza conoscere l’oggetto della discussione. Chi studia seriamente l’e-learning (e ci sono ormai migliaia di pubblicazioni sul tema) sa benissimo quali sono i punti di forza e di debolezza, i rischi e le opportunità e su questi elementi lavora provando a mantenere il necessario distacco per analizzare l’oggetto e giungere a soluzioni efficaci.
Io spero che questi 3 mesi di didattica forzatamente online a scuola e all’università non vengano buttati via o dimenticati. Molti docenti hanno sperimentato per la prima volta la “presenza” online, molti hanno provato a inventare nuove soluzioni didattiche, molti invece hanno espresso una posizione di irriducibile rifiuto; è emerso il problema del digital divide (e delle diseguaglianze economiche e infrastrutturali), delle piattaforme proprietarie (e quindi della necessità di piattaforme pubbliche o open source), di come valutare la didattica online, etc. Ripartiamo da qui, evitando sterili posizioni dicotomiche.
Dopo un mese e mezzo di lezioni a distanza, a fine aprile, ho chiesto a mia figlia di 12 anni se sentiva nostalgia della scuola. Questa la sua risposta: “Un po’ sì papà. Ma, d’altra parte, è un mese e mezzo che la scuola entra tutti i giorni nella mia cameretta”.
Questo nel complesso è stato un dibattito aperto e proficuo. Grazie a tutti i suoi partecipanti.