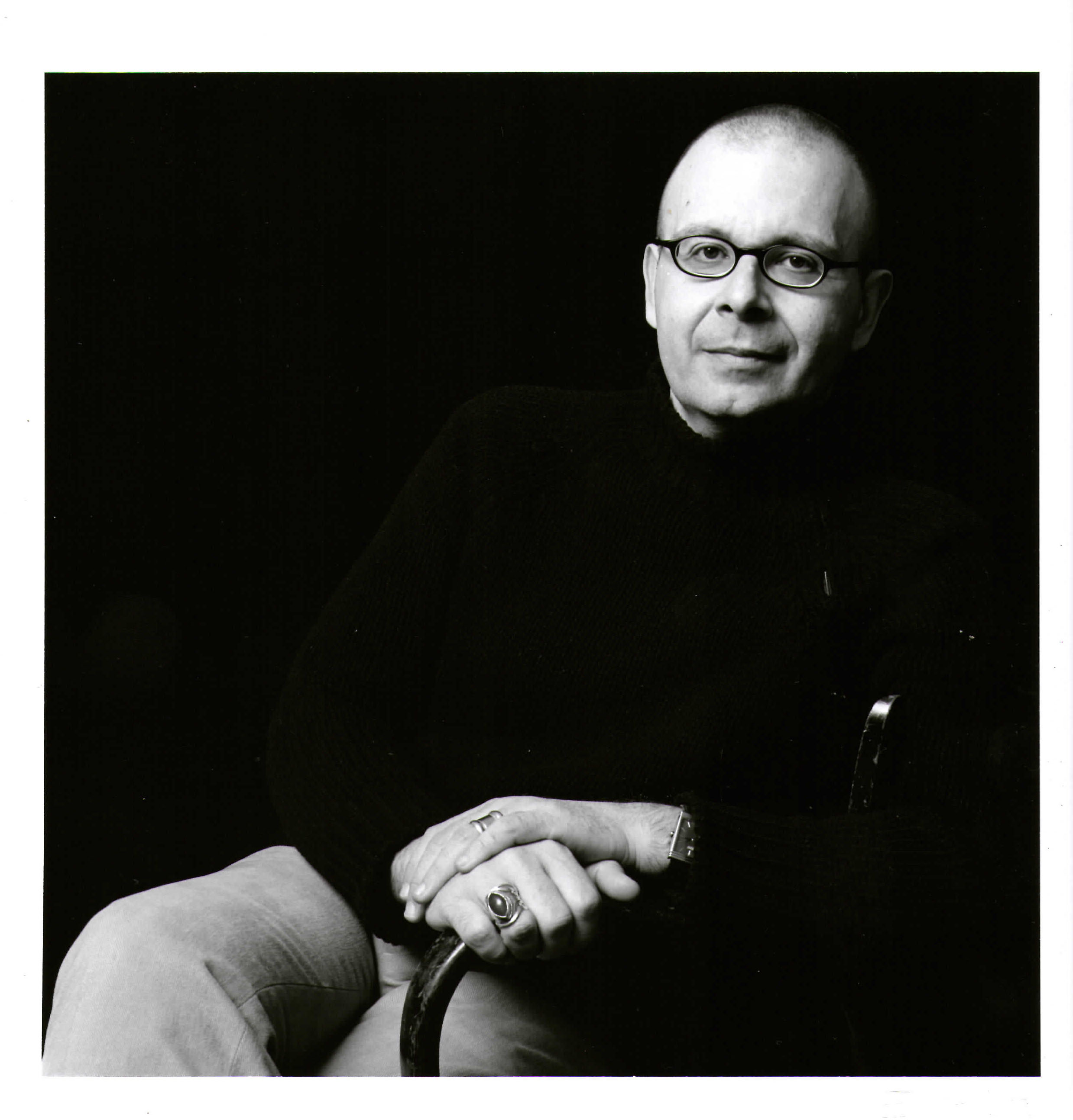 INTERPOSTA PERSONA
INTERPOSTA PERSONA
DI VITO M. BONITO
Faccio fatica a pensare per macrostrutture, per astrazioni, per simulazioni.
Queste poche e deboli riflessioni sono a margine e marginali rispetto a quanto accaduto e ancora in atto da mesi, al nostro essere confinati e vivere reclusi tra l’invisibile virale, l’aria sublime e rarefatta di parole giganti talvolta inafferrabili (talvolta fastidiosamente inautentiche), il vaniloquio social-mediale e la microscopia di un quotidiano in cui è difficile arrivare a concludere un pensiero che varchi la soglia della propria vita familiare e biologica.
Faccio l’insegnante e sono padre di una bimba di tre anni e tre mesi, l’orizzonte del mio vivere già da decenni contratto segregato e zoppicante, ha dovuto fare i conti con questi altri due aspetti che in sé, in questi mesi di clausura e distanziamento, hanno presentato vantaggi e svantaggi, messo a nudo sicurezze e insicurezze, sospiri, respiri e logoramenti a cui non sempre sono stato in grado di fare fronte.
Non ho rischiato il posto di lavoro, ma ho dovuto adattarmi a un modo di lavorare quasi capovolto. Un universo capovolto in cui, pesce fuor d’acqua, ho dovuto respirare al contrario, pensare al contrario, comunicare al contrario e per via fantasmatiche, larvali proprio come dentro «il delitto perfetto» così ben spiegato da Baudrillard.
Durante più di due mesi e mezzo murati in casa, una bimba di tre anni – che all’improvviso smette di andare al nido e di vedere gli altri bimbi e non può uscire di casa – comincia a fare domande a cui non sai rispondere con le sue parole e ti accorgi che le tue non hanno e non danno alcun senso e significato a ciò che sta accadendo. Lei comincia altresì ad andare in crisi e ad agitarsi in perfetto orario ogni giorno alle 18 e dopo almeno nove ore che i genitori si sono inventati il mondo per tenerla impegnata, e sono piegati, scarsamente reattivi alle percussioni comportamentali, ai forsennamenti verbali che aumentano proprio quando tu diminuisci, ti stai spegnendo.
Ogni giorno poi fai la conta dei morti, dei contagiati, e così misuri lo spazio in cui vivi.
E ogni giorno tutto torna uguale, ferocemente uguale.
Non riesco neppure lontanamente a immaginare cosa provi chi ha perso il lavoro e non sa se lo ritroverà e in quale forma e in quali tempi.
Non riesco a immaginare quale strazio stia ancora provando chi (non) ha visto spegnersi i propri cari, blindati, murati dentro la malattia e nell’isolamento sanitario; cosa abbia provato chi ha sofferto e poi perduto la vita, soffocato nel respiro, chi è sopravvissuto, chi ora si sente perduto dentro questa vita.
Non so rispondere, né fantasticare intorno a scenari globali, grandi visioni macro-tecno-economiche di un capitalismo feroce, o rasserenarmi dentro il sogni di un’economia salvifica dell’umanità e del pianeta, da avverarsi nel post-pandemia.
Sono confinato nel mio corpo, in quello dei miei cari, ma con molte più paure di prima di non farcela, di ammalarmi e morire.
Non faccio che farmi domande – o procedere senza direzione dentro alcune immagini.
Dove va un corpo che si ammala e muore? Cosa pensa? Dove sta un corpo malato? Qual è la sua dimora?
La luce degli occhi guarda fuori scena e la sembianza trasloca in un aldilà del corpo muto e senza luce, lasciando chi resta – perduto e solo sulla scena.
Chi resta è il testimone infinitamente lontano di un martirio.
Chi resta non ha che le mani. E non può che muoverle da una lontananza impercorribile.
Un corpo malato che muore non vede più. E non vede più che se stesso.
La mani di chi resta pèrdono l’orizzonte quanto più si avvicinano al corpo che muore.
Non fanno che chiedere perdono.
Un corpo malato diventa straniero a se stesso. Diventa il luogo della proliferazione di un intruso che piano piano lo rende estraneo a quella identità fino ad allora limitata e sicura fuori e dentro di sé, verrebbe da parafrasare Nancy quando scrive del suo trapianto cardiaco.
Se la malattia è lo straniero più familiare a cui si dà ospitalità, cosa e chi stiamo ospitando di corpo in corpo, quale lingua babelica ci parla in tutto questo morire senz’aria?
Chi è malato trema. È un tremore della luce che scende dentro di sé e fa buio intorno. È luce che si avvicina al punto massimo di biancore e si allontana dalla pelle.
Inerme il corpo si chiude, si piega su di sé, in sé. Lascia andare la sua litania finale nello sgomento dell’abbandono, dell’essere abbandonato.
Qual è il margine dello sguardo di un morente?
Noi che viviamo sempre rivolti verso il mondo, d’improvviso ci vediamo smarriti, perduti nello specchio di volto che si fa piccolo e piano piano inesiste mentre gli occhi si velano di un silenzio opaco, si fanno laghi lontani, voci abbandonate che ci lasciano, non ci chiamano più.
A chi vuole bene chi se ne va? A chi vuole bene chi muore mentre muore?
Qual è l’ultimo sguardo? Per chi? Qual è l’ultimo pensiero, l’ultima parola pensata, sognata, respirata? Dove dimora il margine morente d’uno sguardo? E dove va a morire lo sguardo di chi resta, il buio bianco del respiro?
Mentre un corpo ‘dice’ «io muoio», l’altro ‘risponde’ «io vivo». Mentre il corpo che dice «io muoio», forse, chiude la ferita del dolore, il corpo che dice «io vivo» raccoglie su di sé la ferita, riceve il taglio, il raggio verde all’orizzonte prima che il sole scompaia.
Chi muore lascia i viventi in un ‘per sempre’ intransitabile.
Un corpo morente è un’onomatopea muta.
*
Nel racconto di questi terribili e incandescenti giorni di pandemia, i vivi e i morti sono come di spalle gli uni agli altri. Ciascuno porta in sé un lutto che lo separa dall’altro e paradossalmente lo salda a una comunità messa di fronte alla morte quasi ciecamente, quasi per mancanza d’aria.
Faccio fatica a pensare per macrostrutture, per astrazioni, per simulazioni.
Così mi sono detto che l’unica cosa evidente che io riuscivo a percepire era (ed è) il collasso del pensiero medesimo e di tutti i suoi paradigmi. Comunitario, immunitario, medico-sanitario, simbolico, concentrazionario.
E via, tra i rimbalzi di mia figlia e i pupazzetti che a giro compaiono e scompaiono, fanno le voci e le straziano, come dentro un libro di Thomas Bernhard ho pensato al nostro invisibile nemico, il virus, a cui non importa nulla di ogni nostro pensare e agire, che leopardianamente non sa chi o cosa siamo e neppure perché poi lui stesso si trovi nei nostri corpi, grassi magri vecchi giovani, quasi spaesato ospite costretto meccanicamente a proliferare parassitariamente in noi – fino a morire con noi.
Mi sarebbe piaciuto intervistare il virus, l’innominabile; sapere di lui, cosa pensa, come ci trova, se siamo confortevoli, se magari è interessato a ogni nostro sentire, se intende sterminarci o convivere con noi, se soffre quando minacciato dai medicamenti o dal nostro sistema immunitario, se fa parte di una metafisica ancora da noi non pensata o se è solo l’ennesima testimonianza patafisica e beffarda della nostra insulsa presenza nell’universo, se mai magari non fossimo noi medesimi (e non metaforicamente) il virus, l’infezione, il contagio combattuti da qualcuno o qualcosa che non vuole di noi morire, spengersi, finire.
E invece siamo qui a cercare di capire – mentre non siamo in grado di non capire e di accettare di non capire; non siamo in grado di dichiararci sconfitti da un ‘prodigio’ più ‘grande’ di noi, di essere deposti – sovrani di niente, risibili e inconsistenti.
Ho pensato a certi film di Harmony Korine che parlano di vite spezzate e straziate, inermi e rigettate in una sorta di post-umano, troppo umano: in uno smarrimento temporale e percettivo tanto più profondo quanto più la condizione umana stordita e residuale, senza gloria, in una si dimena dentro una luce fredda e malata, in una storicità terminale, asfissiante, senza identità.
Non so perché continuo a pensare a Mister Lonely (un film del 2007) e a una delle due storie che si alternano e intrecciano nella trama: quella di un gruppo di suore che a Panama sostengono una comunità indigena che vive in condizioni di povertà. Padre Umbrillo (‘interpretato’ da Werner Herzog) è il punto di riferimento spirituale della comunità di suore che con lui volano in aereo nella foresta per raggiungere lontane e sperdute missioni cui distribuire viveri. Durante un volo una suora precipita dall’aereo, ma si rialza una volta schiantatasi a terra. Le suore in virtù di questo miracolo cominceranno a lanciarsi dall’aereo volando.
Essere state donate di un miracolo – cadere da un aereo e essersi rialzate vive – conduce il gruppetto di suore guidate da padre Herzog a reiterare il miracolo, a sottoporlo a verifica ‘sperimentale’ fino a che in viaggio per una benedizione papale, ostensione quasi dei corpi gloriosi delle miracolate, l’aereo con le suore precipita in mare in una sorta di prodigio inverso e fatale: è così che l’impensato della vita (e di iddio?) irrompe nell’esistenza e la devasta.
È come voler svelare l’inganno supremo che regge il mondo e la vita – ho pensato.
Siamo esposti all’opera cieca dell’inatteso che dà e prende senza consenso e senza senso.
E dunque ha ragione padre Herzog, pur nel suo essere un agente di spettacolo divino, quando dice: «sorelle, so che può sembrare assurdo, ma il Signore vuole metterci alla prova.
Il Signore vuole che saltiamo giù da un aeroplano senza paracadute. Vuole vederci volare. Vuole vederci danzare nel cielo e servire allo scopo. Vuole mostrare al mondo che esistono i miracoli, che esistono miracoli che accadono a chiunque. Se siete pure, se credete, sorelle, credetemi, voi volerete».
È una tragica e beffarda orazione che nel prosieguo diventa funesta parodia, profezia che si rovescia nel tragico scherzo di un paracadute che Dio si dimenticherà di aprire: «in questa nazione spezzata siamo stanchi e feriti. Ci hanno lasciati soli, senza niente. Siamo stati abbandonati. Siamo come il vomito in strada davanti ad un bar malfamato. Siamo stati cacciati in fondo al barile, e tutte le nostre capacità di comprensione e amore sembrano sparite per sempre. Se vogliamo sopravvivere, dovremo diventare come gli animali e dovremo lasciar perdere ogni senso di civiltà e comprensione. Come è possibile che una suora voli? Come può cadere da un aereo e atterrare sana e salva? Ma chi siamo noi, chi siamo noi per farci beffe di queste cose? Chi siamo noi per dubitare di questi miracoli?
Ahimè, non siamo che barboni nella spazzatura, qui in questa nazione spezzata.
Ma un po’ di fede ci porterà molto, molto lontano. Se siete pure, se credete davvero, sorelle, credetemi, voi volerete. Dio sarà il vostro paracadute».
Lo schianto mortale delle suore (perduti, squassati corpi nel mare e sulla spiaggia) sporca la favola della vita così com’è. Nessuna redenzione. Solo una morte ‘qualunque’. Neppure adatta a un santino con gli ologrammi.
Chi siamo noi, appena senzienti sul margine inattingibile dell’impensato.
Chi siamo, per credere che Dio sarà il nostro paracadute.
Ho pensato.
Siamo caduti in ginocchio e stiamo sussurrando la nostra preghiera.
Da Nessuno guardati, da Nessuno ascoltati.
Cosa ricorda nelle sequenze iniziali del Paese del silenzio dell’oscurità Fini Straubinger, la protagonista sordo-cieca del documentario di Herzog? O meglio cosa Fini dice di vedere, dentro il buio da cui affiora la sua voce fuori campo?
«Quando ero bambina prima di diventare così ho visto una gara di salto dal trampolino. E una cosa continua a ritornare … quegli uomini che attraversano l’aria… . Ho guardato i loro volti. Vorrei che voi poteste vederli».
Sono morte più di trentatremila persone. Chi ha guardato i loro volti? Chi non ha potuto guardarli?
Ho pensato.
