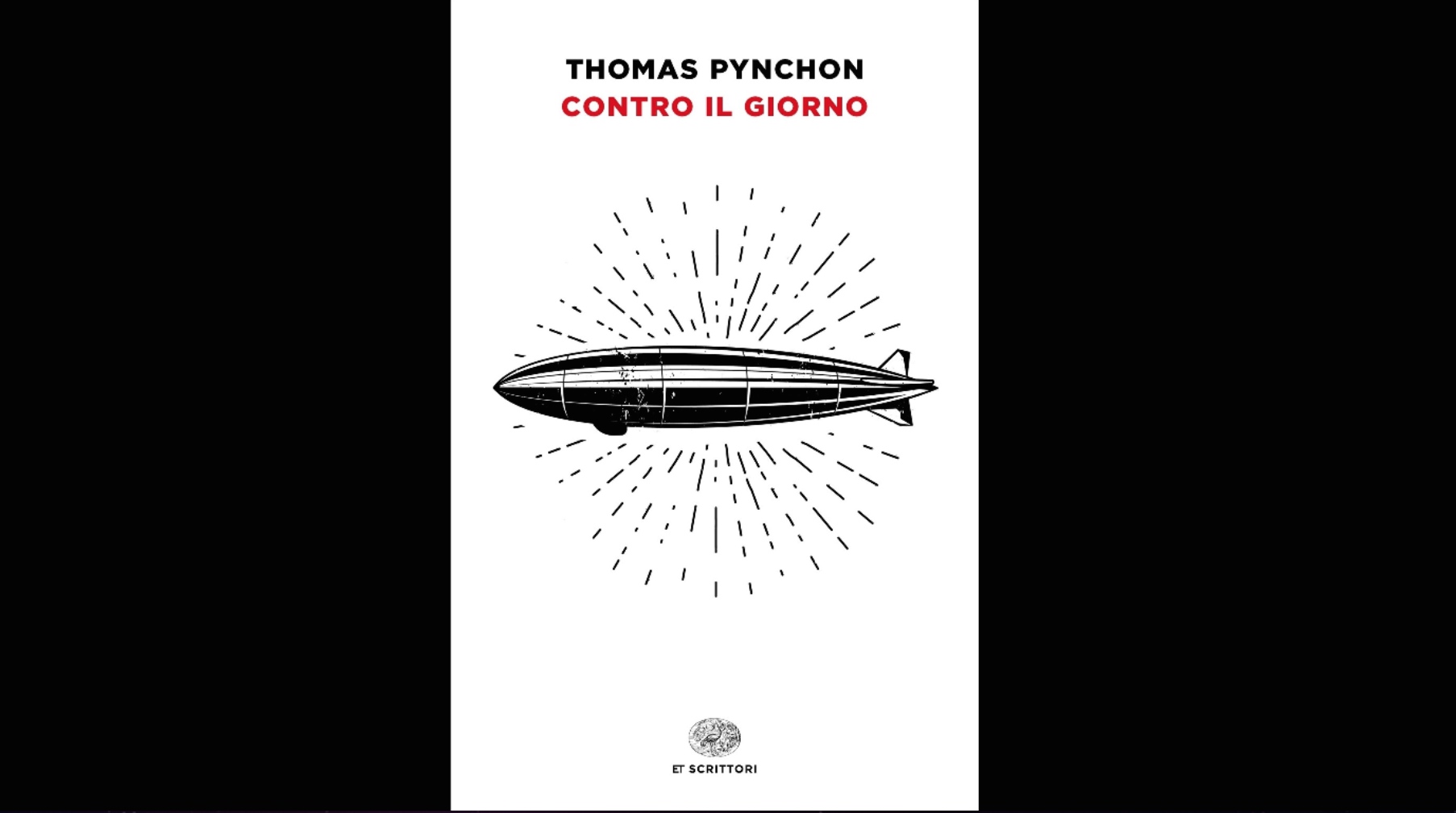 RECENSIONE DI ALBERTO FRACCACRETA
RECENSIONE DI ALBERTO FRACCACRETA
Thomas Pynchon. È un nome, solo un nome. Flatus vocis. Vive a New York ma nessuno lo ferma per strada perché nessuno può dire esattamente che viso abbia. Siamo in possesso di una manciata di fotografie della sua giovinezza. Capelli leccati, naso piccolo e stretto, dentoni, blusa da marinaio. Intelligenza vispa. Nel 2018 sono uscite su un rotocalco americano un altro paio di istantanee di lui anziano, con il bastone, chioma nivea e floridissima. Il figlio Jackson al suo fianco. Qualcuno dice che nel film con Joaquin Phoenix Inherent Vice, tratto dall’omonimo romanzo pynchoniano, ci sia un cameo con lo scrittore. La notizia non è confermata, ma è certo che abbia prestato la sua voce in una puntata dei Simpson. Recitava sé stesso con un sacchetto marrone in testa e un punto interrogativo stampato.
Thomas Pynchon ha ottantatré anni e — secondo alcuni — è tifoso della Juventus (?!). Non ha mai concesso un’intervista in vita sua (è un record assoluto perché un altro grande sfuggente della letteratura americana, Cormac McCarthy, qualche strappo alla regola lo ha fatto). Paragonato a Salinger per ovvi motivi e candidato al Nobel da decenni, ha esordito a ventisei anni con V., testo letteralmente inafferrabile, e ha proseguito con un libro cult del postmodernismo e del realismo isterico, L’incanto del lotto 49.
Le trame dei romanzi di Pynchon — sia ben chiaro — sono intricatissime, labirintiche. I dettagli nascondono il tutto e il tutto si riversa borgesianamente dentro ogni singolo dettaglio.
I nomi dei personaggi sono quasi sempre parlanti: si pensi a Oedipa, protagonista dell’Incanto, o Herbert Stencil (“stampino”) che gira il mondo alla ricerca di qualcuno o qualcosa che si chiami V. Queste tipologie di opere Calvino le definisce «romanzi enciclopedici moderni», nei quali avviene in sostanza «un’analisi dello sfacelo, una coscienza del collasso, una testimonianza della frammentazione, una critica radicale del concetto di verità».
Episodi storici poco noti o completamente sconosciuti, cultura elevatissima e pop dei più triti, amore per la fisica e le scienze naturali, crudi tecnicismi e momenti lirici si mescolano in reticoli cristallini e tetraedrici, in forme allotropiche e deformanti al limite della piena comprensibilità. Tutto questo cosa ha a che fare con la poesia?
Analizziamo anche solo superficialmente Contro il giorno, sesto libro di Pynchon pubblicato nel 2006 e appena ristampato da Einaudi nella traduzione di Massimo Bocchiola.
Come già si è anticipato, la trama è ovviamente non riassumibile. Siamo dinanzi a un dedalo di vie e viuzze, di ghirigori, di incontri e d’improvvise apparizioni. Si parla del capitalismo a cavallo tra Otto e Novecento e di falsi profeti, di idioti folli al potere e di menti raffinate, di forze proletarie e anarchiche presto sconfitte, di male diguazzante e di bene che riesce in qualche oscurissimo modo a non contaminarsi.
Ha scritto con molta chiarezza Paolo Simonetti su Alias D, il supplemento del manifesto, che «come suggerisce il termine francese contre-jour, il romanzo racchiude all’interno un romanzo fantasma che si svolge in “controluce” rispetto agli avvenimenti principali. I continui riferimenti al “misterioso potere sciamanico noto come bilocazione, che comporta il dono di essere letteralmente in due o più luoghi, spesso molto distanti, nello stesso tempo”, segnalano che lo sdoppiamento spazio-temporale è parte integrante del meccanismo narrativo».
Soffermiamoci un attimo, dacché Pynchon è per noi un nome soltanto, sui già fatidici nomi dei personaggi. Per dirne alcuni: Yashmeen Halfcourt, Dahlia Rideout, Kit Traverse, Scarsdale Vibe, Cyprian Latewood, Mister Ace, Estrella Briggs, Vlado Clissan, Sloat Fresno, Padžitnov, Randolph St.Cosmo, Andrea Tancredi (!), Heino Vanderjuice, Luca Zombini il Misterioso (!!!). Non sono semplicemente nomi parlanti. Sì, anche quello. Ma la cosa va oltre. Il peso specifico del loro corpo è troppo forte per affogare nel mare della lettura. Sono nomi disturbanti. Infastidiscono, fanno chiasso, osteggiano, appesantiscono il leggere. Visivamente e mentalmente. Costringono egoisticamente a soffermarsi su di essi. Sono parole-barbaglio. Suoni-abbaglio. Luccicano. Frammenti di senso dentro il flusso narrativo, da essi inderogabilmente interrotto.
È chiaro che siamo nei pressi di quella letteratura da Joyce a Gadda (come non pensare a Ciccio Ingravallo e Gonzalo Pirobutirro) che gioca eternamente con la lingua, che quasi inietta per via metaletteraria una personalità propria al linguaggio tale da essere il vero, termidoriano protagonista dell’atto dello scrivere. E c’è di più: s’impone alla presenza del lettore una sorta di coscienza gnostica con annessa strizzatina d’occhio a dire: ebbene, hai capito? Qui il messaggio è per pochi, gli happy few. Alle catene fonematiche Pynchon conferisce un valore nascosto di cui vuol rendere partecipi soltanto coloro che superano i primi, difficilissimi, livelli di lettura. Non stiamo parlando di professori universitari o fedeli esegeti o colleghi scrittori o sferzanti critici dalambertiani.
Stiamo parlando delle 4 o 5 persone in tutto il mondo che, oggi, nonostante il vasto successo editoriale, costituiscono il reale pubblico di Pynchon: gente che come lui — esattamente come lui — vive di un’incontrollata potenza d’immaginazione, impossibile da comprendere.
È abbastanza evidente che la presenza aerostatica di tali nomi e soprannomi, che la fantasia sfrenata, selvaggia, mostruosa dell’autore, che la continua ricalibrazione di generi letterari interni al testo (dall’intrattenimento ottocentesco al western fino a un improbabile noir), che l’occhio smaliziato dei Compari del Caso — banda di giovani avventurieri in giro per il globo su un’aeronave —, che l’idea di intitolare un capitolo Spato d’Islanda appartengono a procedimenti del tutto antieconomici sotto il profilo narrativo. Sì, perché in definitiva, a conti fatti, questo enorme e ingombrante armamentario appartiene alla poesia. Non c’è altra strada. Ciò che esagera, rompe, divelle, disarticola, gonfia, insuffla, deterge, polverizza il narrato (a rischio e pericolo: non è questa un’apologia), non può essere circoscritto solo all’ambito della narrativa, causa la sua presunta orizzontalità. Rientra probabilmente nel più alto (e scivoloso) concetto di poiesis, nelle maglie di un “fare” e di un “produrre” che ci atterrisce metafisicamente.
Cosa diamine vuole dire Pynchon?, cosa gli sarà passato per la testa?, cosa vedono i suoi occhi cisposi e catafratti?, ci domandiamo noi che ogni volta siamo costretti a riconoscere con costernazione o forse anche con sollievo di non essere tra gli happy few. E leggiamo questo incipit ancora con delusa o con liberante perplessità, come un testo chiuso da una chiave etrusca, un passaggio segreto e inaccessibile che mai ci sarà rivelato: «“Ora dimezzare gli ormeggi e occhio a tutti i passi!” “Di lena, adesso… calmi… bene così! Pronti a salpare!” “Città del Vento, arriviamo!” “Urrà! Si sale!” Fu fra queste vivaci esclamazioni che l’aeronave all’idrogeno Inconvenience, con la gondola ornata da bandierine patriottiche e un equipaggio composto da cinque membri del fregiatissimo circolo nautico noto come i Compari del Caso, ascese bruscamente nel mattino e in breve prese il vento da sud».
Thomas Pynchon, Contro il giorno, traduzione di Massimo Bocchiola, Einaudi, pp. 1152, € 22
______________________
Thomas Pynchon (1937) è avvolto in un mistero pari solo a quello che ha circondato J. D. Salinger ed è considerato unanimemente il più grande narratore americano (e non) dal secondo dopoguerra a oggi. Einaudi ha già pubblicato la sua unica raccolta di racconti, Un lento apprendistato, e i romanzi L’incanto del Lotto 49, Vizio di forma, da cui Paul Thomas Anderson ha tratto il film omonimo, V., La cresta dell’onda e Contro il giorno.
