
Umberto Piersanti, creidits ph Dino Ignani
ANTEPRIMA EDITORIALE
Nell’ultima raccolta di versi di Umberto Piersanti, Campi d’ ostinato amore, (la Nave di Teseo, 2020) il poeta urbinate conferma e condensa l’ identità e l’unicità di una voce che deposita con grazia il germe assoluto della sua poesia in una terra mitica e leggendaria: l’amato altopiano delle Cesane, il mondo antico e arcaico della civiltà contadina, le figure mitiche che lo popolano e l’ostinato silenzio dell’amato figlio, Jacopo.
La testimonianza poetica di Umberto Piersanti evoca una realtà naturalista scomparsa, un passato lontano dalla quotidianità, una civiltà remota, che riaffiora dalla memoria con uno spessore antropologico e magico.
(Luigia Sorrentino)
Il passato è una terra remota
a Giulia
no, non tra rossi papaveri
e fiordalisi come l’antica
col velo dentro al quadro
ma alta sugli stivali
nel terrazzo fumi,
e non mi guardi,
poi su gran verde stesa
quel tuo volto acceso,
e accesi gli occhi
così azzurri e persi,
sei la ninfa riversa
nell’attesa
e la tua bionda carne
m’invade e piega
passano innanzi agli occhi
le figure,
in altri tempi
e luoghi lontani
e persi, tu sotto la cascata
t’infradici i capelli
neri e sciolti
e mi sovrasti
chino sulla roccia
non conosci quei lampi,
non sai i tuoni,
Dicono che i soldati
salgono su lenti
dalla marina,
lei siede alla ringhiera
contro i bei vetri,
tu non ricordi il volto,
non sai la veste,
solo quelle ginocchia luminose
che appena intravedi
fra le trine
quando la casa cambi
o la dimora,
salgano le memorie
fitte alla gola,
e se tendi la mano
quasi le tocchi,
ma il muro che le cinge
è d’aria e vetro,
nessuna forza
lo può oltrepassare
il passato è una terra remota
magari non esiste,
non sai dove.
dicembre 2015
Volti
volti, volti nella mente
infissi,
sempre più infissi
e incerti,
e poi così lontani,
lontani e persi,
nell’oscura veglia
mi siete d’intorno,
vicini, così vicini
alle mani
e agli occhi,
padre da un grande tempo
dimori oltre la valle
che la nebbia copre,
la grande nebbia
che sta oltre,
oltre ogni casa
e campo,
come chi ha la vista
quasi spenta
risalgo con le mani
alla tua fronte,
su ogni piega
mi soffermo e insisto,
del tuo magro sorriso
ricerco il dono
e i tuoi occhi madre
sono i più chiari,
io me li stampo dentro,
mi fanno il sangue lieto
e nulla può il dolore
che m’abbranca,
restano chiari
e azzurri
oltre lo sguardo,
lo sguardo mio
che tanto s’appanna
sorella dalla veste chiara
ora m’allacci i pattini
e spingi alla discesa,
lascia ch’io tocchi ancora
i tuoi capelli così lunghi
e scuri
l’altra ha quei tacchi larghi,
larghi e spessi
degli anni di guerra,
tra le ginestre lei
rifulge tanto
che degli occhi appannati
lacera il velo
e padre e madre,
e la bruna sorella
l’altra più chiara,
la cucina fumosa
e l’orto coi soldati,
quelle canzoni lente
e disperate
mentre il maiale cuociono
sull’erba,
tra loro un giorno
ti sei risvegliato
e loro t’hanno accolto
e riscaldato,
il tempo poi dissolve le figure
ad una ad una nel vortice
degli anni rapinate,
contro il vuoto che ghiaccia
sangue e fiato
dentro l’aria le incidi
per l’eterno
e poi c’era quell’erba
contro i mali
quella di colore scuro
come il nome,
è l’erba delle bisce
che la pozza cerchia,
se la metti a bollire
sopra un gran fuoco
e poi quell’acqua bevi
densa e nera
i mali come serpi
strisciano via
lontani
era come una radura
riparata dall’acqua
e i venti,
dai fuochi d’attorno,
l’unica che rammenti,
se altre ne ho incontrate
non le ricordo
marzo 2018

Continua a leggere→



 ANTEPRIMA EDITORIALE
ANTEPRIMA EDITORIALE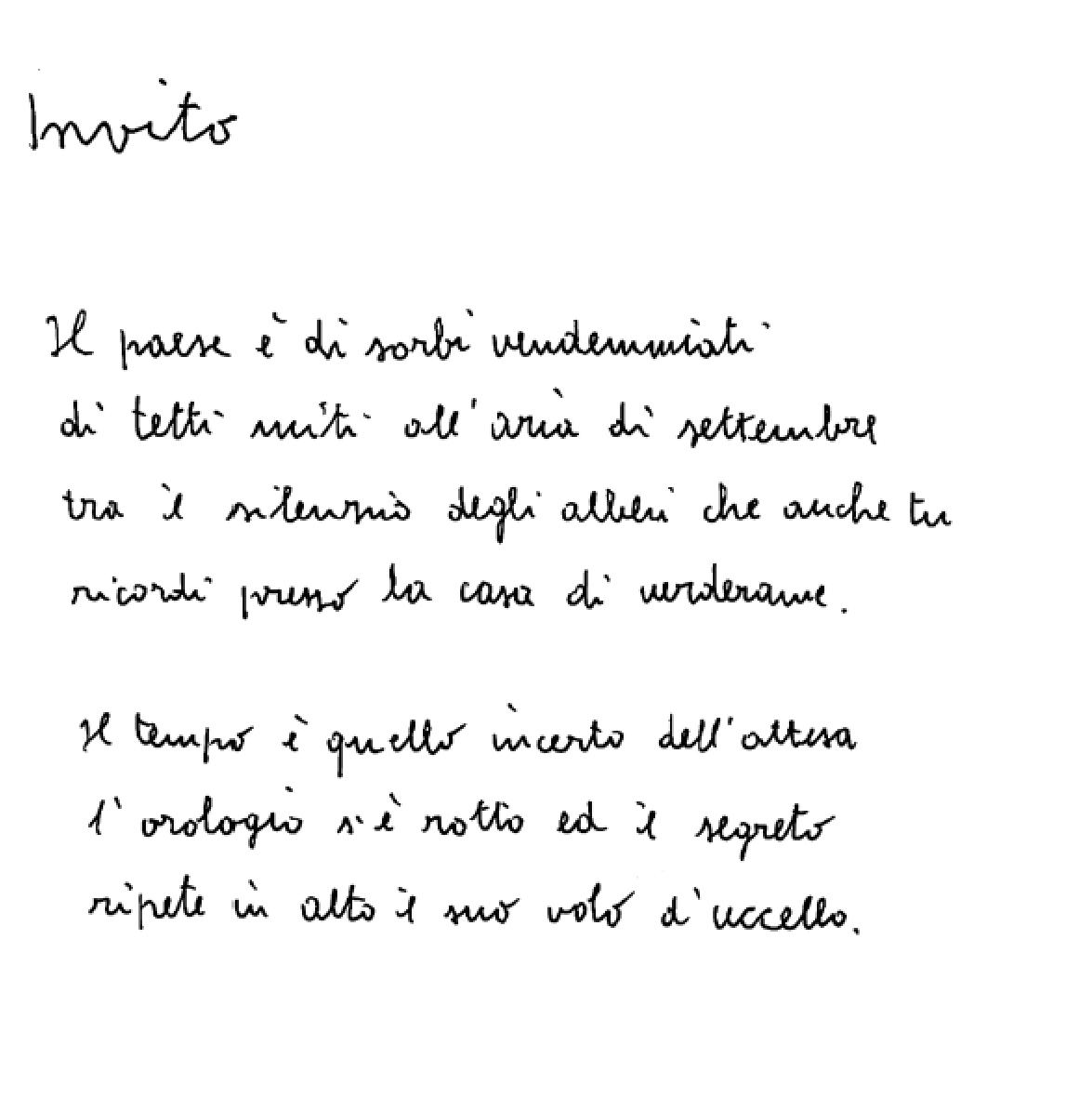
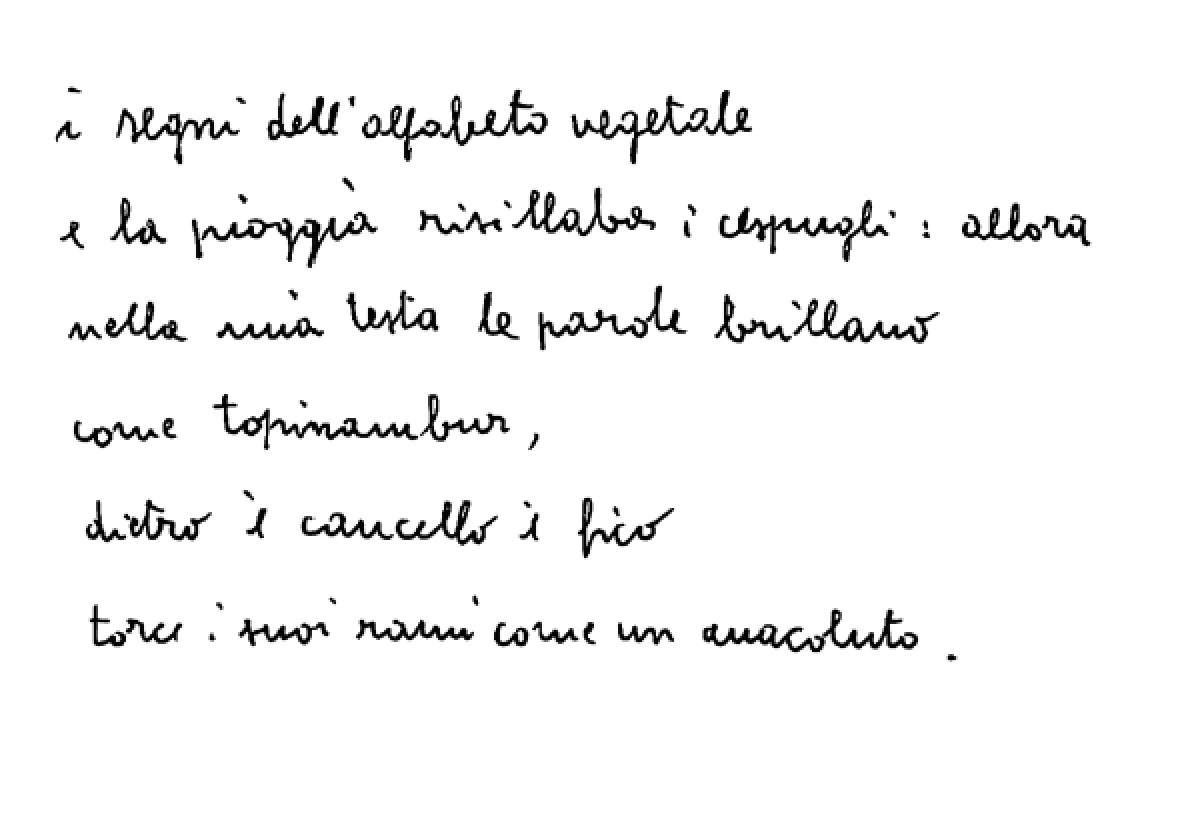
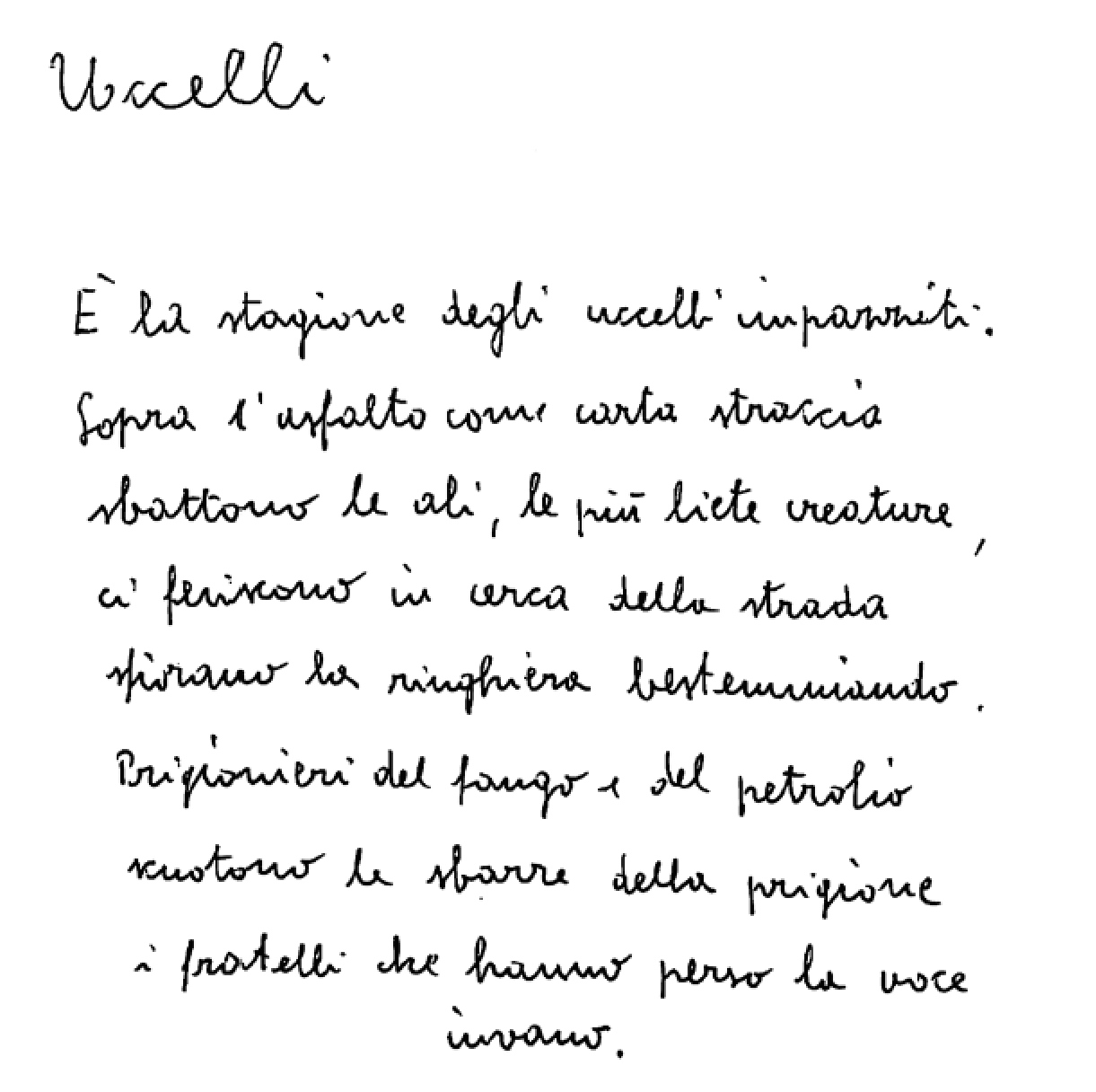


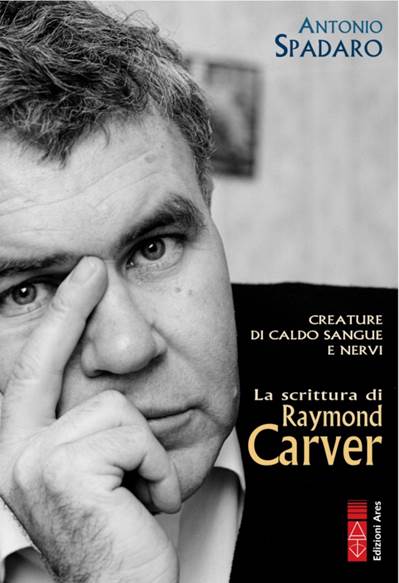 COMMENTO DI ANTONIO SPADARO
COMMENTO DI ANTONIO SPADARO






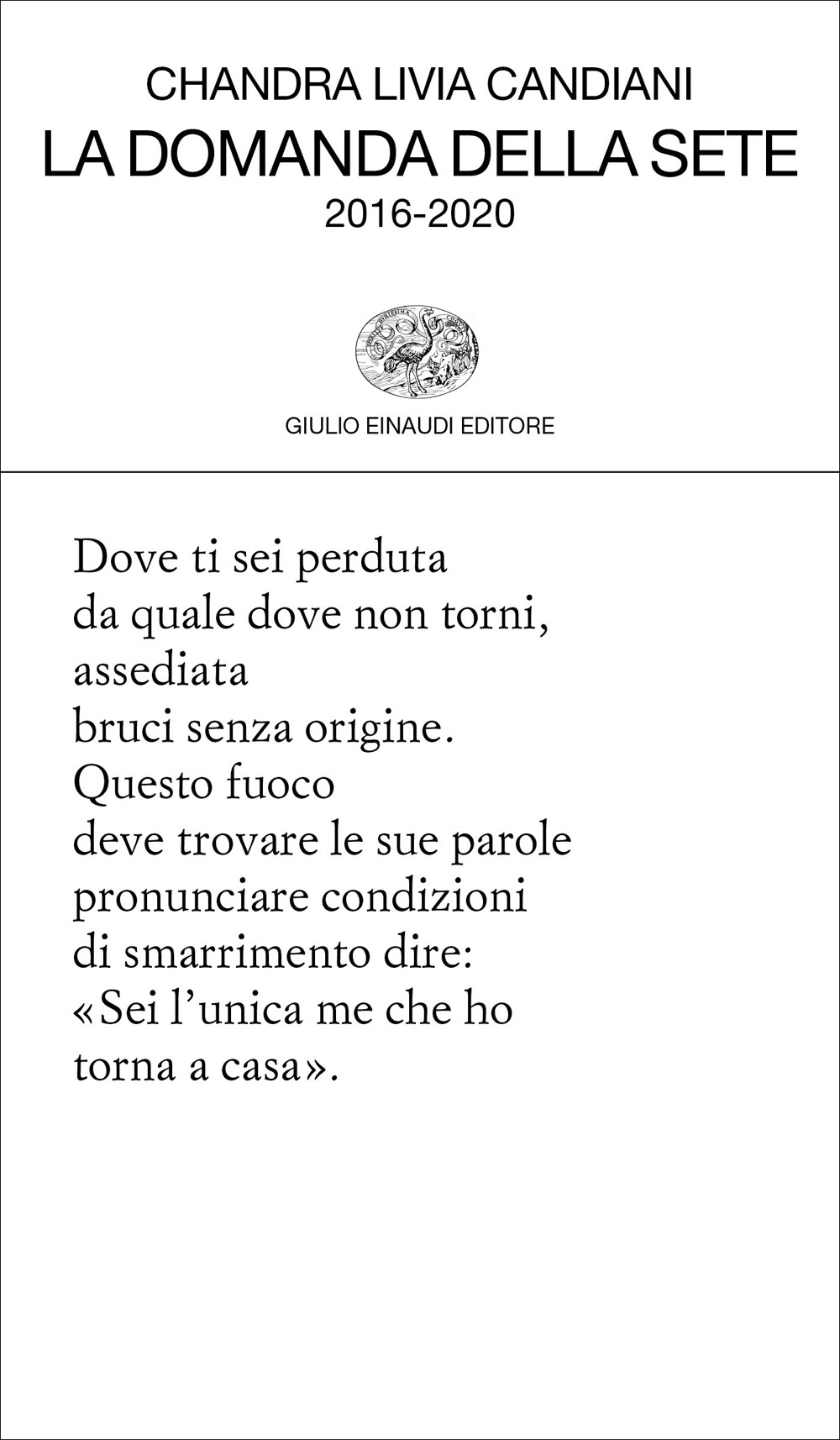

 RECENSIONE DI ALBERTO FRACCACRETA
RECENSIONE DI ALBERTO FRACCACRETA


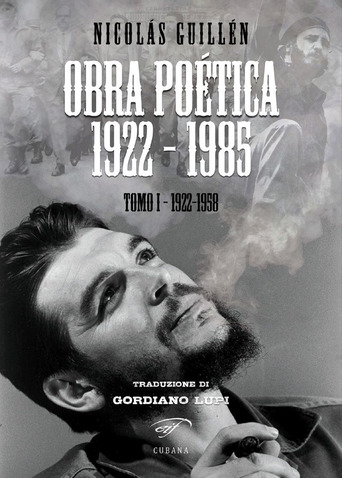
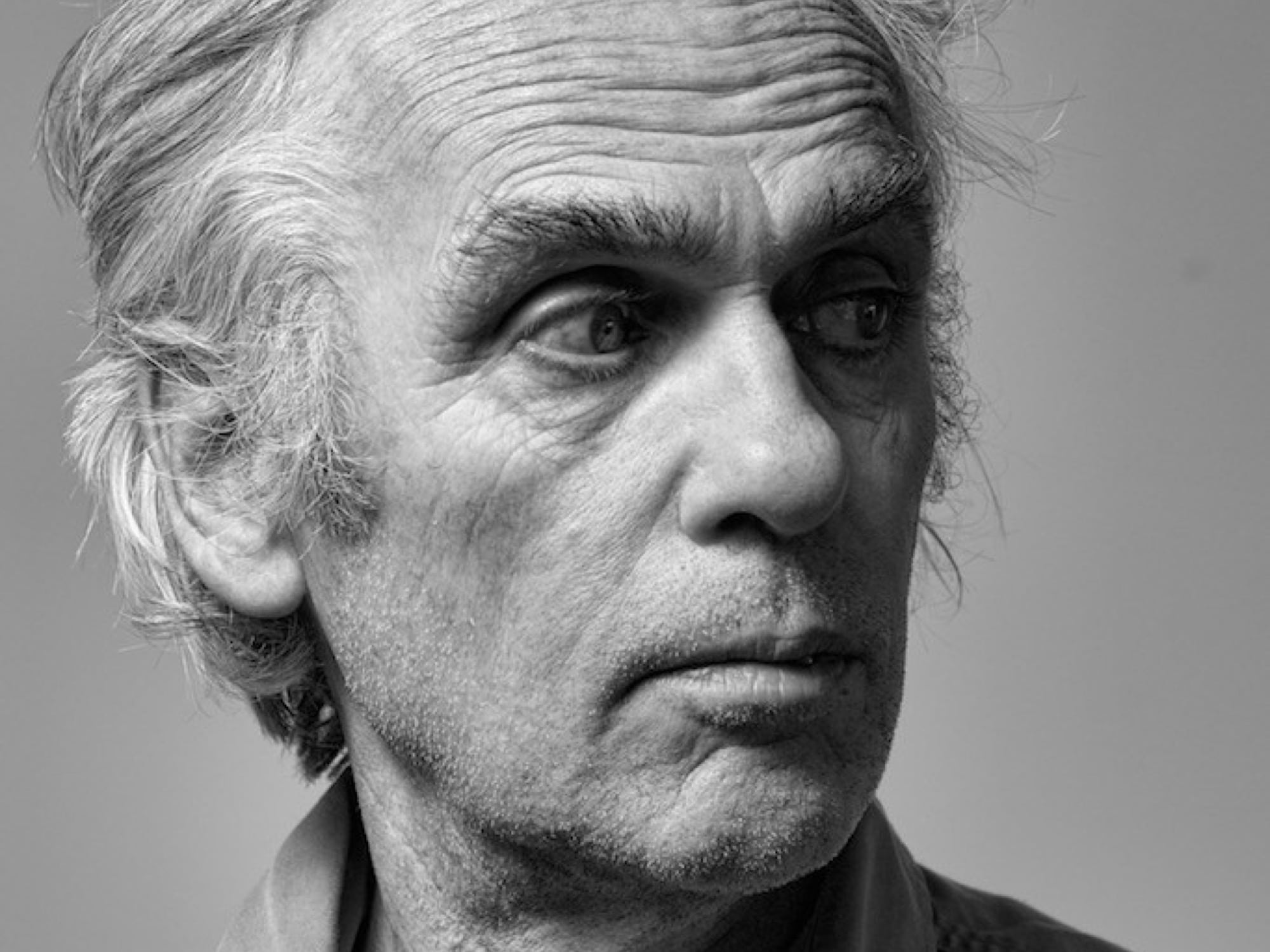

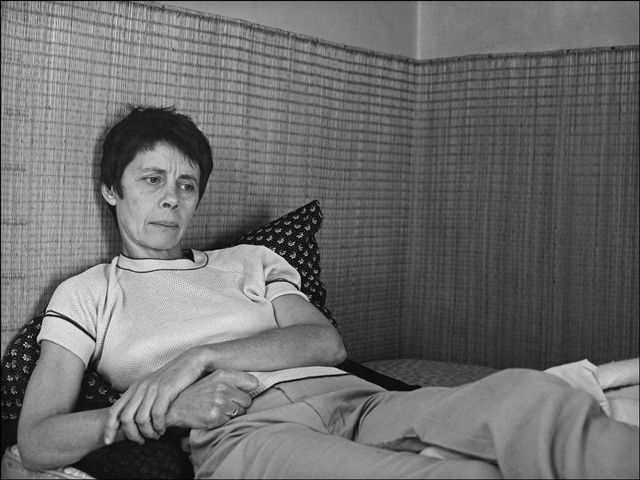

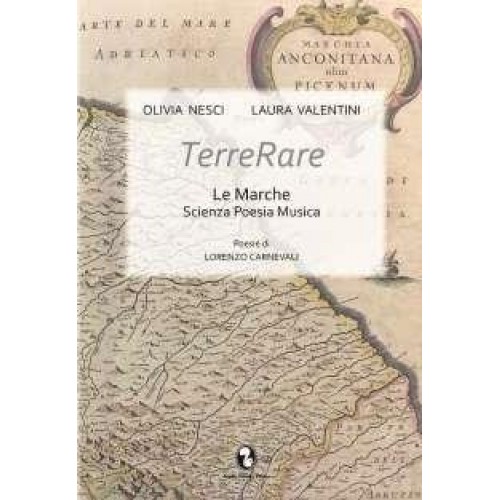

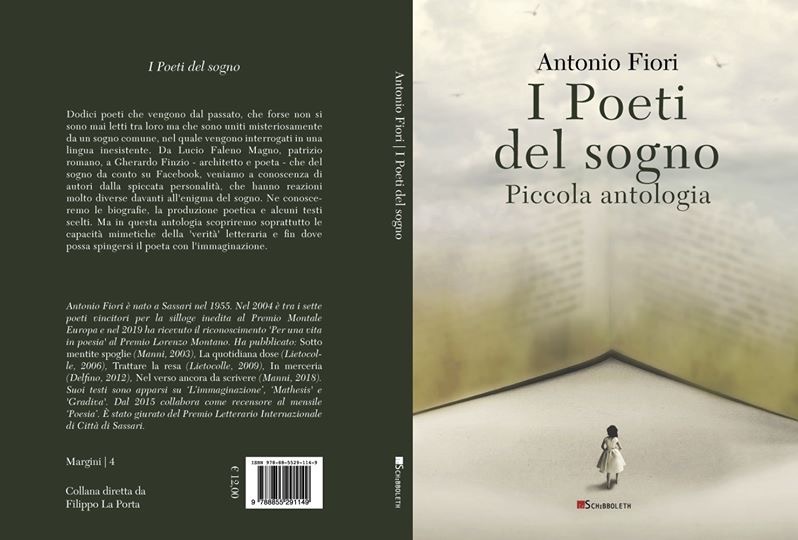


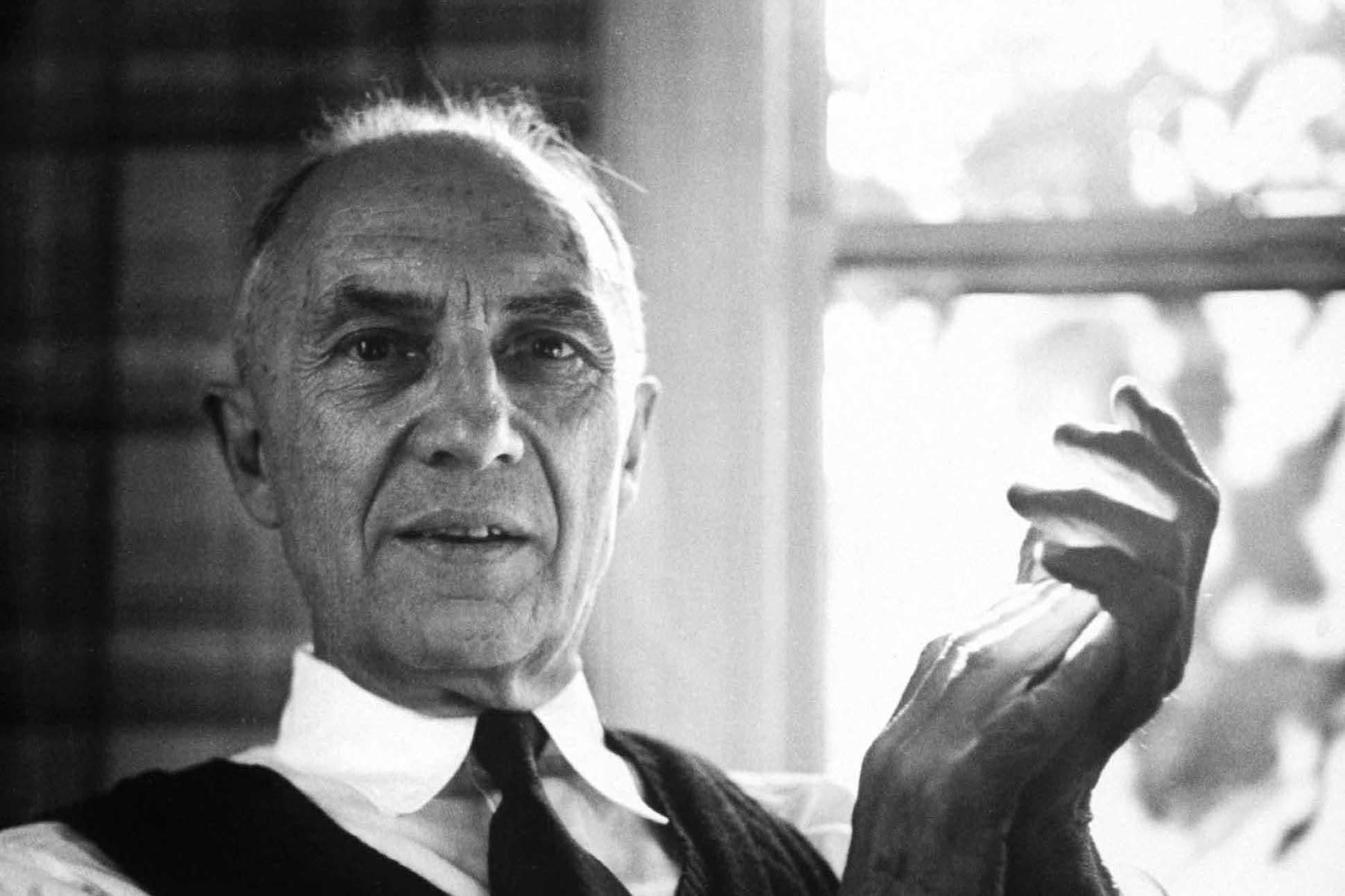

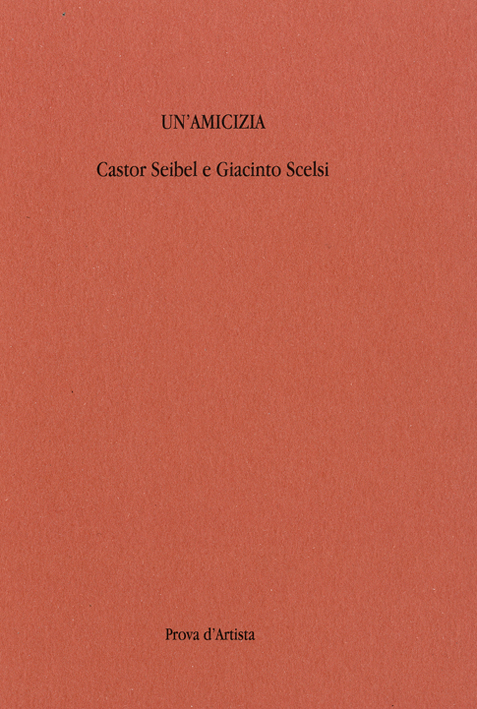



 Perché scrivere? Quale impulso muove da secoli l’uomo a narrare storie? È l’interrogativo da cui parte la riflessione di Franco Rella, facendo appello al bagaglio di letture accumulate nel corso della propria vita e interpellando gli autori che più lo hanno segnato. Da Dante a Cavalcanti, da Shakespeare a Benjamin, e poi Goethe, Kafka, Bataille, Roth, senza dimenticare i classici greci e latini, non esiste narratore che non si sia posto l’interrogativo e che non abbia cercato di spiegare – e spiegare a sé stesso – la realtà che ci circonda. L’esigenza di raccontare nasce proprio da quella realtà, e chi scrive può manipolarla, far interpretare la parte del protagonista a un personaggio di finzione, per poi rendersi conto che la protagonista assoluta della narrazione è la parola stessa, unica difesa che l’uomo abbia contro il male, unica arma capace di organizzare l’immagine del mondo e della realtà, come in un ideale inventario che raccolga tutte le esperienze vissute. Quella stessa parola che Pasolini suggeriva di usare con cautela, che per il solo fatto di portare con sé «un carico d’anima» legittima l’altrimenti insensata attività di scrivere.
Perché scrivere? Quale impulso muove da secoli l’uomo a narrare storie? È l’interrogativo da cui parte la riflessione di Franco Rella, facendo appello al bagaglio di letture accumulate nel corso della propria vita e interpellando gli autori che più lo hanno segnato. Da Dante a Cavalcanti, da Shakespeare a Benjamin, e poi Goethe, Kafka, Bataille, Roth, senza dimenticare i classici greci e latini, non esiste narratore che non si sia posto l’interrogativo e che non abbia cercato di spiegare – e spiegare a sé stesso – la realtà che ci circonda. L’esigenza di raccontare nasce proprio da quella realtà, e chi scrive può manipolarla, far interpretare la parte del protagonista a un personaggio di finzione, per poi rendersi conto che la protagonista assoluta della narrazione è la parola stessa, unica difesa che l’uomo abbia contro il male, unica arma capace di organizzare l’immagine del mondo e della realtà, come in un ideale inventario che raccolga tutte le esperienze vissute. Quella stessa parola che Pasolini suggeriva di usare con cautela, che per il solo fatto di portare con sé «un carico d’anima» legittima l’altrimenti insensata attività di scrivere.












 Dalla spiaggia scura del lago
Dalla spiaggia scura del lago