
Gerardo Masuccio
Gerardo Masuccio ha vinto il premio Struga Poetry Evenings 2022
Struga Poetry Evenings (SPE) (Macedonian: Струшки вечери на поезијата, СВП; tr. Struški večeri na poezijata, SVP) is an international poetry festival held annually in Struga, Republic of Macedonia.
La poesia e il disertore
Gerardo Masuccio
Discorso di accettazione del premio
Bridges of Struga
Agosto 2022
La letteratura mi ha salvato la vita. Tra una lettura e l’altra, tra una poesia e l’altra, tra un lavoro editoriale e l’altro, io fingo di vivere. Grandi autori del passato – più abili, più illustri di me – hanno affermato di essere nati per scrivere. Piacerebbe anche a me sostenere questa posizione, ma mentirei. Non sono nato per la letteratura. Io leggo, scrivo e curo i libri degli altri perché la vita, senza, mi si rivela in tutta la sua mediocrità. Eppure, per citare Leopardi, «non ho fin qui cagion di pianto».
Dal momento che il non-essere mi inquieta e, se mai si può prediligere ciò che non si conosce né si ricorda, non posso sceglierlo, e la vita – per così come la avverto in me e la percepisco negli altri – mi appare assurda e insignificante, fin da bambino ho scorto nella letteratura una via di fuga. Quell’istante della giornata in cui il sole non è ancora sorto, ma la notte è già un ricordo. Un’intersezione in cui nulla è ancora quel che è. Un limbo, un istante di tregua.
In altre parole, la letteratura è per me una scialuppa nel naufragio. Eppure, se quella via di fuga è salvezza per il naufrago cui sprofonda la nave sotto i piedi, se anche è sopravvivenza e quel naufrago le deve una riconoscenza infinita, non si può affatto pensare che un uomo parta per mare con l’obiettivo di imbarcarsi su una scialuppa. No, non posso dire di essere nato per la letteratura, ma posso affermare con certezza che la letteratura ha reso la mia vita possibile.
Pronunciate in questo tempio della poesia mondiale, qui a Struga, forse le mie parole fanno di me un disertore. I poeti che più stimo vivono per la propria poesia, la nutrono come fosse il nucleo pulsante di tutto ciò che sono. Quanto a me, devo confessare che non scriverei più e mi disfarei di tutto ciò che ho scritto se solo potessi abbandonarmi alla felicità senza più pormi le domande che il pensiero poetico alimenta in me, e che sento necessarie. Credo, insomma, che la mia poesia non nasca per descrive il viaggio esistenziale, ma per denunciarne l’inconsistenza. Un viaggio felice non contempla alcun ricorso alla letteratura.
C’è però una domanda cardinale che può forse riabilitarmi dalla diserzione. Mi è possibile coniugare consapevolezza esistenziale e felicità? Mi è possibile disfarmi della letteratura e, nel contempo, proseguire un’indagine sulla vita che non si fermi all’ovvio, alla pura superficie?
Per rispondere a questa domanda ho bisogno di osservarmi con gli occhi di un altro.
Mia nonna, nata nel corso della guerra, a pochi mesi dal tracollo del fascismo, mi avrebbe voluto religioso e devoto. Ha provato a crescermi così, in buona fede e con amore. Oggi, però, non sono affatto un uomo religioso. Coltivo la mia spiritualità e non rinvio ad altre dimensioni e ad altri tempi quelle domande esistenziali a cui non trovo risposta. Una fede solida mi avrebbe reso un uomo felice, ma i dogmi avrebbero stemperato una ricerca esistenziale tenace.
Mio padre, nato negli anni ruggenti del boom economico italiano, avrebbe desiderato che mi impegnassi attivamente nella società, che investissi la mia intelligenza qui e ora. Oggi, però, non sono affatto un animale politico. Mi tengo informato, seguo il dibattito pubblico, rifletto sui temi sociali ed economici all’ordine del giorno.
Credo, tuttavia, nell’impotenza umana, nei corsi e nei ricorsi storici. Solidarizzo con la vittima, ma scorgo nei suoi occhi il mancato carnefice; condanno il carnefice di oggi, ma non mi sfugge la vittima che è stato o che sarà, chissà dove, chissà quando.
Mi sento responsabile di ogni efferatezza umana, in ogni piccolo gesto, anche quando pranzo o accendo la luce: il mio pasto è la fame di un altro; la mia vista è il buio di un altro. Non posso perseguire la giustizia se avverto che la mia prima colpa è esser nato e che ai torti che il nascere innesca non c’è equa soluzione.
La lotta politica avrebbe assorbito tutte le mie energie, mi avrebbe reso un uomo più sereno, ma i filtri sulla realtà che ogni credo impone avrebbero appannato una ricerca esistenziale nitida.
Mia madre, nata nei primi anni settanta, in un’epoca in cui tutto ha assunto il valore del proprio corrispettivo economico, avrebbe voluto che io diventassi un avvocato.
Per un periodo si è illusa che l’avessi assecondata, ma io ho studiato giurisprudenza senza ambizioni di quel tipo. Con dedizione, sì, ma spinto da valori alti che non sono precipui per la giustizia umana.
Non mi animavano i codici e le procedure, ma le parole di Euripide e di Dante, di Dostoevskij e di Deledda: il delitto e il castigo, la causa e l’effetto, il peccato e la grazia. Non i processi, non i contratti. Una brillante carriera forense mi avrebbe assicurato prestigio sociale e immediata solidità economica. Ma, calato nel mondo come ogni burocrate deve e sazio della pienezza di chi non vede oltre il secolo umano, avrei trascurato ogni spinta esistenziale più profonda.
In quel che mia madre, mio padre e mia nonna hanno considerato il tutto, fin da subito ho avvertito la carezza del nulla. Dio, la patria, i valori civili, la ricchezza e il prestigio sociale. Ho scoperto il vuoto in ciò che riempie la vita di altri. Continua a leggere→

 Continua a leggere
Continua a leggere


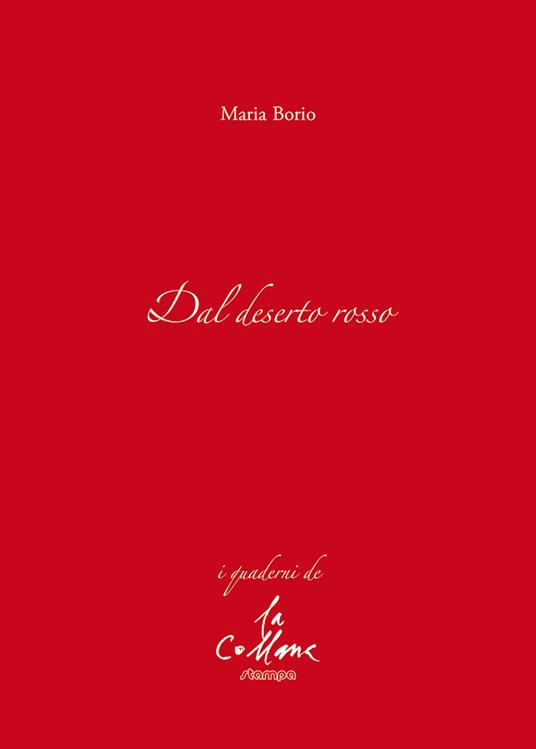

 La sua narrazione esprime un forte disagio sociale che vivono alcune donne oggi all’interno della famiglia. Anche se le madri che uccidono i propri figli ci sono sempre state e infatti i suoi racconti sono ambientati in epoche differenti. Essere madre oggi come ieri è una responsabilità che incombe principalmente sulla donna nella relazione con il figlio, ma anche con il marito, o con il proprio compagno. Ci sono donne che hanno una storia difficile alle loro spalle, non sufficientemente elaborata dalla donna stessa, altre donne, invece, quelle che hanno avuto la possibilità di elaborare il proprio vissuto riescono nella maternità perché non riflettono sui figli i propri fallimenti, la propria autodistruzione. Insomma il figlicidio può celare il dubbio che la responsabilità non sia soltanto delle madri che lo commettono ma anche della società che ha inculcato loro di dover essere madri a tutti i costi?
La sua narrazione esprime un forte disagio sociale che vivono alcune donne oggi all’interno della famiglia. Anche se le madri che uccidono i propri figli ci sono sempre state e infatti i suoi racconti sono ambientati in epoche differenti. Essere madre oggi come ieri è una responsabilità che incombe principalmente sulla donna nella relazione con il figlio, ma anche con il marito, o con il proprio compagno. Ci sono donne che hanno una storia difficile alle loro spalle, non sufficientemente elaborata dalla donna stessa, altre donne, invece, quelle che hanno avuto la possibilità di elaborare il proprio vissuto riescono nella maternità perché non riflettono sui figli i propri fallimenti, la propria autodistruzione. Insomma il figlicidio può celare il dubbio che la responsabilità non sia soltanto delle madri che lo commettono ma anche della società che ha inculcato loro di dover essere madri a tutti i costi?  Da Poesie di Vera Lùcia de Oliveira
Da Poesie di Vera Lùcia de Oliveira





 Nota
Nota [Nota a Margine ]
[Nota a Margine ]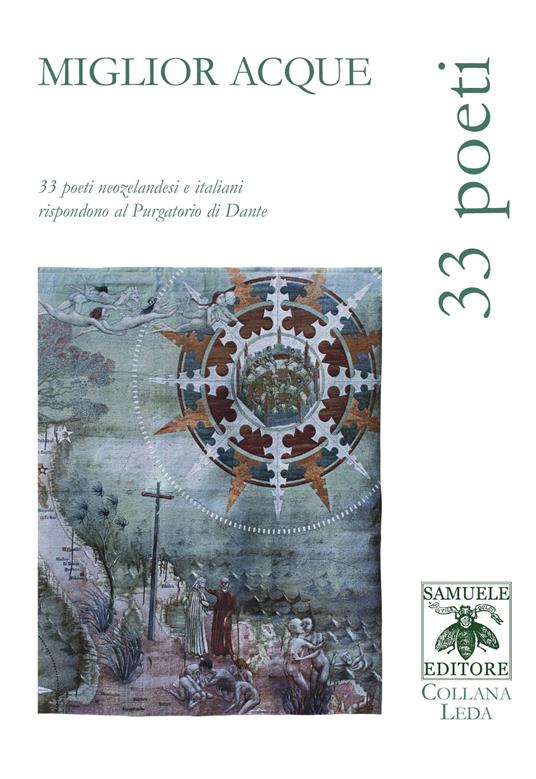


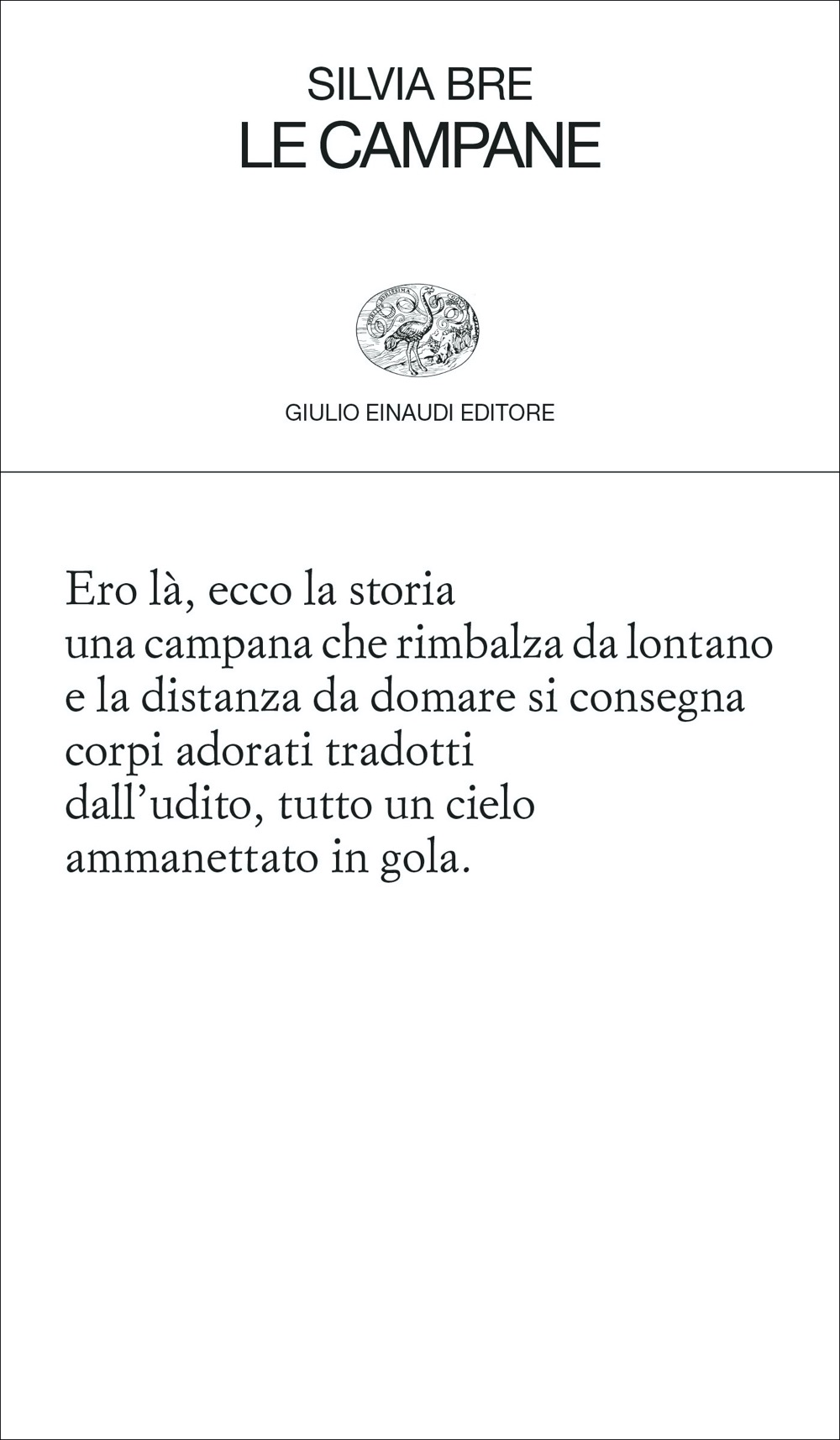



 Finiscono qui i legami tra The Hill We Climb e la Bibbia? Certo che no. Se strizziamo i versi, notiamo che gocciolano di sintagmi, parole-tenda, elementi morfologici i cui detergenti e additivi sono Vecchio e Nuovo Testamento. Ecco una rapida carrellata: «Nasce il giorno» (nell’originale «When day comes») corrisponde a Giovanni 14,20 «When that day comes», secondo la Bibbia di Re Giacomo fruibile in USA; nella formula idiomatica «il ventre della bestia» allignano Giona 2,1 «Giona restò nel ventre del pesce» e Apocalisse 13,1 «vidi salire dal mare una bestia»; l’«unione perfetta» richiama 1Corinzi 1,10 «siate in perfetta unione di pensiero e di intenti»; «alziamo i nostri sguardi non / su ciò che si frappone tra noi» è parallelo a 2Corinzi 4,18 «perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili»; in «un’ora di così grande terrore» riecheggia Luca 22,53 «ma questa è l’ora vostra e il potere delle tenebre». Si va avanti a lungo smerigliando la Genesi, Geremia, la Lettera ai Romani. Ma facciamo soltanto due esempi che riguardano la chiusa.
Finiscono qui i legami tra The Hill We Climb e la Bibbia? Certo che no. Se strizziamo i versi, notiamo che gocciolano di sintagmi, parole-tenda, elementi morfologici i cui detergenti e additivi sono Vecchio e Nuovo Testamento. Ecco una rapida carrellata: «Nasce il giorno» (nell’originale «When day comes») corrisponde a Giovanni 14,20 «When that day comes», secondo la Bibbia di Re Giacomo fruibile in USA; nella formula idiomatica «il ventre della bestia» allignano Giona 2,1 «Giona restò nel ventre del pesce» e Apocalisse 13,1 «vidi salire dal mare una bestia»; l’«unione perfetta» richiama 1Corinzi 1,10 «siate in perfetta unione di pensiero e di intenti»; «alziamo i nostri sguardi non / su ciò che si frappone tra noi» è parallelo a 2Corinzi 4,18 «perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili»; in «un’ora di così grande terrore» riecheggia Luca 22,53 «ma questa è l’ora vostra e il potere delle tenebre». Si va avanti a lungo smerigliando la Genesi, Geremia, la Lettera ai Romani. Ma facciamo soltanto due esempi che riguardano la chiusa. 


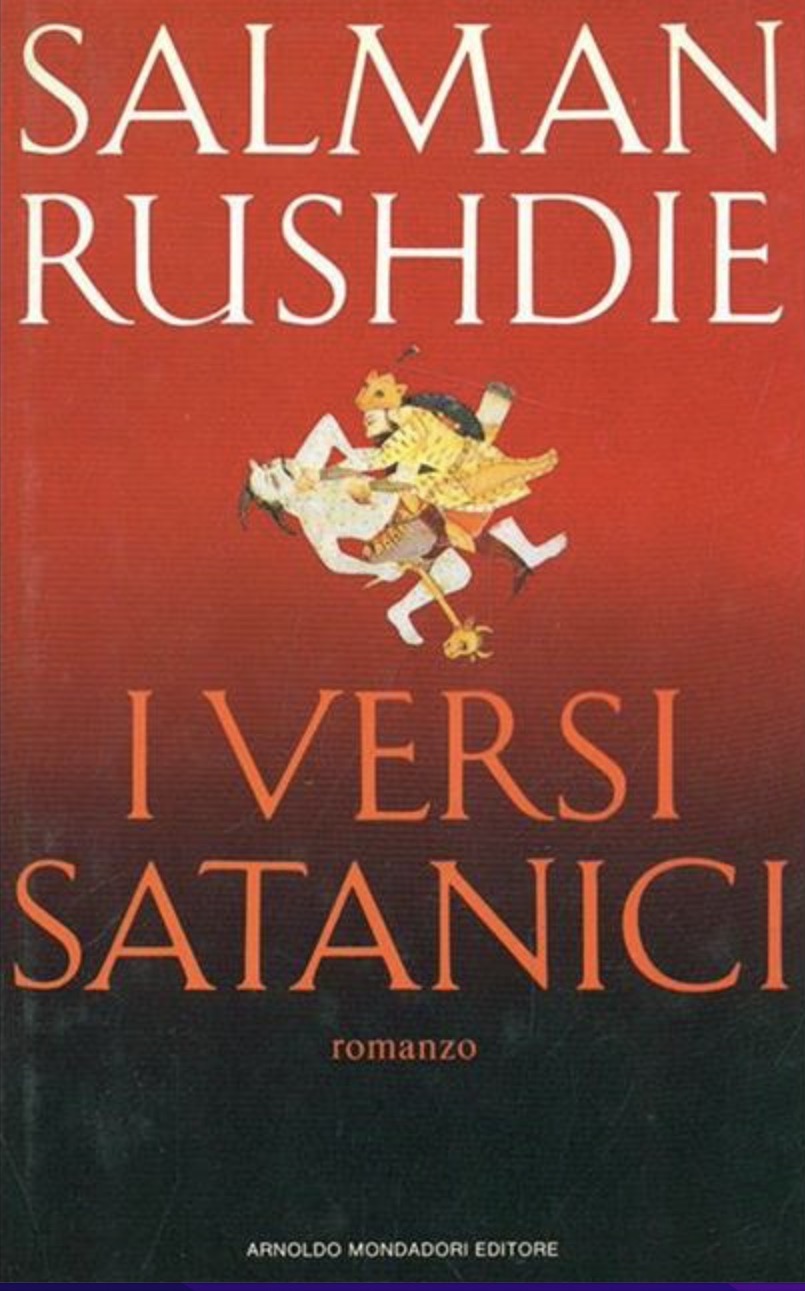 La Fatwa emessa nel 1988 dall’ayatollah Khomeini è piombata su di lui a causa del suo romanzo “I versi satanici” pubblicato in Italia da Mondadori.
La Fatwa emessa nel 1988 dall’ayatollah Khomeini è piombata su di lui a causa del suo romanzo “I versi satanici” pubblicato in Italia da Mondadori.










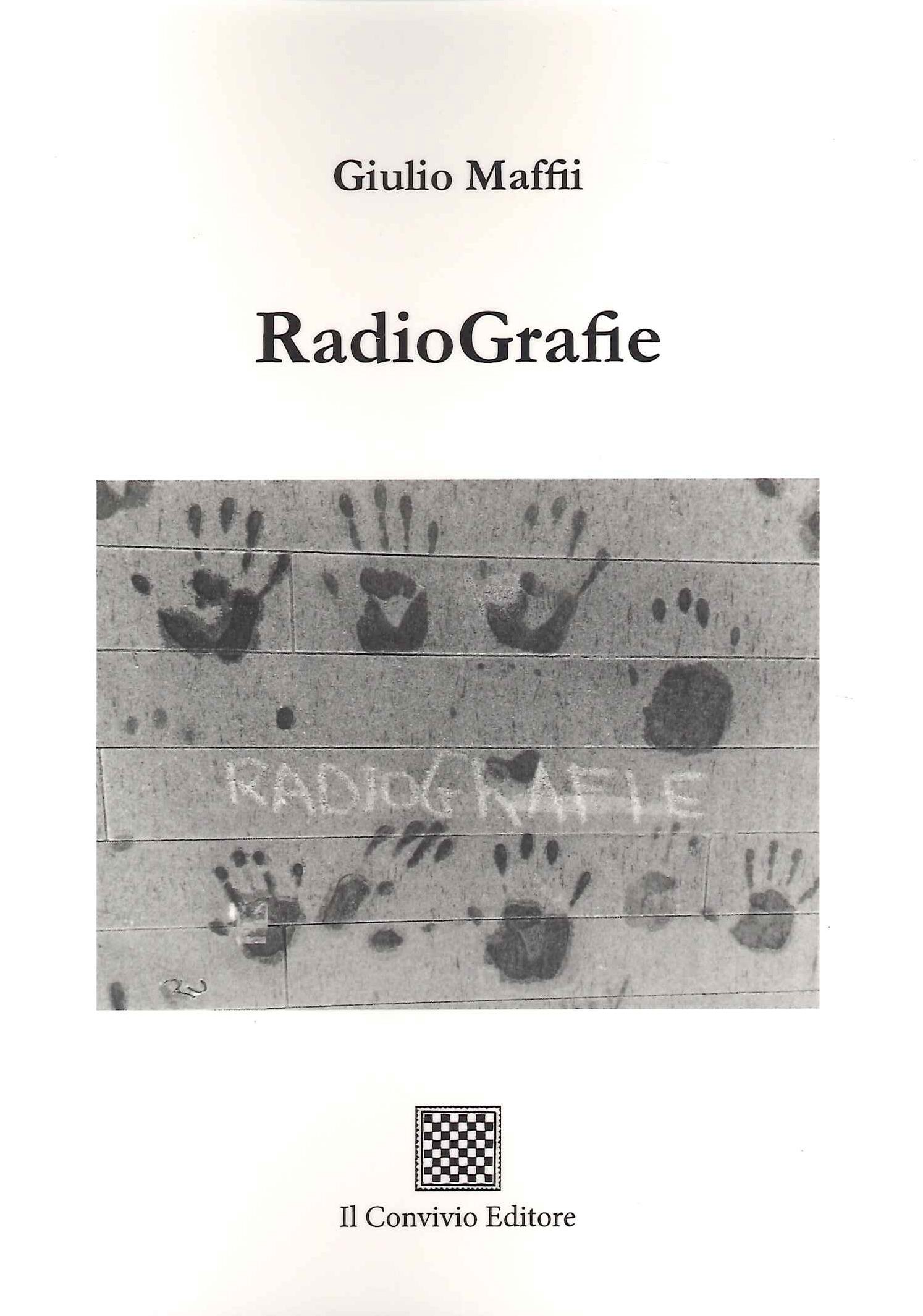

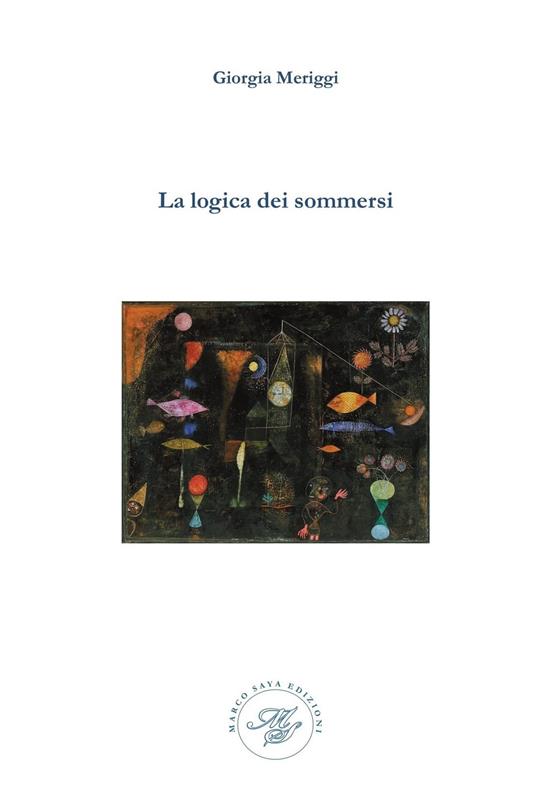

 Intervista a Innocenzo Odescalchi
Intervista a Innocenzo Odescalchi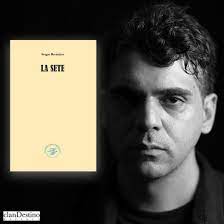 Vieni,
Vieni,




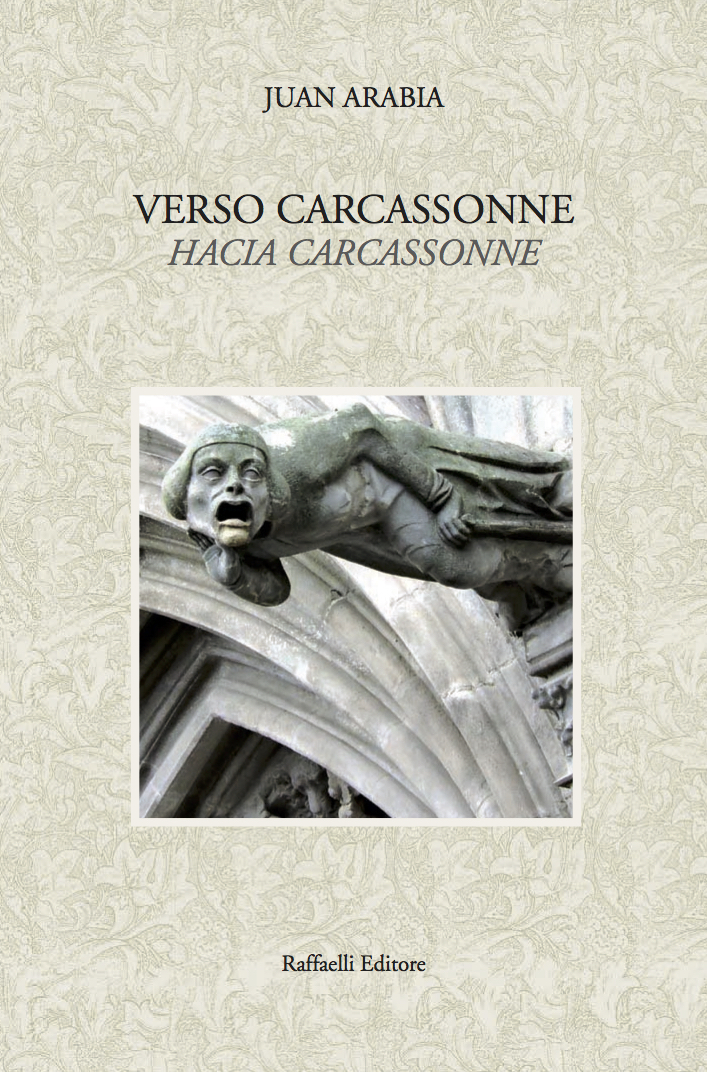









 COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO STAMPA