
Gino Scartaghiande, marzo 2023 (foto di proprietà dell’autore)
di Luigia Sorrentino
Nel 1977 l’uscita dell’opera di Gino Scartaghiande, Sonetti d’amore per King-Kong, nato a Cava de’ Tirreni (Salerno) nel 1951, rappresentò uno spartiacque nella poesia italiana del Novecento. Un poema stilisticamente audace per quei tempi che molti accolsero come un evento. A distanza di oltre quarant’anni Graph Editore ripropone i Sonetti, con l’aggiunta di alcune poesie inedite.
Fonti del Kong
di
Gino Scartaghiande
Sonetti d’amore per King Kong sono un fenomeno non circoscrivibile in una data realtà storica, tantomeno in una decade. A rigore, rifacendomi ad Husserl, il fenomeno non ha niente a che fare con la realtà; esso è, rispetto all’arte, quella “inconcepibile mezza sfera mancante” a cui, come dice Beppe Salvia in Idea cinese, l’arte stessa “deve assoggettare la propria rappresentazione”, altrimenti “diventa genere. oggetto di culto”. Ed infatti è proprio da questa lontananza dalla realtà del fenomeno che la poesia riesce a darci oggetti precisi con cui comprendere e preservare l’intero Lebenswelt umano. E anche io, per quanto mi riguarda, credo che proprio la poesia in quanto fenomeno, dacché mi ha da sempre estraniato dal mondo, mi abbia poi aperto la vera via per poter questo stesso mondo incontrare ed amare fin dal di dentro della sua Storia, o proprio mettendomici sotto, come una talpa.
Il decennio post-sessantottesco è stato senz’altro tragico, per me studente universitario nel quartiere di San Lorenzo a Roma, durante i cosiddetti anni di piombo. Eppure eravamo aggrappati a questo fenomeno-poesia come oggetto reale, non solo io, ma tutta una schiera di poeti prima e dopo Pasolini, da Amelia Rosselli a Beppe Salvia, che hanno saputo superare, con enorme sacrificio di sé stessi, quell’assentificazione del fenomeno operato dalla poesia ermetico-idealista in cui si era venuto a dilatare l’occulto nichilismo liberal-romantico di Manzoni – si veda sull’argomento il libro-pamphflet di Aldo Spranzi L’altro Manzoni, Ares, 2008 – ovvero la mistificazione di una letteratura che, perdendo di vista il proprio oggetto fenomenico, diventa mero esercizio di stile, o di estetica, denotante una sostanziale mancanza proprio di quello stesso fenomeno cui avrebbe dovuto annunciare.
Il caso del romanticismo e dello storicismo di Manzoni è emblematico, e la questione è fondamentale per comprendere la catastrofe che si apre dopo l’altissima cifra classica di Foscolo e di Leopardi, e il conseguente precipitare di tutta l’epoca nell’ideologia positivista. Se ne avvidero Pascoli e Carducci, e corsero ai ripari, ritrovando il fenomeno oggettivo della poesia, e con esso soltanto, una lingua ed uno stile veritieri. “C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole” ci apre all’ “altrove” del fenomeno, e il “Né io sono per anche un manzoniano” sono parole pur troppo vere, dette quasi per celia da uno che aveva in epoca positivista vissuta la tragedia della messa a tacere di una origine fenomenica della lingua, che era invece ancora così naturalmente presente, in quanto tale, nei suoi avi meno remoti, e che il poeta fa d’un tratto balzare ai nostri occhi, nell’incontro di nonna Lucia con lo scaturire celeste dei giovani-cipressi “alti e schietti”. Non anche forse da quel “T’amo, o pio bove” carducciano sarà derivato il “Ma io / t’amo King Kong” dei Sonetti (pag. 28, Graphe.it Edizioni, 2023) e “Da la larga narice umida e nera” quel “Vieni con la narice dilatata” (ibidem). Come se un poeta prima di me mi avesse dato una plausibile zattera di salvataggio su cui salire. Mancando di questo oggetto fenomenico reale, l’arte non conforma nessun atollo di libertà per l’umanità, e anzi la conculca, per sostentare il mito-idolo di sé stessa. La catastrofe manzoniana si allargherà poi in quella del nostrano idealismo ermetico, con tutti i loro inani tuffi pitagorici in non si sa quale eternità se non in quella di una vanagloria mondana. Se ne ritrarranno in tanti, come dall’orlo di un abisso, consapevoli del maltolto… di “quanto ha roso il ferro della notte” Beppe Salvia (Canzone d’estate). Rebora che si ritirerà a Domodossola, Campana che scolpirà un suo sentiero di solitudine fino a La Verna, Antonia Pozzi che nell’antivedere di una nebbia, realizzerà il suo concreto oggetto fenomenico di poesia.
Il fenomeno della poesia è unico ed eterno in tutti i tempi e luoghi, e costituisce esso da solo tutta la tradizione. In questo fenomeno, o zona, se vogliamo dirlo con Apollinaire, si entra e ci si incontra all’istante con tutti i poeti di sempre in quanto persone vive, pur non avendoli mai prima conosciuti, e neppure mai letti. Sono essi stessi che ci vengono incontro e che ci prendono per mano. Essi ci donano le parole con il più alto grado di perfezione, ed è già un’altissima degnità per noi farne memoria. Così, in un percorso di conoscenza, mi è venuto incontro con il suo “Como smarrito sì vo per la via” Jacopone da Todi (Laude 89, v 127) mentre scrivevo “Come smarrito su di una strada” (ivi, pag. 36), e, dalla stessa laude, v 143, “scendemmo, saglio, tegno e so’ tenuto”, ed io “salgo, scendo gradini. Dappertutto” (ivi, pag. 45); o anche da Le aureole di Corazzini “Sei triste, mi dai pena / questa sera […] Che hai?” (Spleen, v 14-16) per il mio “sei triste stasera, sai cosa significa?” (ivi, pag. 27). Ma a volte basta anche un solo accento, una sola parola, come in questo “Te Campo” (Catullo, 55, 3) che mi si fa presente in un “Tu campo di / viaggi, campo di stasi” (ivi, 57).
Nessuna critica dunque di fronte al fenomeno, nessuna ermeneutica, se non il nostro confessarcene debitori. Il cosiddetto Anonimo del Sublime di fronte al fainetai trinitario di Saffo, “A me sembra pari agli dei colui che accanto a te siede”, viene rapito in estasi anch’egli, e tace, e ci rimanda solo il testo-fenomeno. Come tra i più splendidi oggetti reali di poesia. Se ne fa diacono, e anche doulos, ovvero servitore.
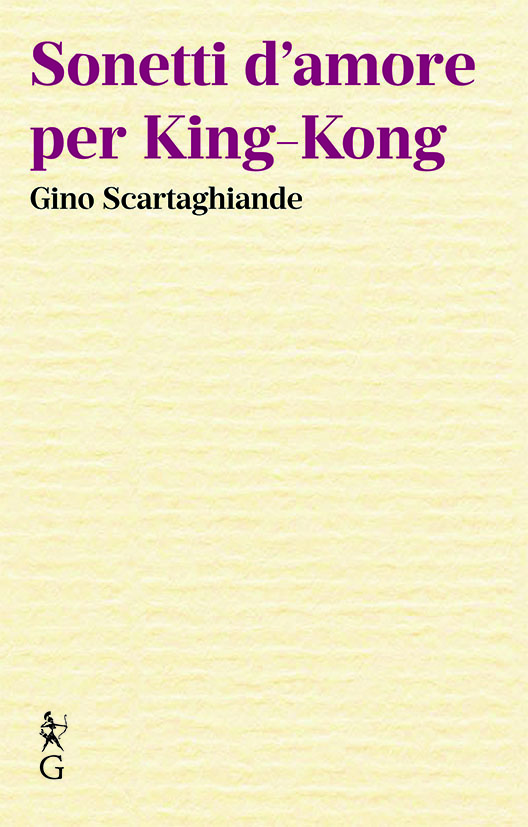
UN ESTRATTO DAL LIBRO
Il nome
I
Frantumazione di cristallo assorbita dal
corpo, schegge, relitti, aspre punte di vetro
inseguenti il loro metabolismo dentro le
braccia. Ancora disteso sul letto, con lo
spavento che incomincia a precipitare dalle
fenditure, dai vuoti delle finestre. Il nero
oleoso, impossibilmente denso, invade la stanza.
M’invade, copre tutto, assorbe tutto. Congloba
tutto. Tutto in effetti già conglobato da sempre.
Se la stanza, la tua stanza, non è più. Non è
mai stata; se non lo stesso nero universo
oleoso; ondulante. Mare che volge e rivolge
la sua sabbia nera: granellini coinvolti
nelle miriadi di combinazioni.
Ora sai bene, lo sai per certezza: il mare
d’acqua azzurra non esiste, non esiste il
cielo azzurro, non esistono le pareti azzurre
della tua stanza e nemmeno i vetri, i frantumi
di vetro, e le finestre.
L’esistenza non ha di queste topografie.
L’esistenza è oltre lo schermo di una
stella che brilla, oltre il polarizzante
cerchio d’oro del sole. L’esistenza non
è dedita allo sfruttamento della morte.
Coltiva questa frantumazione vetrosa
all’interno di te. Frantuma i milioni
di finestre divisorie, lascia che lo sfaldamento
prenda luogo dove entra l’esistenza.
So di certo chi sei, chi sono. L’asfalto
grigio della strada. Il tuo sangue sull’
asfalto penetratomi sin d’allora. E so
che altre strade dovrò ancora assorbire,
altro vetro frantumare, prima di poter
pronunciare il tuo nome, che sarà anche mio
e infine nostro. Ti chiamerò Rosa Luxemburg.
Mi darai il nome.
Ti chiamerò mentre ti uccideranno. Sarà
come ricevere una tua lettera d’amore.
Dovrò meritarla. Ora ancora no.
I gradini scorrono lontano, fuggono come
tastiere di pianoforte, fuggono in tutte le
direzioni. Non so se muovermi coi piedi o se
affidarmi all’ascolto. Ma devo assolutamente
trovare il punto ove tutti i gradini e
tutte le voci confluiscono. Un foglio
trasportato dal vento, un grido d’aiuto
basterà?
Ora. Sono pronto a barattare ogni cosa
per questo incontro. E vedo talmente bene
il nero che cola sui gradini. Anche dagli
occhi, anche gli occhi che vedono colano
nero, come assassini che complottano,
che attentano.
Sono pronto. Ma non ancora in stato di grazia.
Cara Rosa, oggi è stata una
giornata piovosa, ma stasera il cielo
era sgombro e c’erano le stelle.
Sento di svegliarmi, non so ancora
dove. Con ostinata certezza percorro
tutte le ferrovie della terra.
Morire è un lusso che non possiamo permettere
né alla fantasia né alla pratica quotidiana.
E soprattutto a quest’ora di notte, nella strada
così nera e deserta, col silenzio gravido
che vorrebbe scoppiare in fragorosa giornata
d’estate, con bagnanti al mare e bambini
che giocano, mare che volge e rivolge
la sua sabbia nera: granellini neri
coinvolti nelle miriadi di combinazioni.
Ora sai bene, lo sai per certezza:
il mare d’acqua azzurra non esiste.
Il ritardo assunse toni fatali. Erano
esattamente 5 giorni d’assoluto silenzio.
Muti io e lei. Neri e muti. Da 5 giorni
seduti al tavolino del bar, bevendo un caffè
che non finiva mai, 5 giorni oscuri come 10
notti. Vestiti di una pesante e appiccicosa
calzamaglia nera, sentimmo il turbamento
di una rondine su di un umido filo di
telegrafo, prima di partire, in autunno,
giornata piovosa, quasi sera. E un’altra
rondine sul filo opposto.
Se ora ricominciassi dagli occhi. Permettetemi
di dirvi questo: grappoli di pipistrelli
maturavano assiepati sui miei occhi,
poi gonfiavano sonnolenti e scorrevano
giù a formare pozzanghere.
Erano già 5 giorni. Le pozzanghere
aspiravano a diventare mare. Rosa divaricò le
cosce e pisciò per molto tempo. Si sa che
il pianto è cosa diversa. Ma io non ho mai
più visto nessuno pisciare tanto e così bene
e per così lungo tempo. E permettetemi di
dire anche questo: l’amore che ho per Rosa
non è diverso da quello che ho per i poeti.
5 giorni equivalenti a cinquemila anni
d’attesa proiettata nel passato. Berlino
aveva la presunzione della cosa aspettata
e venuta, la superbia di un avvento cristiano,
come un orologio che puntualmente scandisca
secondi e minuti. Ma Berlino con le sue case
da manicomio aveva anche l’impaccio dell’evento
verificatosi senza la precedente attesa. Nascita
non desiderata, Berlino aspettava ancora d’essere
stata attesa; la presunzione che aveva, i campi
di concentramento e le questioni razziali
con cui si imbellettava erano solo momentanee
distrazioni dal pensiero di non essere stata
necessaria, un po’ come le altre città
sparse per il globo.
ho anch’io come Berlino l’impaccio
dell’evento verificatosi gratuitamente
e da circa un miliardo d’anni
aspetto d’essere stato atteso
Le strade enormemente deserte. Il bar deserto.
Tranne noi due e il tavolino e le nostre due
sedie e due tazze di caffè. Gli assassini
avevano nell’aria presente la loro realtà
di fantasmi, ma non era un incubo. Era una
tranquilla gravità oscura. Per le strade
dilagavano pozzanghere di pipistrelli
suicidi e fiotti d’orina.
In quel momento Rosa fu ferita da uno
degli assassini. Non smise di pisciare,
ma io ebbi paura che morisse prima di
potermi parlare. L’assassino le si avvicinò,
era una comune faccia intravista al supermarket,
le diede una scossa leggera, lei cadde.
È triste starsene seduto ad un bar con
la sensazione che la nostra persona
non colmi nessun vuoto dell’attesa cosmica.
Per questo sappiamo che tutte le nostre sciagure
si collocano nel passato e che il futuro
non potrà portarci che dei miglioramenti.
Sappiamo benissimo però che tutto ciò
è anche falso.
La vidi mentre cadeva, mentre l’assassino
cercava di tamponarle la vulva che continuava
ad emettere fiotti d’orina nera. Poi vidi l’
assassino rinunciare. Lei capovolta con le
cosce divaricate, le braccia rilasciate.
La sedia vuota. Lei che andava e veniva
sull’onda morta dei pipistrelli impoltigliati
d’orina. La sedia vuota. Il caffè e la tazza
navigavano già lontano in una traversa
sinistra della strada principale. Il cucchiaino
restato nel piattino, sul tavolo. Mi sentii
nudo, senza neppure l’involucro di pelle,
sentii l’aria tagliarmi i muscoli e vidi
il sangue nero gocciolarmi dappertutto. E
pensai a qualcosa d’azzurro.
Divenni estremamente debole.
Feci in tempo a posare il mio caffè sul tavolo,
cadendo vomitai briciole di vetro sul piede
sinistro di Rosa. Temetti di morire prima di
poter ascoltare ciò che lei aveva da dirmi.
I miei occhi, strano a dirlo, piansero ancora
di più, m’aggrappai disperatamente ai piedi
di Rosa, le strade erano completamente allagate,
i nostri corpi venivano trasportati lontano,
ricordo che prima di svoltare a sinistra
vidi una luce accendersi all’interno del bar.
Una volta, alcuni anni prima, a Mantova e
a Verona, in due bar deserti successe la
medesima cosa che a Berlino. Impressionante
l’identità degli assassini e delle loro
azioni. Oscura è restata l’identità
delle vittime.
Saremmo affogati? Affogati nei neri prodotti
della nostra decomposizione? O era un modo
diverso di resurrezione, una maniera di dire
– NO! – agli assassini?
Dal suo interno Rosa si svuotava sempre più,
fegato ed ossa marce prorompevano fuori dalla
vagina. All’esterno la pelle restava meravigliosamente
tesa e delicata. Io aggrappato alla pelle del suo
piede sinistro avevo terminato la consunzione d’
ogni mia fibra. Di me restavano pochi milligrammi
di polvere di calcio fosforoso sull’alluce
sinistro di Rosa, il resto completamente
sminuzzato fino all’atomo andava girovagando
in quella strana marea di notte berlinese
insieme agli atomi di lei, poiché anche di
Rosa non era restato che un millimetro di
pelle sull’alluce sinistro dove io poggiavo
il mio ultimo milligrammo di fosforo.
Era un modo altrettanto bello d’amarsi.
Non il cazzo che viene a porre la sua
prepotente eiaculazione in una delle quattro
cavità del cuore, e nemmeno un braccio che
rovistasse l’utero con la mano pronta a
ghermire ovaie.
Insomma io e Rosa non avemmo bisogno
di fedi nuziali e nemmeno di vivere
nella stessa metà di secolo, non avemmo
bisogno di questi trucchi per amarci.
Saremmo affogati? Berlino, Mantova e Verona
coi loro supermarket pieni d’assassini
in miniatura ci avrebbero soffocati,
avrebbero posto fine alle rivoluzioni,
esigevano altre catarsi d’angeli?
Una sera d’estate Rosa mi fece capire
che sarebbe stato utile e bello parlare
con un geranio perché si perde la maggior
parte del tempo a parlare con fiori stupidi.
Ah! il piccolo grumo di calcio fosforoso
si dissocia e il millimetro di pelle
si disintegra allontanandosi e grido che
non voglio essere lasciato
Ah! i nostri miliardi d’atomi vaganti dentro
oscure galassie, i nostri miliardi d’atomi
solitari non s’incontreranno mai, le
probabilità sono alquanto esigue, mia
Rosa, mio amore, non potrò mai bere
un caffè con te
Ah! il nero, il nero, il nero. Ho perduto
le mani e il viso. Ho perduto tutto
il mio corpo
Ah! più niente. Solo il nero.
Non ascolteremo amici, non ascolteremo,
sappiate che le nostre due orecchie
se ne sono per sempre andate. Io
non sto dicendovi niente e non vi
vedo, come voi non potete vedermi.
Qualche volta viaggiando all’interno del
nero ho creduto di sfiorare i vostri
cuori, ho creduto di poter raggiungere
con essi la compenetrazione illuminante.
I vostri cuori mi sorrisero come dei
ciechi, se mi avessero visto avrebbero
capito che io portavo solo notte.
Due miliardi d’anni fa la nostra elettricità
viaggiava altrettanto sorda e muta della
carne di cui oggi s’è svestita.
Non potremo uscire, non potremo
entrare; il verbo essere è tutto
un maledetto imbroglio.
Allora?
Questo è il rifiuto della necessità di
dover capire, è il rifiuto della eternizzazione,
il rifiuto del sentire, il rifiuto della carne
viva e della carne morta. Per il resto
non credo assolutamente. Non
accetto nessun discorso che non parta da
un a priori assoluto. I rattoppamenti non
mi piacciono. E poi a questo punto il piacere
non è altro che un letamaio dove ronzano
mosche. Ed io mi sento una mosca dal ventre
nero e puzzolente. Ho fatto tilt.
