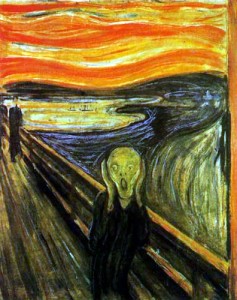 La vostra voce, Lettere dalla crisi
La vostra voce, Lettere dalla crisi
a cura di Luigia Sorrentino
—
Prendere uno stipendio significa sentirti in diritto di calpestare il suolo su cui cammini; significa sentirti cittadino e non clandestino del mondo; significa non sentirti un mangiatore ad ufo al desco della tua compagna; significa poter fumare il tuo sigaro senza rimorsi; significa sentire il sapore della minestra meritata anziché di quella regalata; significa poter scrivere questa lettera senza l’angoscia che stai togliendo tempo al lavoro, e poterlo fare alla luce del giorno anziché di nascosto come un ladro. Significa far progetti anziché tirare a campare, e non passare ogni giorno con l’acqua alla gola perché domani finiscono i soldi; significa poter dare alla donna che ami la tranquillità che finora le hai negato e non aver paura che lei non ne possa più di te.
Invece no. Da quando ho iniziato a cercar lavoro, nel 2006, questa sicurezza non l’ho mai avuta. La psicologia del disoccupato somiglia a quella del fuggiasco: si ha sempre paura. Anche i rapporti umani vengono avvelenati dal fatto di essere rapporti economici, e quindi di forza.
Ho fatto molti lavori: stagista in un giornale, stagista in un altro giornale, stagista in un’Agenzia per il Turismo, distributore di volantini, dimostratore di strumenti giocattolo in un grande magazzino, venditore di vini per telefono, addetto alle informazioni turistiche, portinaio in un ufficio pubblico, portinaio in un’azienda privata, addetto alle promozioni in un’azienda, addetto alle promozioni dinun’altra azienda. Per molti di questi lavori non ho ricevuto una lira. Ho mandato su Internet centinaia di curriculum. Ho girato per le città cercando lavoro porta a porta. Mi rispondevano cose come “In bocca al lupo”, “I miracoli possono sempre accadere”.
Adesso ho superato la trentina. Ma dipendo ancora in parte da mia madre. Che è ossessionata dal mio problema al punto che oramai non parla d’altro. La mattina di Natale mi ha telefonato non per farmi gli auguri, com’io credevo, ma per segnalarmi dei colloqui di lavoro che dovevo andare a fare. Il giorno dell’anniversario della morte di mio padre, non se n’è nemmeno ricordata, e m’ha parlato soltanto di di colloqui di lavoro, di quanti soldi ho, di quanti me ne servono. Devo ringraziare Iddio d’avere una madre benestante e generosa, ma questo non mi fa sentire meglio: vorrei avere una madre con cui fare discorsi normali. Da quando è andata in pensione, la mia passa buona parte del tempo scrivendo a mio nome curriculum e lettere di presentazione. Ogni sera trovo la posta elettronica sommersa da mail che rispondono a curriculum che non ho mai mandato, per lavori che non ho titolo per fare, oppure di semplice spam proveniente dai siti a cui mia madre m’ha iscritto credendo di essermi utile. Spesso mi invitano a cosa che non c’entrano nulla col lavoro.
Ogni tanto mia madre mi spedisce anche da qualche amico di amici, o parente di parenti, che dice di avere la soluzione per me: e immancabilmente mi trovo di fronte a un parolaio, che non dice nulla di concreto. Una volta, per soprammercato, mi han telefonato, senza riconoscermi, dallo stesso ufficio per cui lavoravo: mia madre aveva mandato un mio curriculum anche a loro.
Uno degli aspetti più umilianti della disoccupazione è il dover fare colloqui di lavoro. Ne ho fatti tanti. E’ come essere, da adulto, uno studente che viene interrogato -e valutato- tutti i giorni, e magari più volte al giorno. I datori di lavoro sanno d’avermi in pugno, forse perché lo porto scritto in faccia. Forse la mia ansia di superare i colloqui mi rende antipatico e fa sì che mi scartino. Non lo so. Ma di sicuro, i selezionatori non mostrano per me nessun rispetto. Mi fanno star seduto per ore ad aspettare, mi trattano come un mendicante che va a far la questua, mi chiedono perché ho perso tempo a laurearmi. Una volta mi son sentito dire: “Se vuoi lavorare, devi venire qui dodici ore al giorno per tre mesi. Io non ti dico né se verrai preso né quanto e se ti pagherò. Scordati di passare il sabato con la tua fidanzata. Devi mettere la tua vita nelle mie mani per tre mesi, e io ti dirò se potrai fare o no questo mestiere”.
Adesso lavoro in un’assicurazione. Ma è un lavoro che non rende e che non fa per me. Guadagno circa cinquecento euro al mese. Non dico che non sia anche colpa mia: non ho il carattere giusto, non ho la spavalderia, la sbruffonaggine, la ruffianeria, la capacità di pensar doppio che occorrono per farlo. Il contatto con la gente mi logora. Sono un uomo schivo, con poca fiducia in se stesso. I capi mi raccomandano di usar parole a vuoto per imbonire le persone, per imbambolarle, ma io non ne sono capace. Non ho la mentalità del venditore, ma in giro non trovo nient’altro che lavori di vendita. Forse sono io che cerco male. E’ impossibile non domandarsi se sia anche colpa mia.
I commerciali dovrebbero essere gente pragmatica, invece si perdono in rituali parareligiosi come la riunione settimanale, che non serve ad altro che ad ascoltare tutti insieme la Parola del Capo -sempre la stessa e per la quale si fanno saltare appuntamenti produttivi. I clienti coi quali insisto mi vedono come un fastidioso scocciatore -e spesso hanno ragione- ma mentre son da loro io penso solo alla faccia che farà la mia compagna quando tornerò a casa tardi anche stasera, senza nemmeno una polizza in mano; e le dovrò spiegare che nel mio lavoro si può sputare sangue tutto il giorno, ma se il cliente non firma è come se non avessi fatto niente e non mi danno neppure una lira. I capi hanno un tono intimidatorio, ti ricordano che sei indietro con la produzione e ti invitano a farti da parte, controllano se stai lavorando e si rivolgono a te come a un lazzarone che sta senza far nulla tutto il giorno. Ti minacciano, ti blandiscono, ti pompano, ti spaventano, insistono perché tu faccia cose che, se le facesse il tuo vicino, lo schiferesti.
“Se non sai usare il cervello, sparati e mettilo in funzione”; “Sembra di parlare con un decerebrato, eppure hai preso la laurea”: così mi apostrofano i superiori. “Tu hai un difetto: sei sensibile”. Non c’è mai silenzio. Quello che si può dire in dieci parole, loro lo dicono in dieci minuti, perché un commerciale è prima di tutto uno che parla. Ti fanno fare ore d’anticamera per darti il permesso di far la tale o la talaltra cosa, o perché occorre la supervisione del Capo e quindi devi aspettare i suoi comodi; ma se tardi di un quarto d’ora alla riunione, ventilano persino la possibilità d’introdurre sanzioni economiche. Naturalmente, nessuna minaccia viene mai mandata ad effetto: è solo un modo di frustare i cavalli affinché corrano.
Ma i cavalli, a volte, corrono a vuoto. La gente s’è fatta più scaltra, agli assicuratori non crede più. Hai voglia a dire che noi siamo venditori di sogni, che questa crisi è la nostra opportunità, che un appuntamento ben preso non viene mai disdetto!… La gente non ha nemmeno gli occhi per piangere. Sono andato per lavoro da famiglie con un bambino e un reddito solo da 800 euro al mese. Ho richiamato clienti disponibili, che m’hanno detto “Mi dispiace, stan licenziando mia moglie”… Che polizze si può mai fare a questa gente? I capi rammentano i tempi, quando con le assicurazioni s’erano fatti una ventina di carte di credito: ma erano altri tempi. Oggi è difficile.
Certo, io sono fortunato. Sono nato ricco, e la mia famiglia d’origine se la cava ancora bene. Ma, se mi manca quella tigna che rende il poveraccio capace di far qualsiasi cosa, di resistere a qualsiasi sforzo pur di raggiungere il suo scopo, è anche perché sono nato ricco. Chi parte da zero ha una marcia in più di chi inizia dall’alto e affronta la decadenza. La nostra è una generazione di bimbi fragili.
Chi è entrato nel mondo del lavoro dieci anni fa, è abituato ad avere diritti. Oggi si sa che, entrando in quel mondo, i diritti vengono perduti. Nessuno parla più di ambizioni, speranze, progetti per il futuro. Tutti si aspettano dalla vita il minimo sindacale. Abbiamo la rinuncia incorporata. Quando qualcuno ci sfrutta dieci ore al giorno e ci dà pochi euro al mese, noi non pensiamo che è un delinquente: gli siamo grati perché ci ha dato un lavoro. Non siamo abituati a combattere, non siamo abituati a far sul serio: siamo degli adolescenti di trent’anni arrivati alla vita adulta senza un minimo di preparazione.
Chi sta dall’altra parte lo sa, e se ne approfitta. Io, nel mio piccolo, oltre agli insulti sono soggetto a regole tanto minuziose quanto inutili: in pratica, devo essere invisibile. Se qualcuno “al di sopra di me”si accorge della mia presenza, devo fare ammenda; e se il capo m’insulta, devo scrivergli chiedendo un appuntamento per scusarmi.
Credevo che la vita sarebbe stata diversa. Un tempo scrivevo poesie. Ma questo non è tempo di poesie. Al telegiornale non parlano d’altro che di crisi, di soldi che mancano, di fallimenti, suicidi per fallimento, gente licenziata, famiglie sul lastrico. Ho sempre avuto la passione della letteratura e non pensavo che avrei dovuto vendere tutti i miei libri. Nei miei CD di musica classica custodivo più ricordi che dentro di me. Ma me ne restano pochissimi. Le collanine di battesimo e il braccialetto della prima comunione li ho dati via. La mia compagna ha dovuto far lo stesso. Ogni tanto andiamo a un mercatino dell’usato e portiamo un oggetto, un mobile, un apparecchio elettrico. E poi? Lei ha un mutuo da pagare; credeva d’avere un lavoro sicuro ma da qualche mese non è più così. Soffriamo tutti e due di depressione. Ma gli antidepressivi costano e gli orari della psicoterapia non sempre sono compatibili col mio lavoro, dove non ci sono orari. Lo scorso autunno, quando stavo guadagnando un po’ di più, e speravo di aver finalmente iniziato a risalire la china, m’ero iscritto ad un corso di teatro. A detta di tutti, ero bravissimo. Ma non ho potuto continuare: i soldi non bastavano. Molte volte, quando faccio la spesa, al momento di pagare mi sale il cuore in gola: e se i soldi non bastassero? Una sera, in fila a un bancomat, mi sono accorto che la mia mano destra stava facendo il segno della croce. Mi sono stupito, mi sono rimproverato. Non sono neanche credente. Ma avevo troppa paura di aver finito i soldi.
Gli scalatori, quando uno sta cadendo e potrebbe tirar giù anche il compagno di cordata, gli tagliano la corda. La mia compagna dovrebbe tagliarmi la corda se inizio a cadere. Invece mi sposerà. Affronteremo la crisi in due. Affronteremo le nostre depressioni in due. E, se andrà male, ci inventeremo un altro lavoro, da fare in due.
(Lettera firmata)

Ho letto, ho recepito un animo sensibile,ma questo trentenne crede che avere uno stipendio sia tutto….No non è così. Al suo posto mi impegnerei ad avere più speranza. Io questa parola la vagheggio, so che non ho certezze. Lo sa caro anonimo che di cancro si muore? E che ho dovuto accettare una simile realtà? Forza, sia più fiducioso…lei deve essere ottimista….
Rosa