
Frammento tratto da un saggio inedito
di Giorgio Galli su OLIMPIA
___
Iperione, la caduta
[…] Iperione è una delle sezioni più intense del poema Olimpia, di Luigia Sorrentino (Interlinea Edizioni, 2013, Recours au Pòeme Editeurs, 2015, Traduzione in francese di Angèle Paoli con testo a fronte), composta da sei Cori e da una prosa finale dal titolo Il confine. Già c’eravamo soffermati sul “noi” di Olimpia, sull’ethos panumano espresso nella sua civiltà estetica, sul suo essere coro di tragedia. Adesso questa polarità diventa esplicita. Esplicito è anche il richiamo all’opera (e non solo) di Friedrich Hölderlin. Iperione sviluppa infatti un discorso sulla creazione e sull’armonia, ma anche sulla conoscenza e su come essa si relazioni all’innocenza. Un discorso caro al poeta tedesco.
Lettura di Luigia Sorrentino da Olimpia, “Iperione, La caduta”
Il Coro I ha inizio su un tono gnomico: altissima è la densità semantica, intricata come una foresta di mangrovie; ma più l’asserzione si fa oscura, più definitivo si staglia il tono dell’asserzione:
tutto stava su di lei
e lei sosteneva tutto quel peso
e il peso erano i suoi figli
creature che non erano ancora
venute al mondo
lei stava lì sotto e dentro
“Tutto stava su di lei”: il peso della conoscenza e quello della creazione, e soprattutto il peso di dover trarre l’armonia. “Il peso erano i suoi figli”: i figli non vanno presi alla lettera, sono vita creata, atto creativo e vivificante per eccellenza. “Lei stava lì sotto e dentro”: la creazione nasce dall’inabissarsi, dal soffrire, è qualcosa che schiaccia l’essere umano e da cui bisogna lasciarsi schiacciare se si vuol creare. Ha scritto Wittgenstein nei Diari che “Il genio è talento più coraggio“.[1] Bisogna avere del coraggio per accettare fino alle ultime conseguenze la sfida dell’essere creatori.
questa pena l’attraversava ancora
quando venne meno qualcosa
“Venir meno“: un verbo che prenderà sempre più corpo nel prosieguo dell’opera. Sembra che la poesia abbia a che fare con un venir meno nella vita, che sia un morire, un tornare all’origine, ma anche un dono – un naufragio da cui s’approda a terra diversa. E ritornano alla mente le parole di Cioran, nel Sommario di decomposizione, sulla personalità umana del poeta ch’è negazione stessa della vita.
Il Coro II vale la pena riportarlo per intero:
c’è una notte arcaica in ognuno di noi
una notte dalla quale veniamo
una notte piena di stupore
quella perduta identità dei feriti
si popola di volti,
quell’abbraccio mortale
in un tempo sospeso tra mente e cuore
mai la notte fu così stellata
gettati in mare ingoiarono acqua
e pietre, strisciarono sulla sabbia
e furono in totale discordia
ebbero passi pesanti
e sparirono, sottoterra
il cenno si dissolve
da sé cade il fragile umano
frutto effimero, del mortale
C’è qui una definizione esemplare dell’attesa: “Un tempo sospeso tra mente e cuore”. Ancora, il tempo è un luogo, ma non ha perso ogni fisicità: appare anzi completamente interiorizzato. La “notte arcaica” è la condizione dell’uomo primitivo, del bambino, ma anche del poeta sensitivo. E’ solo per grazia della notte arcaica che la ferita riacquista il suo volto. E’ una descrizione – quasi fisica- della sentenza di Zanzotto sulla poesia “eterna riabilitazione da un trauma di cui si ignora la natura”. Questo spazio-tempo in attesa è impregnato di presagi, di segnali: “mai la notte fu così stellata”. E non può essere altrimenti perché in questo limbo oscuro la sensitività del poeta riacquista pieno diritto di cittadinanza. La penultima strofa ci riporta alle figure dei naufraghi, alla lotta dolorosa tra forze potenti ed opposte: il caos da cui sorge l’Armonia.
Il Coro III ci parla di uno stadio prenatale, ove l’indistinto (il potenziale) è “immenso” e “inattuato”. Non c’è ancora luce, ma l’indistinto è diverso dal buio: è “non luce”. Poi
si volse la notte si volse
bisognosa a noi che aprimmo
lo sguardo alla forma sollevata
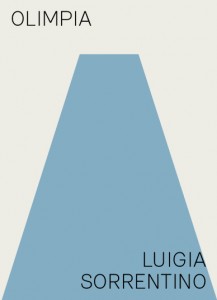 Bello e rilkiano è il verso “si volse la notte si volse”. E rilkiani sono anche l’insistere sulla visione, e l’attribuire alla notte la richiesta d’essere schiarita. In un verso più avanti è detto che solo il gesto vede. Il gesto, dunque, (anche questo è concetto rilkiano) crea il suo spazio e il suo tempo: è un altro deittico creatore. L’enfasi posta sui deittici nei primissimi versi de L’antro risulta, a posteriori, una penetrante prolessi, un elemento strutturale del poema.
Bello e rilkiano è il verso “si volse la notte si volse”. E rilkiani sono anche l’insistere sulla visione, e l’attribuire alla notte la richiesta d’essere schiarita. In un verso più avanti è detto che solo il gesto vede. Il gesto, dunque, (anche questo è concetto rilkiano) crea il suo spazio e il suo tempo: è un altro deittico creatore. L’enfasi posta sui deittici nei primissimi versi de L’antro risulta, a posteriori, una penetrante prolessi, un elemento strutturale del poema.
Il Coro IV è esistenza che tenta di continuare ad esistere, è pura forza vitale. Ma l’intuito e la conoscenza riescono a vincere, a incanalare questa forza. Chi è che opera questa trasformazione? Non c’è dubbio: è Iperione. Il successivo Coro V è un canto del Werden, del mutare, che assume anche la forma dello “svanire” (ed è lecito pensare ad un’altra figura hölderliniana, quella di Empedocle).
Torna un’opposizione che avevamo avvertito in tutta Olimpia. Egli è il cosmo, il tutto, il Werden, il vento; Ella è “nettezza”, ed è davanti a questa nettezza che Iperione si lascia cadere.
E’ semplicistico fare un’equazione del tipo Egli-Iperione, Ella-Diotima. Ma all’inizio del Coro VI è difficile sottrarsi alla suggestione della morte di Diotima.
abbiamo perso tutto
caduti in un eterno
frammento
la prima luce su noi
infuocata ha bruciato tutto
Poi però la poesia s’incarica di ricordarci una verità più complessa:
la prima creatura di umana
bellezza è morta, ignota
a se stessa
i popoli appartengono alla città
che li ama
privi di questo amore ogni stato
scheletrisce e annera
la natura imperfetta non sopporta
il dolore
Qui non c’è solo il pianto per una morte individuale: qui c’è il senso di tutta la caduta di Iperione: c’è il contatto del poeta con la Storia che brucia e che lo porta alla sconfitta nell’azione (pensiamo a un’altra poesia di Hölderlin, l’Ode a Napoleone). E c’è il pensiero di Hölderlin sulla polis (quale lo si ricava da Iperione ed Empedocle): il monito contro una società meccanica (meccanica nel senso simmeliano di società fatta di rapporti meccanici fra i suoi membri individui) contrapposta al senso d’appartenenza di una comunità fondata sulla ricerca comune di un’armonia, sulla volenterosa condivisione di questa fatica.
La prosa conclusiva ci riporta al punto cui eravamo prima del drammatico Sogno. Siamo di nuovo al confine, ma non siamo più gli stessi. Il Sogno e la Caduta ci hanno mutato. Torna l’immagine della statua mutilata, ma stavolta è una statua animata, che si muove: un’immagine leggermente saviniana. La voce che scrive vede Olimpia “morente e mutata”. Il morire e il mutare, lo ricordiamo, sono parti del compiersi, ma il compimento si raggiungerà con il concludersi del poema. […]
[1] Ludwig Wittgenstein, Diari segreti, Laterza, 2001
