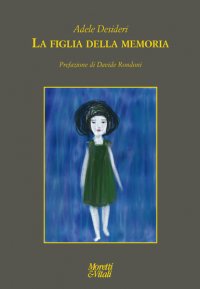L’infanzia e l’adolescenza, risorgenti in noi durante l’intera vita come un sogno, sono la radice stessa dell’esistere. Spesso non si sa dove e come si siano nascoste, se mai ci siano state. Spesso ci richiamano, in un alternarsi di luce e buio significativi. È il tempo in cui intuiamo e pratichiamo l’essenza stessa di ogni cosa e ci nutriamo della gioia e dei più profondi dolori. È anche il tempo in cui ci si guarda e si riflette: ogni istante diventa uno specchio – nei rapporti con la natura, con le persone, col nostro corpo. Non c’è nessuno a cui riferire le nostre emozioni, le esperienze. Sentiamo che non saremo capiti. Abbiamo una precoce sensazione dell’inadeguatezza degli adulti, soprattutto nelle nostre esperienze più profonde. Scrive infatti Adele: «Come avrei potuto spiegare a mamma (…) che il mio corpo era diventato “i miei corpi”: uno sopra, come una nuvola, e uno sotto, immobilizzato?». È quello anche il tempo in cui si vedono i fantasmi, si sentono le voci, si prevede il domani.
Adele tratta il tutto con il distacco, e quindi l’ironia, di chi ha imparato a comportarsi in modo da non essere travolta da quelle prime umane vicende. Da questa sua ironia e dai rapporti infantili viene anche l’uso del toscano popolare che dà forma e colore a tanti passi del suo ricordare. Non a caso lei scrive che «La lingua toscana, forse più di altri idiomi materni, ti entra nel sangue attraverso il latte e ti segna a fondo». E, in un altro passo, conferma: «Avere radici toscane ha significato, per me, sapere e potere accorciare le distanze» con gli altri. Penso che qualcosa di simile possa accadere al lettore di questo libro.