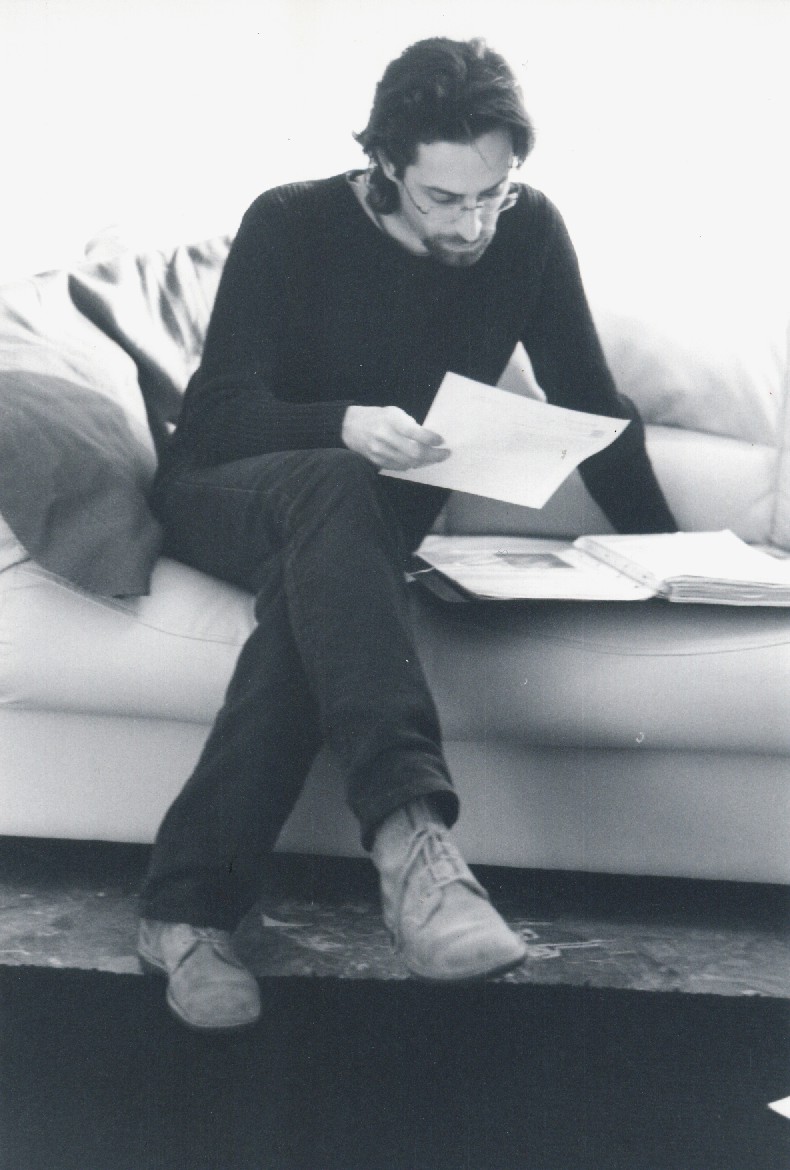
Lorenzo Chiuchiù
Su Le parti del grido di Lorenzo Chiuchiù
Nota di lettura dii Alessandro Bellasio
Da sempre fedele a una parola ultimativa e destinale, giunto alla terza raccolta dopo le precedenti Iride incendio (2005) e Sorteggio (2012), con Le parti del grido Lorenzo Chiuchiù ci consegna un libro al calor bianco, dove l’incandescenza della parola è però puntualmente raggelata dalla lucidità di una visione aliena a ogni enfasi, concentrata unicamente sull’esattezza del dire, sulla precisione assoluta; versi affilati e cesellati a uno a uno, passati per le molte armi da taglio che affollano da sempre i libri del poeta perugino. Una poesia difficile da maneggiare, refrattaria a ogni contromisura da parte del lettore, a qualsiasi tentativo di addomesticamento dialettico, di patteggiamento, di deviazione. Una parola tersa e tesa, concentrata, con cui non si può tentennare e che ci chiama in causa direttamente, senza possibilità d’appello. Abitata, potremmo dire anzi posseduta, da quella violenza misurata e sorvegliatissima così distintiva di Chiuchiù, il quale ha sempre puntato alle verità ultime, ma ha anche sempre avuto ben presente che, con tali verità, non è possibile far romanzo, allestire trama o racconto, poiché esse si danno invece solo per lampeggiamenti, per accensioni improvvise. Siamo qui, nel tempo e nella storia, «come se la vita fosse intera», ma in realtà, a un livello più profondo, si danno battaglia forze e leggi ancestrali, appena intuibili, e «tutto è senza nome, aperto | e sacro come l’occhio del lupo | o come il patto, il suicida, l’innato.» Tutto avviene in uno spazio ripido, scosceso, che minaccia di spalancarci sotto i piedi la voragine fatale – ma senza concessione alcuna al dramma, perché proprio su questo terreno si gioca la partita decisiva della poetica di Chiuchiù, su questa abolizione del pathos drammatico in favore della presa di coscienza tragica, della lucidità impassibile e prolungata, che con voce partecipe ma mai enfatica constata la necessità di tutto quanto accade. Di modo che se anche quella voragine si spalancasse, non vi sarebbe che da prendere atto di un destino precedente, che ci attendeva lì da sempre. È questa una poesia che non si lascia sedurre dall’elegia, né tentare dalla recriminazione: «siamo solo questa gravità del sangue che ci reclama interi, frontali, e perfetti nelle nostre sconfitte, illuminati da pura ferita.»
E d’altro canto, a livello stilistico, la vis potentemente assertiva di questa poesia trova espressione nel serrato susseguirsi dei tanti imperativi, con i quali non a caso l’opera si apre («Ripeti contro di te: ti illudesti») e si chiude («accetta la morte perché anche quella sono io»), convalidando così anche sul piano delle scelte sintattico-grammaticali l’essenza circolare, centripeta del suo movimento, «dall’unico all’unico». Unità di intenzione e di intonazione poetica, unità di pensiero e di visione, di stile: è questo che emerge considerando anche i precedenti lavori di Chiuchiù, che di libro in libro ha scavato e attinto alle risorse di un mondo coerente, compatto; un poeta e una poesia monacale, claustrale, un’avventura solitaria fedele ai suoi perimetri. Giocata tutta sulla tensione. E dove ogni cosa accade una volta e per sempre, irreversibilmente, potremmo dire “grecamente”. Perché in effetti fin dall’esordio di Iride incendio, e poi più distintamente con Sorteggio[1], Lorenzo Chiuchiù ci ha abituati a uno sguardo presocratico, sapienziale, più vicino ai guizzi e alle accensioni degli ardui moniti eraclitei che non alle raffinate scepsi dialettico-forensi della polis platonica. E un tale sguardo, così antico e inattuale, come testimonia l’esperienza di Chiuchiù può trovare oggi solo nelle lente distillazioni di una lirica asciutta e visionaria una direzione e una voce commisurate alla sua forza arcaica, elementare. Questa è infatti una poesia che considera il mondo e tutto ciò che in esso vive e patisce non come corpo, come entità definita e individuata (organismo), bensì anzitutto come campo – un campo di forze che si danno battaglia per entrare o uscire dal manifesto, e di cui i corpi sono in realtà i canali di transito: le cose sono cioè configurazioni provvisorie di substrati dove agiscono potenze elementari. Dobbiamo allora andare al di là dei singoli eventi e delle singole esperienze, per giungere invece al nucleo dal quale essi vengono emanati, all’aggregato di forze che li irradia nell’esistere, prima di reclamarli di nuovo a sé[2]: l’uomo stesso è questa apparizione «nello squarcio | del tempo e delle vite», è «la pura incarnazione» e ha il suo «turno in una notte finita», «fin quando il nucleo | senza simmetria, la stella | che contiene tutte le notti | e tutti gli accecanti battesimi | non rivorrà la tua ombra». Si è emanati e poi riassorbiti nell’arché, come volevano i fisiologi ionici. Ma come si giunge a questa visione, come si può andare oltre il “velo di Maya” che ci tiene vincolati ai fenomeni? Forse troviamo un indizio, un accenno alla via percorsa dall’autore in questo brevissimo distico: «Hai mancato la terra | e ora sei nel centro della materia»: mancare la terra (ovvero la contingenza, il qui e ora, la storia, il divenire), ecco il punto, significa abitare nella lontananza, nel congedo dal piano della realtà manifesta; e proprio questa è, d’altronde, la condizione ascetica indispensabile per andare oltre chrónos, oltre i calendari e le date, e incrociare la nuda frontalità della materia – cifra, appunto, di quanto è essenziale, fondativo, opposta e speculare a quell’altra cifra, del manifesto e transitorio, che è invece la terra. Eppure – ed ecco il tragico in luogo del drammatico – anche quando si giunga alla visione essenziale, si scopre che non v’è nulla cui appoggiarsi, non v’è riscatto, né salvezza, né elevazione, perché il nucleo medesimo, l’arché, «è demolito», è «senza simmetria», come a dire che l’essenza stessa è un buio e un baratro, qualcosa (con i versi più potenti di tutta la raccolta) «senza tregua, senza nome, senza riflesso: esiste e scava gli elementi nella fine degli elementi». Cerchio che si chiude, unico che torna all’unico. Un’apocalisse senza redenzione, quella di Lorenzo Chiuchiù, una rivelazione priva di ogni lusinga soteriologica, dove ciò che conta è solo la testimonianza che riusciamo a consegnare alla luce tersa e fragile della poesia, anch’essa esposta alla minaccia perenne del niente, al ricatto permanente dell’illusione:
Vuoti e frontali come i sogni dove si muore
volete la vostra illusione, la bellezza santificata,
la parola niente ripetuta e divorata dalla gioia:
anche voi siete parole
e avete il vostro turno in una notte finita.
NOTE
[1] Si veda, come testo emblematico, quella che è forse anche la lirica più potente di tutta la silloge, “Officina ionica”, in Sorteggio, Marietti 1820, Genova, 2012, p. 56
[2] A titolo esemplificativo, riportiamo il testo “Casa del 30 luglio 2006”, dedicata al poeta Stefano Massari:
Eppure volevi una grazia senza legge
per forbici russe nascoste tra le camicie
o per i tuoi quarant’anni festeggiati
nel parco dei persuasi,
o gli altri comandamenti,
i passi falsi: e ancora torna quella sera,
i fratelli ridono fino alle lacrime
quando le morti non sarebbero accadute
e vi eravate incontrati nello squarcio
del tempo e delle vite: eppure
tu sei ancora lì, con il bicchiere di vino bianco,
il conto pagato a metà, le voci dei solitari,
l’unico coro che hai mai amato.
