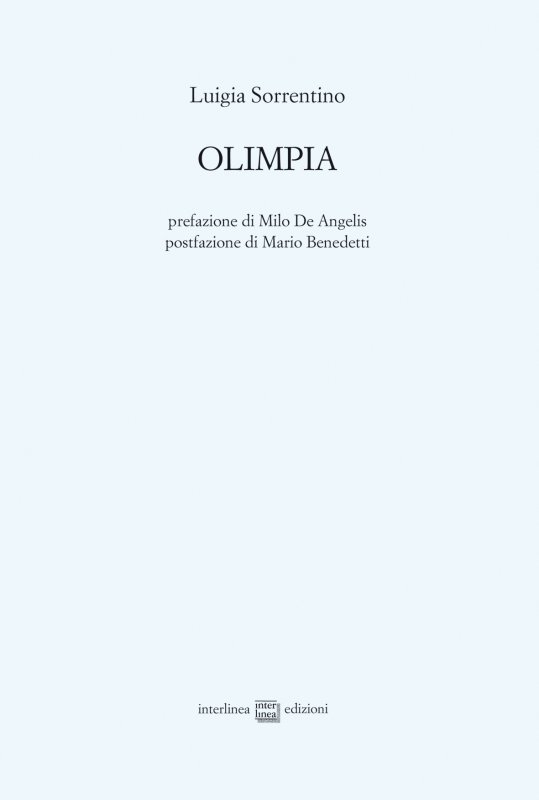 NOTE PER UNA RILETTURA di OLIMPIA
NOTE PER UNA RILETTURA di OLIMPIA
di Giuseppe Martella
- Fonti
A una prima lettura, Olimpia (Interlinea, 2013)[1] appare come un diamante: un’architettura splendida e tagliente, immersa nell’azzurro intenso di un cielo mediterraneo. Una creatura di luce: donna, città e dea. Nel corso della lettura, ti rimanda poi figure cangianti in cui ti rifletti ruotandole intorno, come in un assedio senza fine. Una città ben difesa da alti bastioni, sui cui spalti appaiono visioni elusive di larve e di donne, di colossi e di chimere. Una città fuori del tempo, certo, nuova e vecchia insieme, sfuggente visione nel bianco che ti acceca. Un’architettura più che umana che custodisce gelosa i segreti di un mondo e i possibili tempi della sua storia.
Forse per questo, il poemetto ha avuto parecchie, anche lodevoli, recensioni ma a quanto ne so nessun approfondimento critico vero e proprio. Ci si è fermati insomma al miraggio della città e alla superficie del testo. Eppure, nella sua breve e perspicua introduzione, Milo de Angelis ci aveva fornito alcuni validi indizi, se non addirittura le chiavi dell’interpretazione, quando parlava di “libro orfico”, “percorso iniziatico”, “sguardo lungimirante”, “tempo assoluto”, e di quella sensazione del lettore di essere “sempre sulla soglia di una scoperta cruciale”. Questi sono tutti attributi infatti che bene si confanno alla tradizione cui appartiene quest’opera: cioè a quella linea alta, visionaria e veggente, del simbolismo europeo, tra Otto e Novecento, che sfocia poi anche nei migliori esiti del modernismo, secondo traiettorie che vanno da Baudelaire a Rimbaud, da Mallarmé a Valery, in Francia; che in Gran Bretagna, sotto l’influsso congiunto dei classici (greci, latini, rinascimentali) e dei simbolisti francesi, generano le opere memorabili (nel contempo classiche e rivoluzionarie) di Ezra Pound, T.S. Eliot e dell’ultimo Yeats; e che infine in Germania annoverano tutta una schiera di validi poeti, nel lungo arco di tempo che porta da Hölderlin a Rilke, e fino a Paul Celan.
A questa linea appartiene il poemetto di Sorrentino, piuttosto che a quella musicale ed estetizzante che, a partire da Verlaine e attraverso Swinburne in Inghilterra, conduce dritto all’estetismo, al decadentismo e a D’annunzio qui da noi. L’unico poeta italiano che si può dire appartenga a pieno titolo alla linea visionaria di cui dicevo, è a mio avviso Dino Campana. E desta davvero meraviglia che i critici non abbiano osato chiamare in causa l’autore dei Canti Orfici nella lettura di un testo che è stato definito “orfico” nella sua prefazione. Campana è infatti un nume tutelare della poesia di Olimpia molto di più di quanto non lo sia lo Hölderlin evocato in epigrafe. Mi soffermerò perciò in particolare su questo debito, non certo per diminuire il valore della poesia di Sorrentino quanto piuttosto per inquadrarla meglio nel contesto del simbolismo italiano ed europeo, al quale credo fermamente appartenga, e per renderla pertanto più accessibile e significativa.
Prendiamo ad esempio alcuni motivi e immagini dei Canti Orfici, che ritroviamo poi puntualmente elaborati, condensati o ampliati, in Olimpia. Anzitutto quello della visita alla città che, in dimensione sia realistica che simbolica, attraversa l’intera opera di Dino Campana, dall’inizio alla fine. Dalla “vecchia città rossa di mura e turrita” che apre il viaggio onirico de La notte, alla bianca città equatoriale addormentata di Viaggio a Montevideo e alle altre numerose città italiane disseminate nelle varie sezioni del poema. Fino alla surreale, ariosa passeggiata per i “segreti dedali” di Genova che chiude i Canti Orfici, e dove nel “verde sogno dei giardini” da “una grotta di porcellana” il viandante può guardare a una “porta disserrata”. Il sogno e il giardino daranno addirittura il titolo a due sezioni di Olimpia e l’esplorazione della città ne costituirà in effetti l’ossatura.
Il motivo della città si compone poi in entrambi i poeti con quello della donna, giovane e vecchia, umana e divina, che da Campana viene evocata oniricamente con connotati spesso erotico-sacrali, come la prostituta-vestale dei grandi miti mediterranei che accoglie il viandante alle porte delle città, e “porta il peso di tutto il sogno umano” nel “panorama scheletrico del mondo.” In Sorrentino poi, questa semidea diventa addirittura la protagonista del poema, la donna anonima dell’inizio, il vuoto pronominale che regge l’intera vicenda, una vera e propria proiezione dell’io poetico nello spazio mitico.
L’immagine ricorrente della porta, è peraltro strettamente legata nei Canti Orfici al motivo della apparizione della donna come oggetto di desiderio e tramite di una iniziazione, come capita nei vari riti di passaggio evocati in sogno nel poema. Questa ricorrenza onirica viene a sua volta ripresa e sviluppata da Sorrentino, specialmente nella sezione Il contrasto fra il divino e il tempo (un sogno), e infine condensata nella domanda “è quella la porta?” che insieme alla risposta “qui visse la donna” costituisce il refrain che sottolinea la dimensione mitico-esistenziale del suo percorso poetico, scandendone anche le stazioni e i tempi. (28, 44-50) L’atmosfera del sogno è d’altronde dominante in entrambi i poemi e viene addirittura messa a tema e a titolo di due sezioni di quello di Sorrentino: quella appena indicata e Il sonno (83-87).
Troviamo poi anche nei Canti Orfici un gioco insistito di specchi, con tutte la gamma di sfumature della luce e dell’ombra, che Sorrentino riprende e articola costantemente in Olimpia, riassumendolo infine squisitamente nell’immagine orfica del “traguardo dell’Ombra”, nella sezione centrale del suo poemetto, Il lago, (39) su cui dovremo tornare. Ai giochi di luce si affianca anche in Campana il motivo del bianco, del candore e pallore, sul volto e nelle vesti di giovani destinate a qualche tipo sacrificio: un motivo su cui insiste molto anche Sorrentino. Si consideri inoltre l’alternarsi di discese e risalite, più o meno simboliche, che caratterizza i Canti Orfici nel complesso (e in particolare il pellegrinaggio francescano de La Verna), che Sorrentino trasforma in un elemento strutturale del proprio percorso iniziatico, tra frane e arrampicate, trasponendolo infine sullo scenario mitico della titanomachia dove assistiamo alla caduta rovinosa di Iperione ad opera della nuova generazione degli dei olimpici.
E il bel verso di Campana dove la “città … si compone in un sogno cadenzato” non potrebbe riassumere forse l’intero percorso dell’anonima protagonista di Olimpia? E “la polvere luminosa che posa nell’enigma degli specchi” non potrebbe condensarne il gioco delle figure?
Si potrebbe continuare ma credo che tanto basti a evidenziare il debito.
Se I Canti Orfici di Dino Campana costituiscono un importante serbatoio di immagini per la creazione di Olimpia, bisogna sottolineare subito però che sia Campana che Sorrentino, entrambi attingono all’immaginario orfico di cui si sono nutriti tutti i poeti in senso lato simbolisti, tra otto e novecento, da Hölderlin a Rilke, da Baudelaire a Valery. E se Campana ne nutre la imagery, la situazione iniziale di Olimpia assomiglia infatti proprio a quella della Jeune Parque di Paul Valery, dove si rappresenta il doloroso processo di individuazione che attende la giovane semidea chiamata a filare e a recidere la vita e il discorso degli umani. Si tratta anche qui di una tormentata presa di coscienza che si conclude con un appello alla gioia, così come avviene in Olimpia. Da Hölderlin, infine, Sorrentino trae il tono alto e fermo dell’ode o dell’inno, lo “sguardo lungo” mirato sull’antichità greca, nonché la vocazione (anch’essa sostanzialmente orfica) a ricostituire la perduta unità tra la natura e l’umano.
- Testo
“Lei era lì/
non era più la stessa/
il volto sbiancato nell’intangibile/
nulla più le apparteneva/
si rivoltava in un’altra che l’offendeva/
nell’involo mostruoso in lontananza/
lei era un soffio chiuso/
tutto era in sé pieno, attaccata/
alle pareti, lei era ormai radice.” (13)
Dove siamo? Siamo nel ventre della Terra, all’inizio di Olimpia, ma siamo anche alla sua fine, quando nella panoramica della città nuova, attraverso “un vetro scheggiato” che la de-forma, si profila, come un resto o una traccia, la rovina di quella vecchia, “la cupola sventrata”, (99) come un cordone ombelicale che non si può recidere: quello che ci lega al nostro passato, alle fondamenta di ciò che siamo. Così, giunti alla fine della nostra esperienza e avendo ormai acquisito la consapevolezza di questa finitezza, veniamo rigettati violentemente al suo inizio, alle fondamenta terrestri del nostro essere nel mondo. Sì che il circolo ermeneutico di inizio e fine si apre sulla spirale dell’Eterno Ritorno e sul tempo ciclico del mito che è congeniale allo spazio sacro di Olimpia. La percezione della cornice del testo ci proietta pertanto immediatamente sull’orizzonte mitico su cui si svolge la serie di riti di passaggio di cui si compone l’intreccio del poema.
In questa prospettiva, il lettore può cogliere la duplice portata, esistenziale e poetica, del percorso iniziatico cui partecipa nel corso della lettura. Si tratta però ovviamente a questo punto solo di una ipotesi di lavoro, che va verificata, integrata ed eventualmente corretta in corso d’opera. Olimpia è infatti un banco di prova assai arduo per l’interprete così come è stata una prova assai rischiosa per l’autrice. Alcuni brevi cenni sulla struttura del testo aiuteranno a definire il luogo del loro eventuale incontro: si tratta di un prosimetro infatti, costituito dall’alternanza fra sezioni in versi e brevi inserti in prosa ritmica, con funzione di quadri per l’azione che si svolge nei versi che seguono. Il tessuto fonico-ritmico non è a prima vista complesso: il verso è libero e di lunghezza varia, ma sotto l’accentuazione sillabica dell’italiano sembra correre, come un basso continuo, la scansione regolare dell’esametro, greco o latino, che in parte neutralizza l’accentuazione, conferendo al discorso il tono fermo e il registro oracolare. Già a questo livello perciò si percepisce il sostrato mitico e classico di questa poesia.
D’altronde non si fa qui grande uso di rime, assonanze e altri tipi elementari di parallelismo poetico, o veicoli del cortocircuito fra suono e senso. Anche l’assetto semantico risulta infatti abbastanza elementare e univoco. Le figure retoriche dominanti sono invece di ordine sintattico: fra esse spiccano per esempio l’anacoluto, o sospensione del tema; l’iperbato, o separazione di parole che dovrebbero essere logicamente connesse, il cambio improvviso e immotivato dei soggetti dell’enunciato, e insomma tutte quelle figure che comportano una dislocazione radicale della sintassi logica della frase. Ma la specificità di questo testo si può apprezzare infine solo a livello sintagmatico, cioè nella concatenazione delle varie sezioni e quadri di questa città di parole.
L’iterazione, che è il procedimento fondamentale di ogni discorso poetico, viene insomma prevalentemente spostata dal livello fonico ritmico a quello sintagmatico e simbolico, in una sorta di ripetizione variata del dramma iniziatico attraverso i vari luoghi della città che corrispondono ad altrettanti topoi del nostro immaginario culturale (la grotta, l’atrio, il giardino, il lago, il monte, la città nuova).
Per quanto riguarda poi la grammatica, il testo si può definire come un dramma pronominale i cui funtivi rimangono sempre in attesa di un riempimento che non arriva mai. I suoi attori sono infatti tutti i pronomi personali, singolari e plurali, benché poi la protagonista principale sia senz’altro la lei, la figura femminile anonima e senza volto, che incontriamo nell’Antro fin dall’inizio. Il testo però abbonda non solo di pronomi ma di deittici in generale (avverbi di luogo e di tempo, ecc.), significanti vuoti e disponibili, sempre in attesa di un referente irreperibile. Anche in questo senso il poema è squisitamente orfico: mantiene cioè il segreto, ossia la donazione di senso sempre sulla soglia del compimento. E proprio quella della soglia è l’isotopia portante dell’intero componimento, quella che, attraverso i vari livelli di organizzazione del discorso, ne orienta e regge il senso totale.
Nel complesso il testo organizza i suoi spazi semantici interni proiettandoli sulla mappa dei luoghi di della città sacra, sicché l’intreccio che ne risulta è letteralmente una serie di superamenti di confine o di riti di passaggio, per cui la costruzione e la visita di questa città di parole alla fine coincidono. L’architettura e l’archeologia si sovrappongono in modo tale che, come s’è detto, quando si è giunti alla fine del percorso si viene rinviati all’inizio e la città nuova lascia intravedere in sé lo scheletro di quella vecchia, l’insieme di detriti e di rovine che costituiscono le sue fondamenta. Torniamo così indietro nel ventre della terra madre da cui siamo usciti, chiudendoci in una specie di cerchio magico di cui l’immagine del lago, che si trova al centro del poema, costituisce il fuoco virtuale della riflessione, l’ occhio immoto del ciclone, la sua soglia simbolica interna, il luogo del possibile sprofondamento del volto che ci manca, la “Lei che è lì” dall’inizio, l’oggetto del desiderio e dell’adorazione, della ricerca e del canto, l’Euridice di Orfeo, l’ombra amata che può ad ogni istante sprofondare “a un passo da noi”. ( ) Perché qui si tratta di una iniziazione che è nel contempo esistenziale e poetica.
Il poema infatti si muove sul limite del visibile e del dicibile, costituendo un complesso rito di passaggio, ed è pertanto integralmente e squisitamente orfico. Nel senso specifico che esso si colloca sulla soglia della parola e dell’immagine, dell’indicibile e dell’invisibile (Aides), come Orfeo quando attraversa la porta degli inferi per riportare col suo canto alla vita l’ombra di Euridice e come quando poi su quella stessa porta la perde definitivamente per un soffio. Olimpia infatti mette in scena fra l’altro il rischio di fondo del fare poetico, che è quello di poter portare alla luce del giorno gli archetipi dell’inconscio collettivo e dar loro “un’abitazione e un nome”, rivivificandoli e riattualizzandoli, oppure invece perderli nei meandri del proprio discorso, affondarli sul filo della corrente dove ancora canta la testa recisa di Orfeo. O in uno specchio acqua troppo densa e vischiosa, nelle sabbie mobili del narcisismo di morte: “In un’ellisse chiusa dal vento che ingoia la luce rivoltandola nella materia fangosa che ribolliva in superficie” (39)
Ci troviamo qui su quel limite che, come ci insegna Platone nel Simposio, separa e unisce la rêverie poetica e l’allucinazione psicotica. Ed è proprio qui che, in Olimpia, all’io poetico viene incontro “il traguardo dell’ombra” (39), la porta liquida che gli può consentire di scendere nell’immemoriale inconscio per trarne fuori immagini mirabili, oppure al contrario condannarlo a sprofondare insieme ad esse in un vortice allucinatorio, nel labirinto di specchi e nella foresta di simboli che pure deve necessariamente costruire e attraversare. La struttura del testo di Olimpia, pure nella descrizione sommaria che ne ho dato, ci rimanda dunque imperiosamente a quell’orizzonte archetipico in cui soltanto quest’opera può davvero essere interpretata.
- Mito
I due antichi culti esoterici rilevanti per la comprensione di questo itinerario iniziatico, sono ovviamente i misteri eleusini e quelli orfici. I rispettivi miti di riferimento sono quelli di Demetra-Kore e di Dioniso-Orfeo, il dio sbranato (dai Titani e dalle Baccanti) e poi ricomposto, letteralmente ad opera di Rea, Apollo o altri e metaforicamente per mano del suo sacerdote, proto-poeta e sciamano, Orfeo che ne segue le sorti (sbranato anch’egli dalle menadi) ma prima quasi riesce a compiere ciò che nel mito greco non era assolutamente contemplato: ridare vita all’ombra di una morta e riportarla alla luce. Di ciò proprio si parla nel racconto di Orfeo e Euridice che è tanto noto che non val qui la pena di rievocarlo.
Dioniso, il dio straniero, quello dai molti volti e nomi, dalle tante morti e rinascite, sta sull’orizzonte della religione olimpica, come il segreto della sua origine e il presagio della sua fine. Una versione del mito ci dice che egli nacque da Zeus e Semele, figlia di Cadmo e Armonia, signori di Tebe, e dunque una mortale. Quando ella volle vedere il vero volto del suo amante, ne rimase incenerita. Si dice anche che Dioniso scendesse spesso nell’Ade a visitarla (e la discesa agli inferi è un tratto che lo accomuna al suo sacerdote Orfeo). La sua opposizione-fratellanza con Apollo, così come l’ebbrezza sta alla visione e la passione all’azione, illumina l’intero spazio del mito greco e dona senso a tutte le sue figure. Egli è comunque soprattutto il dio che viene sbranato dalle sue seguaci e il cui corpo viene sparso dando nutrimento alla terra e seme alla sua rinascita. In ciò si connette a Demetra. Le avventure e le reincarnazioni di Dioniso nel mito greco sono innumerevoli. Basterà qui ricordare l’antichissimo racconto titanico che lo riguarda e che costituisce un vero e proprio archetipo dell’inconscio collettivo: Dioniso ancora infante (senza la parola), mentre gioca, nello specchio che una donna (madre o nutrice) gli porge, vede intorno a se una serie di maschere bianche come la sua, che gli danzano intorno in spirali concentriche fino a farlo a pezzi a colpi di coltello. Le sue membra sparse sulla terra saranno poi ricomposte e riportate in vita (da Rea, Zeus o Apollo, a seconda delle varianti). E’ l’incipit del processo di individuazione, della nascita della coscienza dall’esserci, della distinzione dell’uno dal tutto e dal molteplice. Il rito iniziatico per eccellenza.
Sulla figura di Orfeo dovremo tornare.
Quanto a Demetra (il cui nome nelle antiche lingue indoeuropee significava probabilmente proprio “La madre”), essa è l’ultima incarnazione, fra gli dei olimpici, della Grande Dea mediterranea, che in Grecia, sotto il nome di Gea, è al centro del più antico e diffuso racconto sulla nascita congiunta sia degli dei olimpici che degli uomini. Si tratta del mito della evirazione di Urano da parte del figlio Crono. Eccone un breve sunto: all’inizio dei tempi, Urano, il cielo, ogni sera scendeva su Gea, la terra, e la copriva in un amoroso amplesso ma il suo godimento non tollerava la generazione di figli: sicché appena nascevano li nascondeva nella cavità più profonda della terra, che si sentiva perciò oppressa e angustiata. Così escogitò un inganno col più giovane dei figli che erano comunque riusciti a venire alla luce. Costui era Crono (dalla mente tortuosa, il dio del tempo, appunto). Con una falce d’acciaio, tratta dalle viscere della madre, Crono evirò il padre e prese il suo posto come re dell’universo. Urano allora non scese più ad abbracciare Gea, mentre il suo membro sanguinante cadde in mare e generò Afrodite. Una nuova epoca era nata. Dalla ciclicità semplice, imperturbabile delle religioni astrali, si passò alla rischiosa varietà dei commerci fra i divini e i mortali. Di lì a poco, Crono e Titani suoi fratelli vennero poi a loro volta spodestati da Zeus e la nuova capricciosa stirpe olimpica si spartì i poteri sulla terra e governò il mondo. Dal sangue dei Titani sprofondati nel tartaro da Zeus nacque infine la stirpe degli uomini.
Demetra, figlia di Crono e di Rea, e dunque sorella di Zeus, ebbe da lui Kore, la fanciulla divina per eccellenza, quella che dopo il ratto famoso diverrà Persefone, la sposa di Ade (Aides: l’inguardabile) e regina delle ombre negli inferi. Demetra, la Cerere dei romani, è la madre terra, “portatrice di stagioni“, come viene invocata negli inni omerici, nutrice della gioventù e della terra verde.
Tenendo a mente questi miti di riferimento e avendo individuato nella tensione fra gesto, sguardo e voce una delle cellule generative del nostro poema, siamo però ora costretti a fare una giravolta di 180 gradi sull’altra faccia del mito greco, quella esoterica e misterica. Questa si affianca alla religione olimpica come ciò che ne costituisce il risvolto, custodendone l’origine arcaica e la promessa della sua fine. La grande ombra di Olimpia, il suo doppio fantasmatico, nel mito greco e nel nostro poema, è infatti Eleusi, la sede dei misteri, luogo di culto di Demetra, figura greca della grande madre Mediterranea. Ed è all’ombra di Eleusi, che fa da contrasto alla luce di Olimpia, che potremo seguire meglio il complesso dramma misterico messo in scena nel poema, che si può definire esoterico a pieno titolo in quanto compone i due grandi culti iniziatici dell’antica Grecia, i misteri orfici e quelli eleusini, nonché ovviamente i loro miti di riferimento, quelli di Dioniso-Orfeo e di Demetra-Kore. Ma il poema è poi orfico in senso stretto e preciso in quanto ha come protagonista la figura cangiante del primo poeta, declinata per lo più al femminile, e le costellazioni mitiche che gli sono connesse. Questa elaborazione del mito orfico costituisce la spina dorsale di Olimpia e il miglior filo conduttore per la sua lettura.
La figura di Orfeo è infatti essa stessa un perno su cui la sapienza compatta e impersonale del mito greco svolta essa stessa verso la scomposizione nelle varie discipline dell’arte, della filosofia e della politica, costituendo insomma la soglia epocale del passaggio dal mito al logos. I molteplici temi evocati nel suo mito – i nessi tra amore e poesia, tra sacrificio e mistero, ecc. – hanno peraltro goduto di una fortuna senza pari nelle arti e nelle lettere, nella musica e nella filosofia dell’intero occidente.
La ben nota vicenda di Orfeo e Euridice costituisce poi un autentico mito di fondazione della poesia: Orfeo porta infatti l’ombra amata sulla soglia del visibile (l’Aides greco) per poi perderla per un soffio, nel volgersi indietro e in giù, verso il passato e verso l’inconscio. Su questa soglia sottile si decide il destino del canto e dell’immaginazione poetica. La vicenda di Orfeo che si volge sulla soglia dell’Ade verso Euridice e pertanto la perde, si può considerare il luogo e la svolta, il topos e il tropo d’origine della poesia e dell’arte in generale. Si può considerare idealmente come una anamnesi e una rivisitazione della svolta cruciale, quella tra la vita e la morte, dello sguardo e del respiro (la psyke greca è infatti occhio e soffio dell’anima). La mimesi di questa svolta esistenziale si attua nel più bello fra i riti iniziatici, quello in cui l’io poetico (comunione di essere e coscienza, attore e regista del proprio dramma) muore a se stesso, si dimentica, si smembra e poi si ricompone, si dissemina e rinasce nei suoni e nelle figure del proprio canto, nella cerimonia della palingenesi di un mondo, nell’innocenza e nello stupore primordiali.
Questa è la piega autoriflessiva che, nella figura di Orfeo, prende ora il dramma di Dioniso sbranato dalle menadi, coniugando così il sapere panico (il pathei mathos) del dio sofferente con la veggenza e il gesto ieratico del fratello Apollo. E’ questa piega che fa della autoriflessività il carattere proprio della poesia, il centro della sua volontà di forma, il suo voler essere praxis téleias, quel tipo straordinario di azione che può contenere in sé i propri fini. Nella figura di Orfeo e con la nascita del primo poeta si compie in effetti nel modo più inatteso e più squisito il dramma del Kurios, del fanciullo divino, del dio avvenire, che costituisce la tensione generativa e l’orizzonte escatologico del mito greco – nonché probabilmente il segreto che il Prometeo di Eschilo si porta con sé quando viene sprofondato da Zeus nelle viscere della terra. Platone nel Fedro definisce Orfeo un sofista perché il suo canto tende a sedurre piuttosto che a dire il vero. Ma è un sofista del tutto speciale perché in grado di convincere l’Ade che ci portiamo dentro a cedere almeno per un attimo i propri fantasmi e farli venire alla luce e alla parola.
I tratti principali della figura di Orfeo sono dunque il suo smembramento da parte delle menadi infuriate, pare per il suo rifiuto di amarle, e la sua discesa agli inferi per trarne fuori Euridice. Quest’ultima ha molti tratti in comune con la Kore per eccellenza, Persefone, separata a forza dalla madre Demetra, rapita e fatta sua sposa dal Dio degli Inferi: in entrambi i casi si tratta della perdita dell’innocenza e del passaggio traumatico dall’adolescenza alla maturità. I due miti relativi sono al centro delle grandi religioni esoteriche della Grecia antica, l’orfismo e misteri eleusini, in cui si mette in scena la lunga elaborazione del lutto di Demetra per la perdita della figlia, il travaglio della terra sterile in inverno e infine la gioia per il ritorno alla luce di Persefone, e alla vita di Demetra, in primavera. Si tratta originariamente di un rito di vegetazione, che poi si carica però del significato di una universale palingenesi.
I due grandi culti misterici dell’antica Grecia costituiscono le architravi del nostro poema e il mito di Orfeo e Euridice si trova esattamente al loro incrocio. Se leggiamo Olimpia alla luce di questo mito, che è come la spina dorsale dell’orfismo, si chiariscono molti aspetti del poema sia per quanto riguarda i temi che le strutture. Prima di procedere, occorre però fare ora riferimento a un altro autore importante per la poesia di Sorrentino e cioè Rainer Maria Rilke, il massimo poeta orfico del Novecento. Torniamo dunque alla scena iniziale di Olimpia, vera e propria cellula melodica del componimento, esaminandola in maggior dettaglio. Chiediamoci stavolta “chi era lei”, la protagonista anonima dell’intero poema, e cosa le accade. Ricordiamo di passaggio anche che la dottrina della metempsicosi e la pratica dell’anamnesi sono due elementi fondamentali dell’orfismo, ripresi ed elaborati tra l’altro da Platone e posti a base della sua dottrina delle idee e dunque anche dell’intera filosofia occidentale.
Sullo sfondo dei misteri orfici e eleusini, e nella prospettiva del rito di iniziazione, possiamo intravedere nella prima scena del nostro poema, insieme la caduta dell’anima nella prigione del corpo (nel ciclo delle sue reincarnazioni), il ratto di Persefone e la discesa agli inferi di Euridice. Ciò che si annuncia in questa prima lirica basta a farci intendere la direzione e la portata dell’inventio di Sorrentino, che sovrappone e intreccia la religione ufficiale e quella esoterica dell’antica Grecia, tracciando in filigrana la mappa di Eleusi sotto quella di Olimpia e sovrapponendo i luoghi sacri delle due città in un sapiente palinsesto, nello spazio del suo testo, nella ripartizione accurata dei luoghi e delle stazioni del dramma che vi si inscena, dove la sovrapposizione delle due città e dei due culti risulta la mossa decisiva, la metafora fondante. Il riconoscimento di Eleusi come doppio spettrale di Olimpia può offrirci dunque la chiave del percorso disegnato dall’autrice con una perizia, un senso della suspense e una propensione al segreto degni di una ierofante orfico-eleusina.
A sostegno di questa lettura si può scorgere fra l’altro nell’Antro della prima sezione del poema, la grotta che si trova tutt’ora sulla Via Sacra che porta da Atene ad Eleusi, e in cui si facevano entrare i novizi all’inizio della cerimonia. Mentre nell’ultimo quadro del testo, La città nuova, si può rinvenire una veduta dell’odierna Elefnisa con le annesse rovine di Eleusi e del ponte romano fatto costruire da Adriano nel 125 d.c. sul fiume Kefisso lungo la via sacra: “Dal ponte di ferro sul quale sostammo vedemmo la cupola sventrata, accerchiata dalla città nuova…Lontano il confine di un orizzonte tagliato da una sorgente d’acqua che da qualche parte si congiungeva al mare:” (99) Un’immagine che felicemente chiude l’orizzonte del visibile e della memoria nel poema, mentre nell’aria risuona l’eco concentrata di un inno pindarico: “Olimpia, gioia di esseri non esperti di gioia!” Questa gioia evocata alla fine ha carattere assolutamente euforico e pertanto non è affatto la gioia tragica che qualcuno ha voluto vederci quanto quella mistica dell’iniziato che, avendo superato tutte le prove, ha raggiunto l’epopteia o chiaroveggenza.
Avendo così delineato l’orizzonte iniziatico del poema, colei che nella sua prima scena “si rivoltava in un’altra che l’offendeva/nell’involo mostruoso in lontananza” può ben riferirsi all’anima orfica caduta nella prigione del corpo, dove diviene un “soffio chiuso”, poiché la parola “psiche”, anima, in greco significa esattamente “soffio”. Però “l’involo mostruoso” può ben alludere anche al ratto di Persefone. E soprattutto l’intera scena evoca il mito di Orfeo e Euridice e le numerose sue rielaborazioni nell’arte occidentale, a partire da quella radicale di Rilke che, nella splendida poesia “Orfeo Euridice Hermes”, rilegge l’intera vicenda della scomparsa dell’amato dal punto di vista di Euridice che, ormai risalita fino alla porta dell’Ade, nell’udire Ermes che dice “si è voltato”, “non comprese e disse piano: Chi?” Proprio in questa nota poesia di Rilke ricorrono, bencé in ordine inverso, le esatte parole che chiudono la lirica iniziale di Olimpia: “lei era ormai radice”. La poesia di Rilke in generale, dalle Elegie Duinesi ai Sonetti a Orfeo, è evidentemente un’altra fonte primaria di ispirazione per Sorrentino. Ma in questo caso c’è un prelievo preciso che attesta il debito nei confronti del maggior poeta orfico del Novecento.
Anche Rilke tuttavia, come molti poeti simbolisti, attinge a piene mani all’immaginario orfico per cui, per esempio, nella famosa X Elegia duinese, la sua elusiva immagine della Dolente (Klage) appare proprio come una figura di Demetra in lutto ma sempre pronta come vuole il mito a ricompensare chi l’aiuta e a prendersi cura specialmente dei giovani: così Rilke: “una Dolente più anziana/si prende cura dell’adolescente, quando lui/chiede.” Questo tema del ricambio generazionale, della cura dell’esserci, del circolo fecondo fra passato e avvenire è come abbiamo visto ricorrente nel nostro testo e culmina – assumendo una dimensione ecologica, celebrando la riunione di Madre e Figlia/o e la palingenesi del mondo, nella sezione finale intitolata Giovane monte in mezzo all’ignoto, dove si legge per esempio: “tutta la nostra attesa era/ in una madre che ritorna…qui dove si tace di gioia,/tace su tutto chi possiede/ quello spirito del futuro/sopra le rovine.” (94) Oppure: “tesse il suo divino l’umano/giovane monte in mezzo all’ignoto…saluta la bellezza/ tu sei nato” (95) E si confronti ancora con la X Elegia duinese, dove la “Dolente più anziana”, figura di Demetra, “la fonte della gioia”, viene nominata con reverenza da una/uno più giovane ed entrambi “stanno ai piedi del monte” rapiti in un vortice di “felicità ascendente”. Come già nel caso di Campana, anche qui la condivisione dell’immaginario orfico risulta evidente.
La ricognizione di questi prelievi, scambi e composizioni di luoghi credo giovi alla collocazione e all’ascolto del testo da parte del lettore che potrà così cogliervi i numerosi echi mitici e letterari che esso contiene. Non posso ulteriormente dilungarmi nei dettagli. Mi basta avere fornito alcune coordinate e indicato una possibile cornice di riferimento. Voglio però aggiungere un ulteriore spunto per la lettura, stavolta con riferimento alla componente orfica dell’esoterismo greco e allo smembramento rituale di Orfeo-Dioniso di cui ho già detto. Esso è connesso infatti nel nostro testo alla tensione tra gesto, voce e sguardo, a connotare l’avvenire e il rinnovamento della parola poetica, le sua reincarnazione in forme nuove e cangianti. Insomma quell’attimo fuggente in cui l’immagine si fa parola, sulla porta della Ade, soglia del dicibile e del visibile, come ho detto, là dove Orfeo ha condotto e perde l’ombra amata.
L’orchestrazione del tema della anamnesi (anch’esso squisitamente orfico) e la mobilitazione dei piani della memoria nel gioco insistito di voce e sguardo, a connotare la vocazione poetico-esistenziale dell’anonima protagonista, è infatti uno dei tratti salienti di Olimpia. Come si vede, per esempio, nell’atmosfera onirica della sezione Il contrasto fra il divino e il tempo, nel seguente passo: “la voce chiamava, portava/in sé tutto lo spazio dilatato/e solenne di un tempo infinito/tagliava una sapienza/i cui tratti erano netti/…la vista mobile…denudato e morbido il tocco/della voce, tutto riceve/come un nuovo levarsi/in te che fosti alla soglia del vento.” (47) Nel vacillare tra memoria e oblio, e nel continuo deliberato esercizio gestaltico tra figura e fondo: “inesauribile sul fondo/scomparsa si deposita/premendo negli occhi la rara/bellezza/imperfetta resta lì sul confine” (84). Fino alla squisita risoluzione del tema nella penultima figura, l’epifania dell’androgino, l’unione di sguardo e voce, soma e sema, essere e coscienza, nell’effimera compiutezza dell’immagine: “la sua bellezza raccolta in una/sola luce liberata…prima che potesse/sfiorire era accolta, ascoltata, nell’equilibrio dei fiori… lei c’era, è esistita.” (96) E alla stupenda convergenza finale di essere e divenire, vita e forma, tempo e eternità: del fuoco e della rosa, in quel rinnovato battesimo del mondo che è ancora sempre la psicacogia di Orfeo, il sortilegio della voce poetica che “sa e canta con la bocca/la lode della rosa, il cuore acceso in rovina”, mentre “il tempo brucia ma resta” e il battesimo dell’immagine desta un “chiaro brivido che all’indietro guarda/ e sorregge il lontano in quell’istante/la rosa.” (97) E’ l’immagine bella di Euridice, fiore tra i fiori, sottratta per un attimo alle tenebre e all’oblio e fissata in eterno.
Ora che abbiamo compiuto il nostro viaggio sulla parte in ombra del mito, la religione misterica, possiamo infine tornare alla luce di Olimpia e apprezzarne meglio la sottile testura dei motivi e delle immagini, nonché il senso della suspense che ci comunica questo poema integralmente e felicemente orfico. Con la consapevolezza acquisita che sotto la luminosa architettura della città dei giochi, come in ombra, traspare quella di Eleusi, il suo doppio ctonio, le sue sparse rovine, città vecchia e nuova, arché ed éschaton, fondamento e destino, memoria e promessa di ciò che appare ora in piena luce, il complemento misterico del mito greco e l’annuncio del suo smembramento cerimoniale nell’arte e nel pensiero dell’Occidente.
[1] I numeri in parentesi si riferiscono alle pagine di questa edizione (Interlinea, 2013; Ristampa 2019).
Giuseppe Martella ha insegnato letteratura e cultura dei paesi anglofoni nelle Università di Messina, Bologna e Urbino. I suoi studi riguardano in particolare il modernismo inglese e europeo, l’ermeneutica letteraria e filosofica, i rapporti tra scienza e letteratura, e tra letteratura e nuovi media.
Da alcuni anni si interessa anche di poesia italiana contemporanea, collaborando con diverse riviste cartacee e online (La Clessidra, Poesia Blog Rainews, Poetarum Silva, Versante Ripido, Carteggi Letterari). Non ha finora pubblicato versi propri.
Fra le sue pubblicazioni accademiche:
Ulisse: parallelo biblico e modernità, Bologna, Clueb, 1997.
Margini dell’interpretazione, Bologna, CLUEB, 2006.
- Martella, E. Ilardi, Hi-story. The rewriting of History in Contemporary Fiction, Napoli, Liguori, 2009.
Ciberermeneutica: fra parole e numeri, Napoli, Liguori, 2013.
Tecnoscienza e cibercultura, ARACNE, Roma, 2014.
