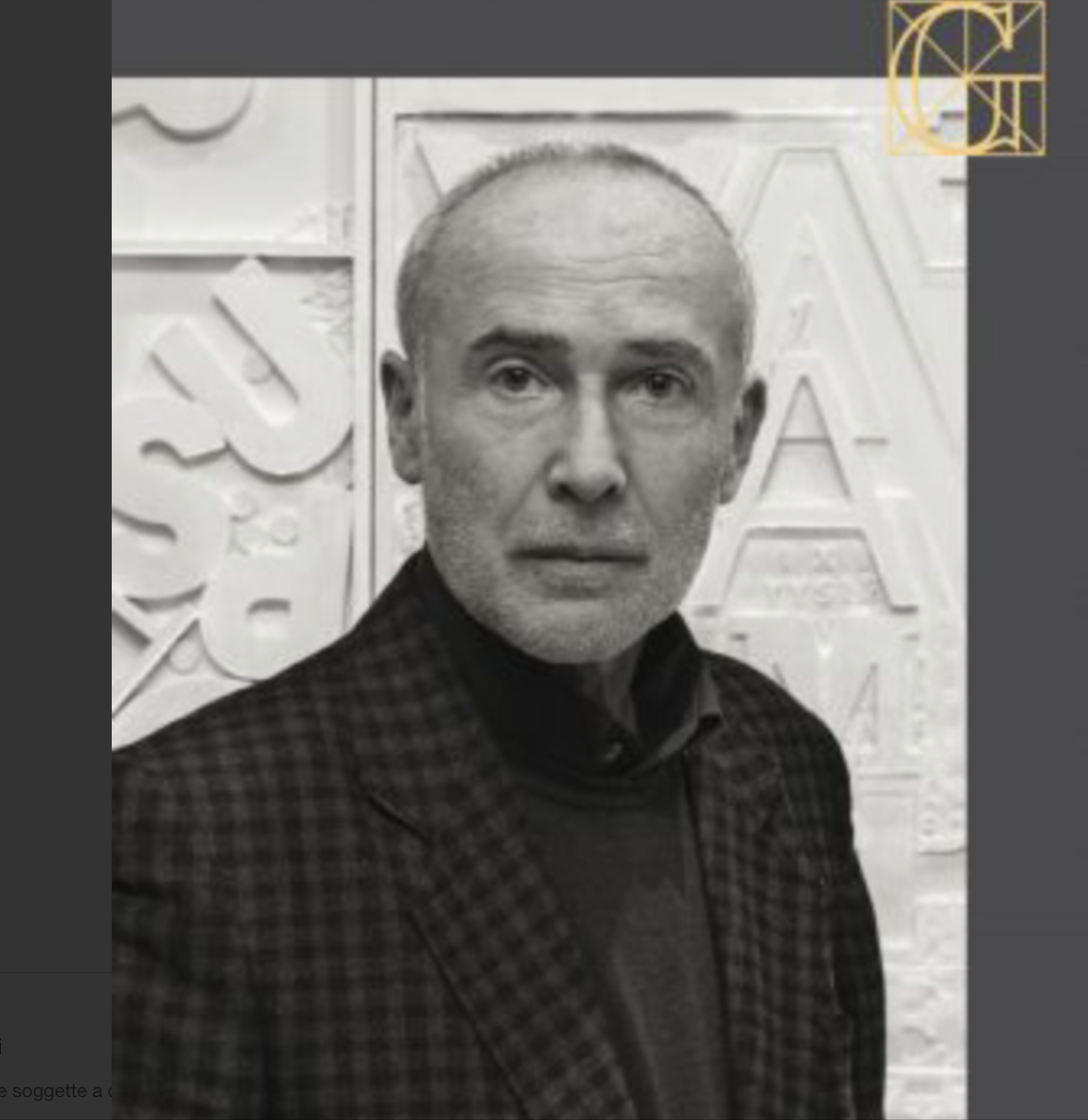 Appunti sul paesaggio in Andrea Zanzotto e Mario Benedetti
Appunti sul paesaggio in Andrea Zanzotto e Mario Benedetti
di Giovanna Frene
Non ho mai conosciuto di persona Mario Benedetti, e se questo può dispiacermi ora a livello personale, mi dà però una sorta di vantaggio a livello teorico e poetico, pensando essere ottimale per leggere un autore la condizione descritta Proust in un passo del suo Contro Sainte-Beuve: “Un libro è il prodotto di un io diverso da quello che si manifesta nelle nostre abitudini, nella vita sociale, nei nostri vizi. Un tale io, se vogliamo comprenderlo, possiamo attingerlo solo nel profondo di noi stessi, sforzandoci di ricrearlo in noi”. In questa distanza che la morte ha reso ormai incolmabile, Mario-Benedetti-poeta mi appare in questo suo io profondo che cerco di ricreare in me rileggendo i suoi testi, pensando che sono ciò che esattamente lui voleva rimanesse di sé stesso, qui isolata a casa e lontana da qualsiasi rumore di fondo del mondo che arrivi a disturbare questo suo puro messaggio nella bottiglia.
È in questo silenzio che mi è apparsa un’inedita vicinanza tra Benedetti e Zanzotto, il quale non a caso apprezzò e recensì alla radio svizzera Il cielo per sempre, la raccolta che Benedetti diede alle stampe nel 1989. Non è certo questo la spazio per esporre con una neppur lontana esaustività i punti di reciprocità tra i due poeti, ma un elemento che si può già da ora fissare riguarda il paesaggio. La portata dell’influenza della poesia zanzottiana ha tra le sue caratteristiche anche quella di avere tracciato degli holzwege attivi a livello geografico, sentieri che poi altri poeti hanno continuato con propri personali sviluppi, o con sviluppi del tutto altri; in questo senso, è chiaro che il cosiddetto “primo Zanzotto”, quello che potremmo dire più schiettamente paesaggistico, ha un rapporto diretto di paternità con un libro come Umana gloria, costruito e sedimentato su altri libri precedenti; anzi, è proprio da questo giovane Zanzotto elegiaco che scorga, seppur in maniera diversa, la dimensione poi potentemente elegiaca di Benedetti.
Tutto il “primo Zanzotto”, infatti, ha una componente elegiaca intrecciata a triplo filo con quella idilliaca: non c’è un solo punto dove il paesaggio, così massicciamente richiamato sul foglio perché costitutivo dell’identità del poeta, non venga altrettanto potentemente distanziato proprio attraverso l’iperletterarietà della scrittura, seppure con la ben nota funzione salvifica che si evince per esempio in un libro come Dietro il paesaggio; così come, rispetto al donativo del mondo, che si dà come paesaggio, il linguaggio ne riconosce l’intrinseco porsi ossimorico, rispecchiandolo attonito nella sua stessa corruzione e assolutezza; senza tralasciare, infine, quei punti dei primi libri zanzottiani dove l’elegia è esplicitamente richiamata nei titoli e nelle narrazioni delle poesie (i lutti, le perdite, la guerra, l’emigrazione ecc.). Questa dimensione di costante perdita della “piccola patria” si può riassumere in questi versi di Vocativo: “Mani, lingua, respiro, / dal cielo è questo mio conoscervi, / dal cielo vita immemore / ti componi al tuo sguardo e il tuo sguardo / dal cielo si compone”.
Posti i dovuti distinguo stilistici e linguistici, che fanno della poesia del poeta friulano un tessuto immediatamente riconoscibile, la dimensione elegiaca della poesia di Benedetti si esplica di nuovo attraverso il paesaggio, ma la distanza che lo caratterizza è quella della mancanza costitutiva: mentre per Zanzotto il filtro della memoria è un filtro linguistico in praesentia, per Benedetti sembra che ciò che viene evocato della sua piccola patria non avesse neppure nel tempo del suo presente una qualche valenza salvifica, e che anzi proprio allora si sia verificata quella dolorosa presa di coscienza di una costitutiva mancanza d’essere. Non a caso la tonalità tutta di Umana gloria viene data da poesia incipitaria come “Lasciano il tempo e li guardiamo dormire“: quel “Non abbiamo creduto che fosse così” riguarda, per dirla imitando le indeterminatezze del poeta, l’ogni futuro di “qualunque viso”, e quel “qui durano i libri” ci arriva infine come la sommaria sopravvivenza di un’entità puntuale destinata alla dispersione atomica. Per questo abbiamo la sensazione, ogni volta, nel rileggere la poesia di Benedetti, che rimpiange il nulla e lo sa guardare in faccia (e che per questo è tutt’altro che pavida), che al dire del poeta si sovrapponga la negazione del suo stesso dire, ma non in modo ossimorico come in Zanzotto, bensì coincidente, di modo che dalla fuga della realtà sovrapposta al dire del poeta risulta quella diffrazione del linguaggio che è tipicamente e solo benedettiana.
