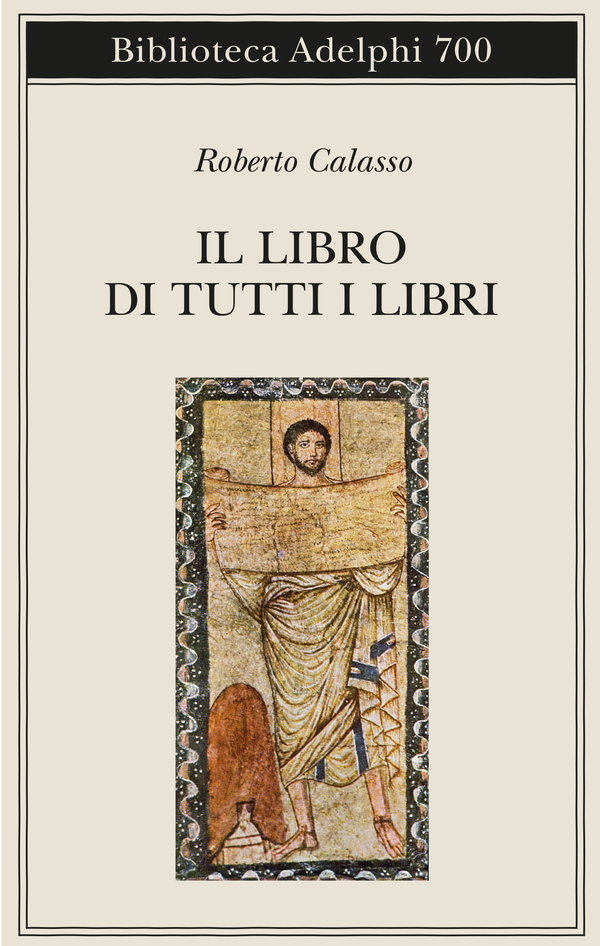Margaret Atwood
Morning in the Burned House
In the burned house I am eating breakfast.
You understand: there is no house, there is no breakfast,
yet here I am.
The spoon which was melted scrapes against
the bowl which was melted also.
No one else is around.
Where have they gone to, brother and sister,
mother and father? Off along the shore,
perhaps. Their clothes are still on the hangers,
their dishes piled beside the sink,
which is beside the woodstove
with its grate and sooty kettle,
every detail clear,
tin cup and rippled mirror.
The day is bright and songless,
the lake is blue, the forest watchful.
In the east a bank of cloud
rises up silently like dark bread.
I can see the swirls in the oilcloth,
I can see the flaws in the glass,
those flares where the sun hits them.
I can’t see my own arms and legs
or know if this is a trap or blessing,
finding myself back here, where everything
in this house has long been over,
kettle and mirror, spoon and bowl,
including my own body,
including the body I had then,
including the body I have now
as I sit at this morning table, alone and happy,
bare child’s feet on the scorched floorboards
(I can almost see)
in my burning clothes, the thin green shorts
and grubby yellow T-shirt
holding my cindery, non-existent,
radiant flesh. Incandescent.
Mattino nella casa bruciata
Nella casa bruciata faccio colazione.
Capirai: niente casa, niente colazione,
invece eccomi qua.
Il cucchiaio che si è fuso raschia
la ciotola che pure si è fusa.
non c’è nessun altro in giro.
Dove sono andati, il fratello e la sorella,
la madre e il padre? Via lungo il mare,
forse. I loro abiti sono ancora sulle grucce,
la pila dei piatti accanto al lavello,
accanto al fornello a legna
con la gratella e il bollitore incrostato,
ogni dettaglio è chiaro,
la tazza di latta e lo specchio grinzoso.
Il giorno è luminoso e senza canto,
il lago è blu, la foresta vigile.
A est un cumulo di nubi
lievita il silenzio come pane scuro.
Vedo i ghirigori nella carta oleata,
vedo i difetti nel vetro,
le vampe dove il sole batte.
Le mani e le gambe non me le vedo
e non so se è un problema o una benedizione,
ritrovarmi qui, dove ogni cosa
in questa casa si è da tempo estinta,
pentolino e specchio, cucchiaio e ciotola,
perfino il mio stesso corpo,
perfino il corpo che avevo allora,
perfino il corpo che ho adesso
mentre siedo a tavola stamattina, sola e felice,
piedi nudi di bimba sulle assi bruciacchiate
(li vedo quasi)
nei miei abiti in fiamme, i calzoncini verdi leggeri
e la maglietta gialla bisunta
che tiene insieme la mia inesistente, cinerina,
carne radiosa. Incandescente. Continua a leggere→



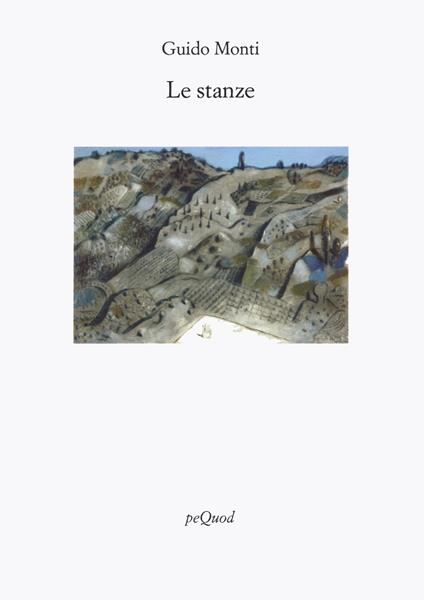
 Da Poesie di Vera Lùcia de Oliveira
Da Poesie di Vera Lùcia de Oliveira

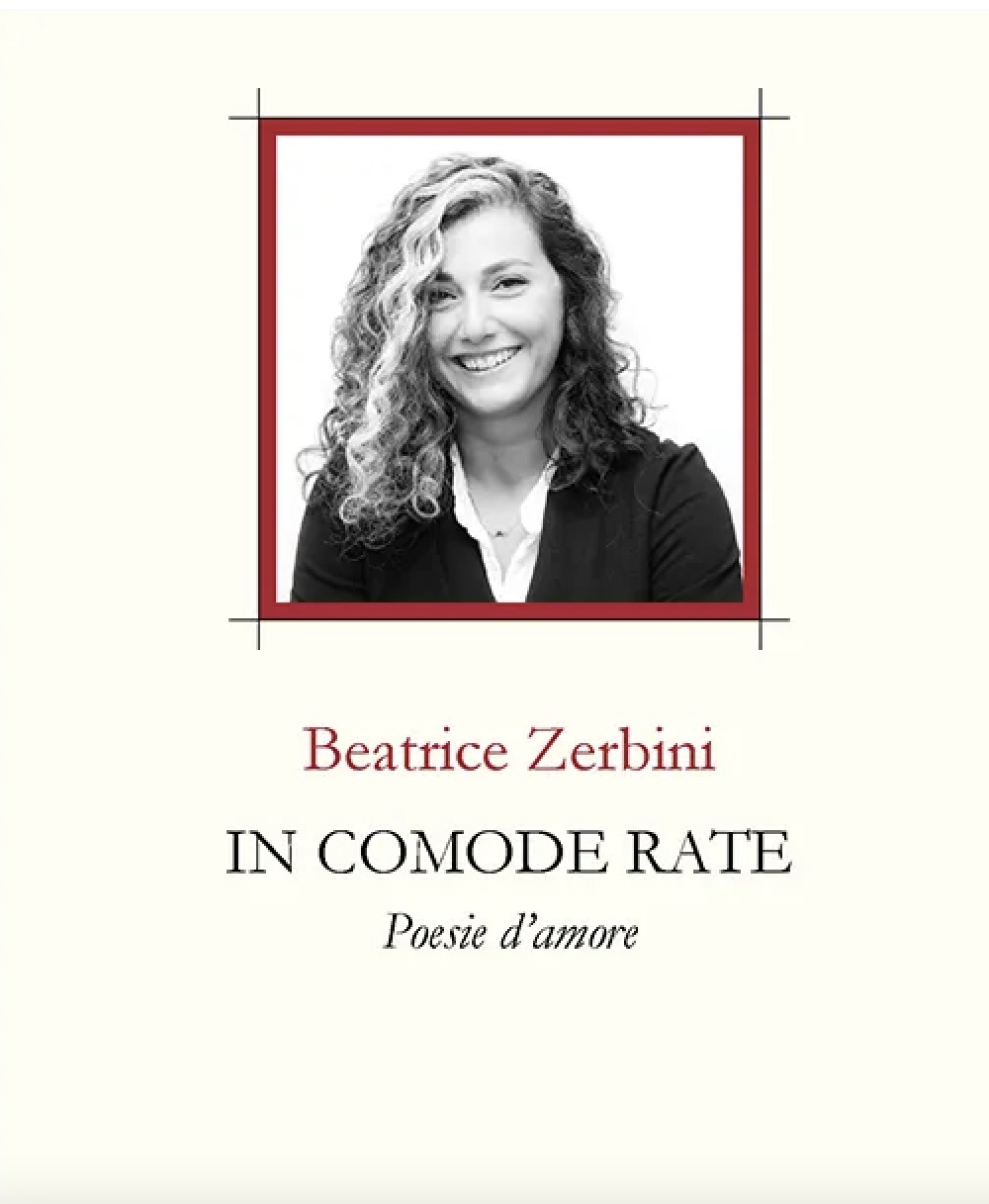 Domani è domani,
Domani è domani,

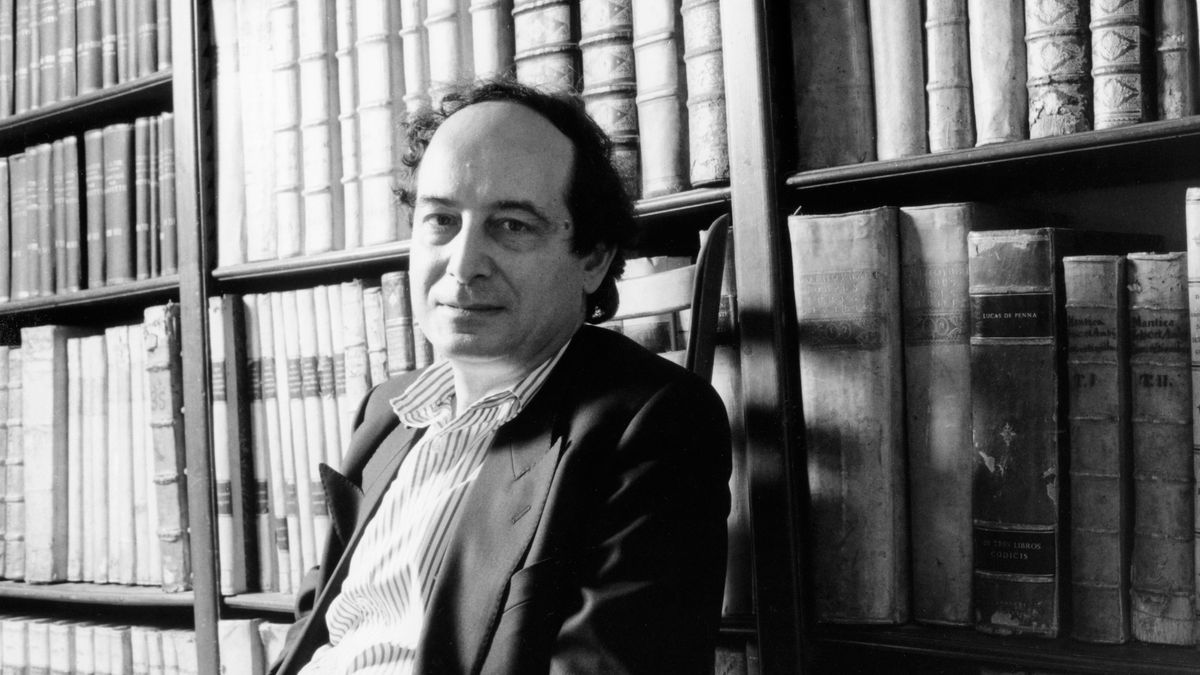
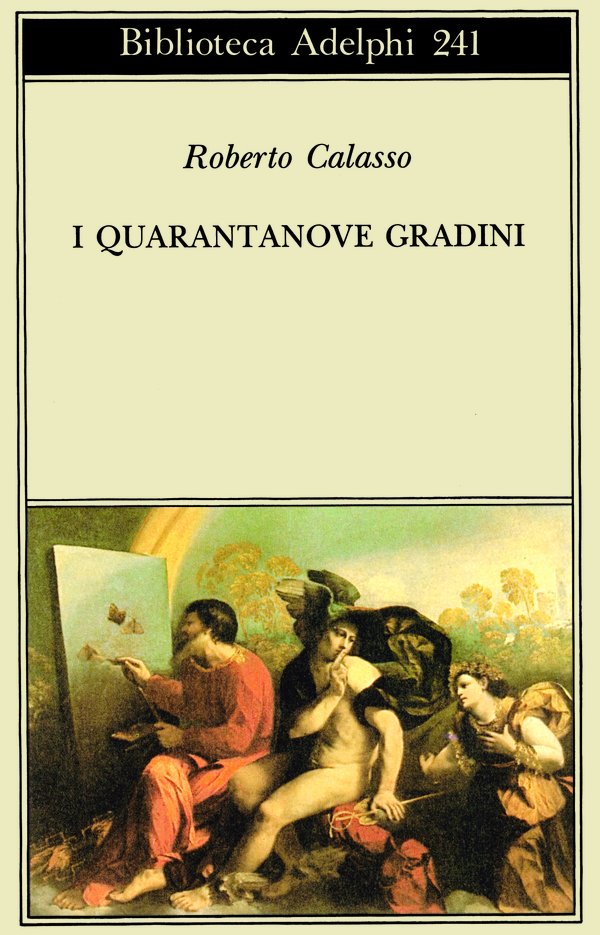


 Ma soprattutto c’è un ‘filo rosso’. Su questo vorrei soffermarmi. Sì, perché le multiple, multiverse e labirintiche scene della Scarpetta di raso sono riassumibili in poche battute: l’amore di Don Rodrigue per Doña Prouhèze. Un amore ovviamente contrastato, che cerca di fissarsi nell’eterno e che ha suscitato splendide riflessioni — dal teologo Hans Urs von Balthasar a Carlo Bo — sulla natura non soltanto pragmatica (affettiva) di questo amore, ma anche per i suoi significati simbolici, filosofici, teologici. La storia è semplice: in un Seicento ancora fortemente ‘combinatorio’ Prouhèze è sposata prima con l’anziano Don Pelayo, poi — morto il coniuge — con il vile Don Camille. In entrambi i casi non può venir meno al vincolo matrimoniale, che accetta per obbedienza e per necessità. Don Rodrigue, che lei ama riamata, non può che desiderarla in un altro spazio e in un altro tempo, oltre le catene della necessità.
Ma soprattutto c’è un ‘filo rosso’. Su questo vorrei soffermarmi. Sì, perché le multiple, multiverse e labirintiche scene della Scarpetta di raso sono riassumibili in poche battute: l’amore di Don Rodrigue per Doña Prouhèze. Un amore ovviamente contrastato, che cerca di fissarsi nell’eterno e che ha suscitato splendide riflessioni — dal teologo Hans Urs von Balthasar a Carlo Bo — sulla natura non soltanto pragmatica (affettiva) di questo amore, ma anche per i suoi significati simbolici, filosofici, teologici. La storia è semplice: in un Seicento ancora fortemente ‘combinatorio’ Prouhèze è sposata prima con l’anziano Don Pelayo, poi — morto il coniuge — con il vile Don Camille. In entrambi i casi non può venir meno al vincolo matrimoniale, che accetta per obbedienza e per necessità. Don Rodrigue, che lei ama riamata, non può che desiderarla in un altro spazio e in un altro tempo, oltre le catene della necessità. 
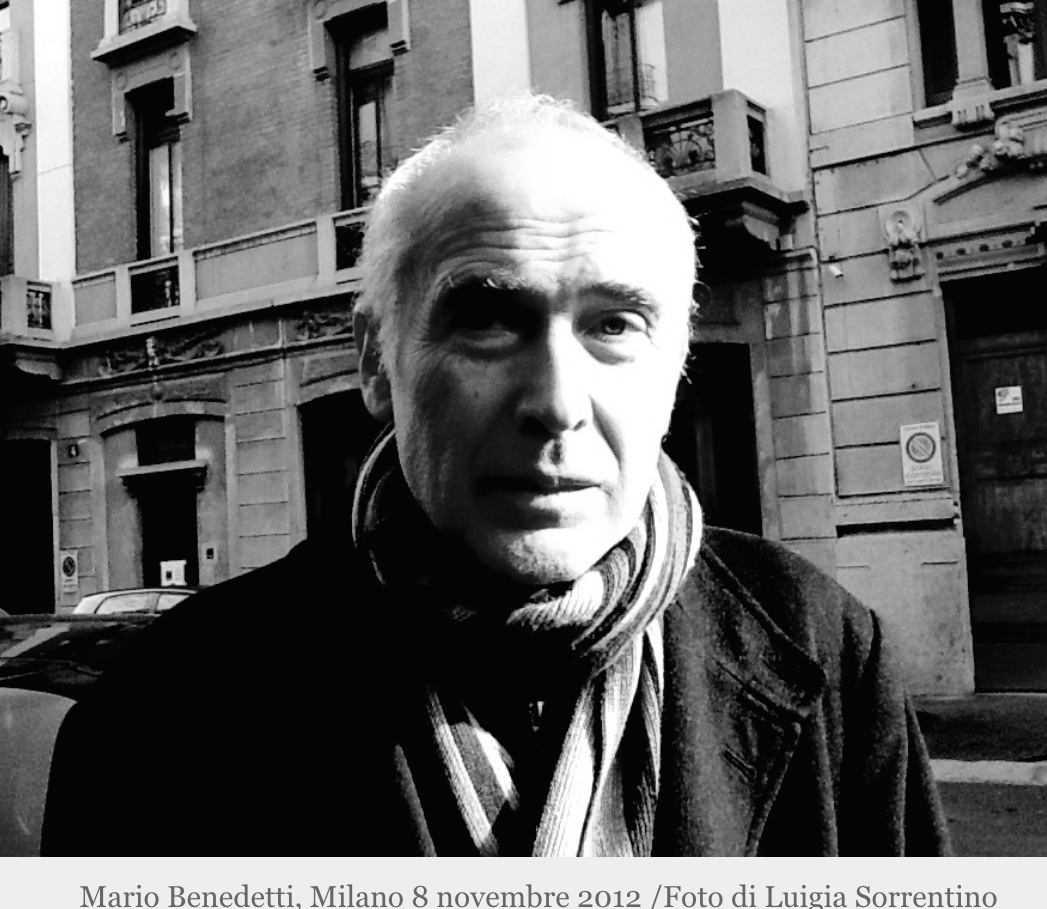












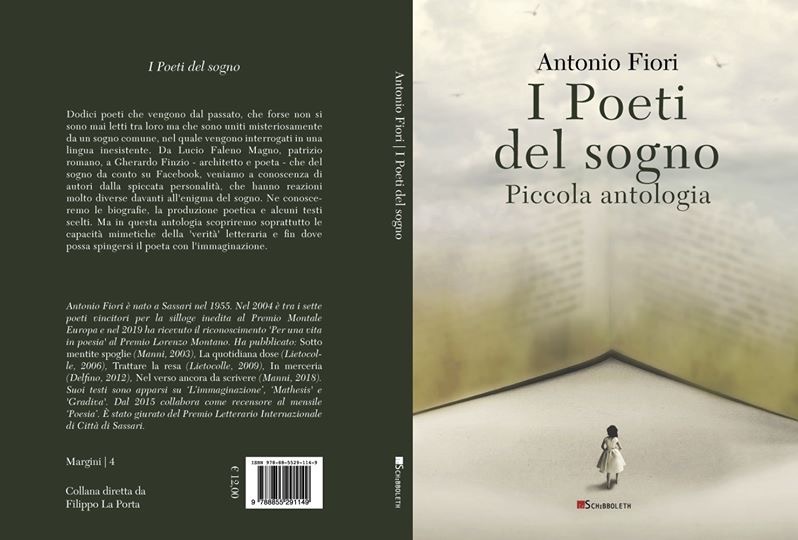





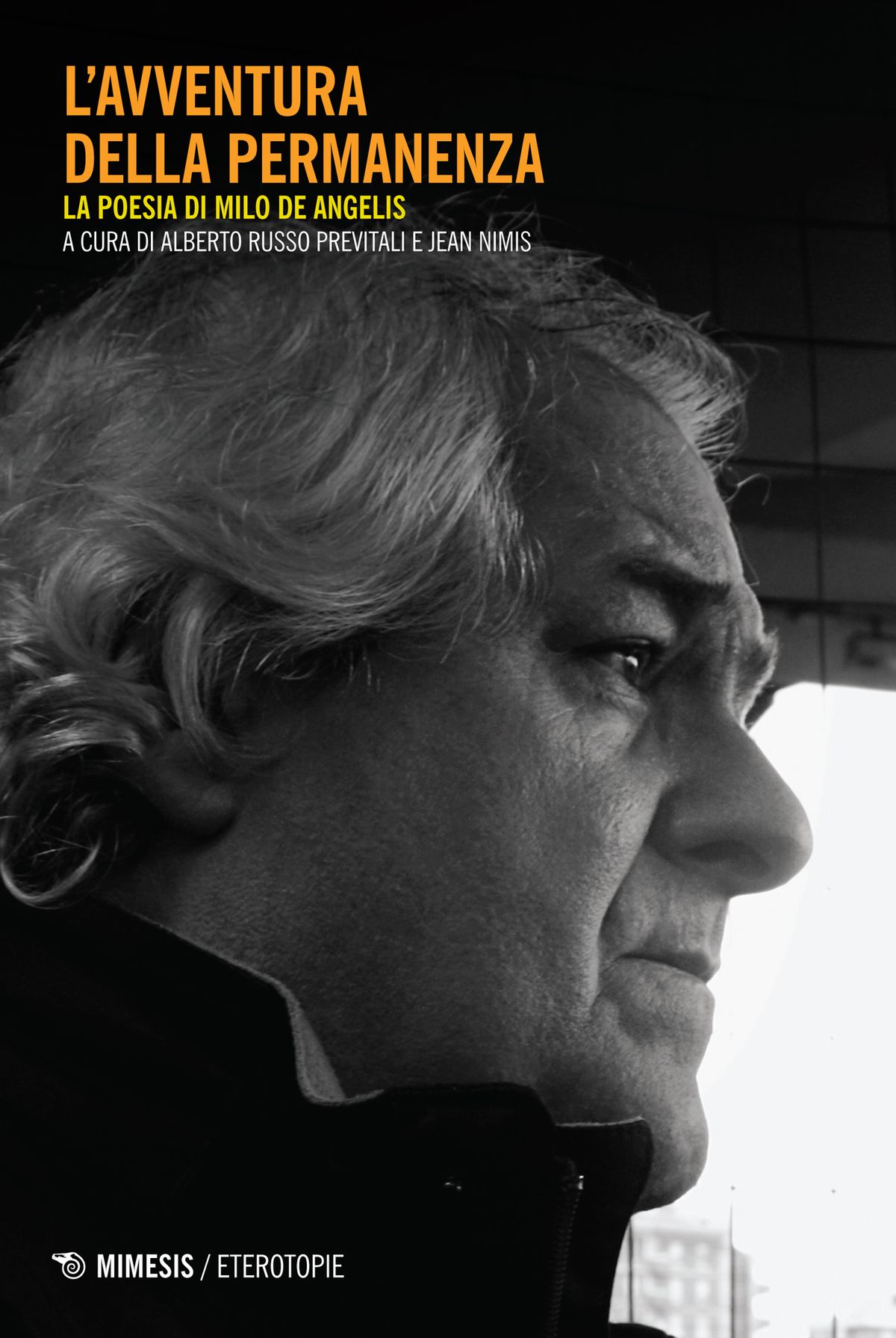 RECENSIONE DI ALBERTO FRACCACRETA
RECENSIONE DI ALBERTO FRACCACRETA
 *
*

 La descrizione degli ebrei d’Europa si fonda sul terrorismo di un esercito contro inermi di ogni età e sesso. L’invasione della Polonia, settembre 1939, è accompagnata da annunci radio dei tedeschi in polacco che invitano la popolazione a nulla temere da loro. “Ma l’ebreo”, grida di colpo la radio, “l’ebreo deve tremare.”
La descrizione degli ebrei d’Europa si fonda sul terrorismo di un esercito contro inermi di ogni età e sesso. L’invasione della Polonia, settembre 1939, è accompagnata da annunci radio dei tedeschi in polacco che invitano la popolazione a nulla temere da loro. “Ma l’ebreo”, grida di colpo la radio, “l’ebreo deve tremare.”



 ESTRATTO DALLA PREFAZIONE DI MARCO SANTAGATA
ESTRATTO DALLA PREFAZIONE DI MARCO SANTAGATA