 Biancamaria Frabotta (nella foto) una delle più importanti voci poetiche contemporanee, in Quartetto per masse e voce sola (Donzelli, 2009) traccia un bilancio raccontando cinquant’anni di esperienze, memorie, riflessioni, di una donna poeta.
Biancamaria Frabotta (nella foto) una delle più importanti voci poetiche contemporanee, in Quartetto per masse e voce sola (Donzelli, 2009) traccia un bilancio raccontando cinquant’anni di esperienze, memorie, riflessioni, di una donna poeta.
Chiunque voglia accostarsi per la prima volta alla poesia di Biancamaria Frabotta non potrà prescindere da questo piccolo libro, un autoritratto che scandisce il mondo interiore della poetessa attraversando anche la Storia d’Italia del secondo Novecento: il Sessantotto, gli anni del femminismo, la poesia plurale, la crisi politica e culturale. Biancamaria Frabotta nel suo autoritratto mette isieme le due facce: l’eternamente presente e l’eternamente fuggito, che costituiscono il volto della poesia.
Intervista di Luigia Sorrentino (Roma, 28 settembre 2009)
Nella sinfonietta “Quartetto per masse e voce sola” si incontrano quelli che lei definisce “volti senza padrone”. Una galleria di confessioni rubate e trasferite in una profondissima emozione lirica che fotografa e fissa in una istantanea il passato e il presente. Autoritratto, dunque, doppio, plurimo, spennellate rapide, del tempo che ci scivola accanto in un ingorgo tra pubblico e privato tutto proiettato verso Il tempo a venire. Parliamo del titolo, che non è un vezzo estetizzante…
Il titolo Quartetto non è un vezzo estetizzante. Si tratta di quattro variazioni su un tema centrale, l’iniziazione alla poesia connessa al profondo rapporto che spesso le donne hanno con la madre. O meglio ancora la loro esecuzione su quattro diversi strumenti. Quattro generi letterari, se vogliamo: la memorialistica, personale e in qualche parte anche generazionale, la critica letteraria, il racconto di viaggio, il saggio etico-politico. Il collante di tutto ciò è un autoritratto “onesto” se possibile, con un io fittizio, ma responsabile. Un vecchio slogan del femminismo degli anni Settanta ricordava che il personale è politico, nell’esistenza delle donne. E io credo che lo sia nella vita di tutti noi, ieri, come oggi, come sempre. Se per politica non s’intende naturalmente una gestione privatistica di affari che vengono spacciati per pubblici e non lo sono. La voce sola è quella del poeta che non può cantare nel coro, a meno che non lo scelga per una vocazione penitenziale o populistica. Ma oggi la solitudine non esiste, se non nelle plaghe di disperati paesi senza vita e senza economia. Le masse sono il tuorlo universale in cui l’embrione di ogni pensiero, o sentimento galleggia, naviga, soffoca, rinasce. Questi sono i nostri tempi. Possiamo anche, come Pasternak, affacciarci alla finestra e chiedere ai bambini che giocano nel cortile: quale millennio è oggi bambini? Ma costa sangue e lacrime. Di solito, altrui.
Nel capitolo “Una pluralità di poeti” lei fa un confronto tra la “milanesità” tutta moderna, contemporanea, che a partire da Sereni passando attraverso la “Ragazza Carla” di Pagliarani arriva fino a Cucchi e De Angelis producendo opere mature e importanti, e la “romanità”, povera di poeti autoctoni, come Belli, Cardarelli e Vigolo, ma ricca di autori “romanizzati” che però, secondo lei, non sono riusciti a dar vita a una vera scuola di poesia. Come spiega questa differenza tra Roma e Milano? Perché Roma non riesce a costituire una vera scuola di poesia, ma solo singoli poeti?
Per dir la verità credo che un poeta, un singolo poeta, uomo o donna che sia, non pensi mai a creare una scuola di poesia. La parola “scuola” non si adatta allo scontroso stare al mondo di chi è già sin troppo occupato a tenere a bada il continuo rimuginìo di parole che trovano pace solo nel felice rifugio di un verso. Non voglio dire che i poeti non abbiano amici con cui incontrarsi, far comunella, scambiarsi qualche futilità. E’ un modo di stare accanto l’uno all’altro, un po’ come i bambini, che non hanno molto da dirsi, se non fantasiosi vaniloqui accompagnati da gesti, toccamenti sfuggenti, umbratili mutamenti di umore. Né voglio insinuare che un sodalizio tra poeti non possa riguardare il loro comune pensare la poesia o il mondo. I poeti non smettono mai di pensare, ma in un loro curioso inafferrabile modo. Le scuole hanno bisogno di aule, banchi, interrogazioni, riconoscimenti. E soprattutto di ordine. Nemmeno a Milano, credo, si sia mai inteso creare una scuola. Nel Quartetto poi io attribuisco diversi comportamenti ai poeti delle due città. A Milano mi fermai la prima volta a leggere le prose inedite di Carlo Cattaneo conservate nel Museo del Risorgimento, ma anche, negli anni Settanta, ne attraversai il centro blindato e terrorizzato da implacabili manifestanti. Un critico puro dovrebbe cercare ciò che trova nei libri. Un poeta critico vede ciò che altri non hanno dentro di sé. E che in qualche modo è già predisposto ad essere colto. E così Roma mi è sempre parsa inafferrabile, sfuggente, indisciplinata, inclassificabile e non rappresentabile. I suoi poeti, quasi tutti immigrati dentro la sua simbolica cerchia di mura, come potrebbero sfuggire a questa eccezionalità?
In “Elogio del fuoco”, che si trova nella parte finale della seconda parte del libro, lei fa un’auto-descrizione fisica ed uditiva di una delle più grandi poetesse del Secondo Novecento, Amelia Rosselli. Lei tiene, peraltro, un corso monografico all’Università “La Sapienza” di Roma proprio su Amelia Rosselli che – tutti sanno – frequentava e amava moltissimo i giovani. Quale è stato il rapporto tra lei e Amelia Rosselli, e che eredità le ha lasciato?
Il “pezzo” di cui lei parla a dir la verità è un elogio funebre. Lo lessi a Roma, davanti al feretro di Amelia nella Casa della Cultura il 16 febbraio 1996. E a stento, facendo fatica a trattenere le lacrime. Amelia morta, Amelia suicida era un pensiero insostenibile. La sua poesia oggi diventa presto popolare fra i giovani, soprattutto donne, che la incontrano nei miei corsi di poesia. Si dice che il pubblico giovanile resti lontano dalla poesia dei Grandi e preferisca occuparsi solo di sé stesso in un’autoreferenzialità cocciuta ed esaltata. E forse è vero. Ma con un poeta intrattabile (parlo delle sue poesie, non di un carattere che può oggi apparire soltanto la mitica proiezione di un tempo stellarmente lontano dal nostro) come Amelia Rosselli, è diverso. Non possono parafrasarla, ma la capiscono e vi si assimilano, a loro modo. L’eredità che mi ha lasciato? Urticante e dunque indimenticabile. Le prime poesie che pubblicai su “Nuovi argomenti” ne portano il segno. Ma capii presto che bisognava liberarsi dell’inevitabile epigonismo cui ci dannava. E contemplarne la straordinaria intelligenza “altra” un po’ da lontano, assorbendola a piccole dosi. Un’isola ignota è meglio desiderarla e non violarla nella realtà.
“I nuovi climi” la raccolta poetica che ha pubblicato nella collana di poesia curata da Maurizio Cucchi è una poesia che acquista nuovi spessori nel segno di una nitidezza affabile e una sapienza del tutto esente da effetti letterari. Una raccolta che risente della formazione milanese, di Saba, una poesia che rinuncia a qualsiasi inquietudine, una voce pacificata, serena, composta, che non si discosta dalla contemporaneità, anzi, ne è permeata.
Come si colloca questa opera all’interno della sua vasta produzione poetica?
Pacificata? Serena? Avrei qualche dubbio ad applicare a I nuovi climi che, nella sezione omonima, si svelano nella loro imprevedibile distruttività, questi aggettivi che alludono a una condizione d’animo che non disprezzo affatto. Ma che non merito. La compostezza invece mi appartiene e non certo per un retrivo bisogno di ordine, ma per una faticosamente raggiunta saggezza stilistica, in primo luogo. Non sapienza, prego. Ma saggezza, amicizia offerta e ricambiata fra sé e quello che si scrive. Tocco delicato, lento, controtempo e controcorrente. L’ego sbandierato stanca, alla lunga, se resta la unica nostra compagnia. Parlare di noi a noi stessi ci compensa, ma che noia! Solo con me stesso ancora non mi annoio, scriveva Giorgio Caproni. Beato lui. Un poeta scontroso, ma anche amante dell’umanità, diffidente della metafisica. Sofferente e partecipe. Per me resta un modello. Non letterario, metrico o tematico. Mistico, direi.
Lei prima di pubblicare “I nuovi climi” con Giorgio Devoto, l’editore di San Marco dei Giustiniani (Genova 2005) ha pubblicato “Gli eterni lavori”, con prefazione di Giorgio Patrizi, una raccolta molto significativa, che ha quasi introdotto la sua poesia successiva. Il discorso poetico già in quest’opera si è soffermato sulla percezione della natura, orientando la sua scrittura verso un confronto tra la storia individuale degli uomini e la natura, così come essa si presenta.
L’eterno lavoro è quindi dare conto di questa relazione?
La ringrazio per questa domanda che mi assilla da qualche anno. Il che vuol dire che ogni risposta qui intessuta, risulterebbe fittizia. L’occasione di quelle poesie che apriranno il mio nuovo libro è semplice: una casa, tra campagna e mare, in Maremma, circondata non da un giardino, ma da un campo. Bellissima parola, naturale, ma anche astratta, indicibile. Un campo da contemplare? Da lavorare? La natura che per la prima volta ho guardato da vicino, anche se con i vizi congeniti della cittadina che non sa riconoscere nelle piante i tagli dell’anno precedente (eppure è da lì che vigorosa parte la ricrescita) non lesina dure lezioni a chi vorrebbe addomesticarla in un idillio. Mirabolante e crudele (Dio è un arredatore, ho sentito dire nell’ultimo film di Woody Allen) smentisce facilmente il nostro vanto di creature civilizzatrici. E’ un po’ come con la poesia. Grazia, o lavoro? Dono, o fatica? Da anni rileggo Vita activa di Annah Arendt. Le sue pagine sul lavoro e sulle opere umane sono stupende. Ma la poesia, dubito, che possa veramente avvalersene. E mi perdoni le solite poche e confuse idee senza cui non si scriverebbe più nemmeno un verso.
da: “Elogio del fuoco” di Biancamaria Frabotta
Davanti alla bara di Amelia Rosselli
Roma, 16 febbraio 1996
“Il fuoco riscalda.
A leggere la poesia di Amelia, la temperatura del nostro corpo si altera un po’. Talvolta si abbassa più spesso si innalza. E non diversi effetti scaturivano dall’ascolto, dalla sua viva voce di straordinaria lettrice. Lei ardeva per suo conto. Era con te, qualche volta contro di te, ma mai lontano da te. Ti metteva a parte dei suoi segreti, ma non della sua intimità. Amelia era furiosamente, strenuamente pudica.
Il fuoco disinfetta.
E cauterizza le piaghe. Lei ci comunicava i suoi incubi, i mali che la torturavano e insieme i suoi paradisi, la gioia del tempo, la passione politica che l’ha sempre agitata, e tutto, il male, come il bene supremo, acquistava un solo tono, il suo. La sua voce era un basso profondo, una musica che faceva lievitare la fondamentale tra le parole rese singole e compenetrate le une nelle altre. Un campo di spighe uniformemente mosse al vento eppure così variate, inafferrabili a un solo colpo d’occhio. Mai un grido nella sua recitazione, eppure quanti soprassalti nelle sue poesie! Per lei hanno nominato Campana, Rimbaud. Ma nulla le era più estraneo dello sregolamento dei sensi, dello sfrenato abbandonarsi all’altra voce che urge quando la ragione tace. In lei parlano entrambe, la ragione della mente e quella che piove dall’Altrove, in una educata, civilissima convivenza che non dimenticheremo mai.” […]
 “Il ritorno all’isola” di Daniela Attanasio, Nino Aragno Editore, 2010 (10 euro).
“Il ritorno all’isola” di Daniela Attanasio, Nino Aragno Editore, 2010 (10 euro).  Potrei parlarvi di altre cose, del tempo che non muore ma che riversa vita vissuta nel presente producendo nuovo linguaggio e nuova poesia -e questo in fondo è il senso dei versi : “Niente s’è spezzato. Nata. E sono ancora dentro quella nostalgia di vita che è una nascita”.
Potrei parlarvi di altre cose, del tempo che non muore ma che riversa vita vissuta nel presente producendo nuovo linguaggio e nuova poesia -e questo in fondo è il senso dei versi : “Niente s’è spezzato. Nata. E sono ancora dentro quella nostalgia di vita che è una nascita”.









 DIARIO FAMILIARE
DIARIO FAMILIARE
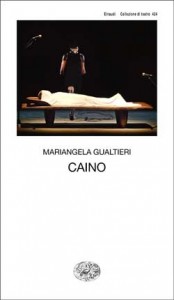




 “Ancora lui, come uno che si mette in mezzo alla strada con le braccia spalancate. O che per quanto resti di lato, appoggiato al muro, ha uno sguardo metallico e di fuoco, che ti inchioda passando.
“Ancora lui, come uno che si mette in mezzo alla strada con le braccia spalancate. O che per quanto resti di lato, appoggiato al muro, ha uno sguardo metallico e di fuoco, che ti inchioda passando.











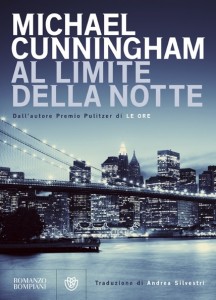








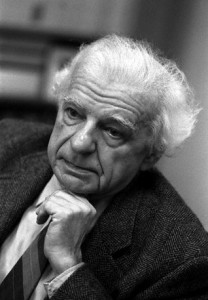





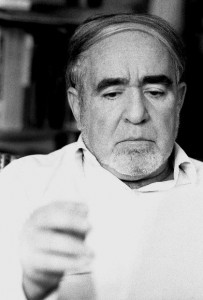


 Biancamaria Frabotta (nella foto) una delle più importanti voci poetiche contemporanee, in Quartetto per masse e voce sola (Donzelli, 2009) traccia un bilancio raccontando cinquant’anni di esperienze, memorie, riflessioni, di una donna poeta.
Biancamaria Frabotta (nella foto) una delle più importanti voci poetiche contemporanee, in Quartetto per masse e voce sola (Donzelli, 2009) traccia un bilancio raccontando cinquant’anni di esperienze, memorie, riflessioni, di una donna poeta.