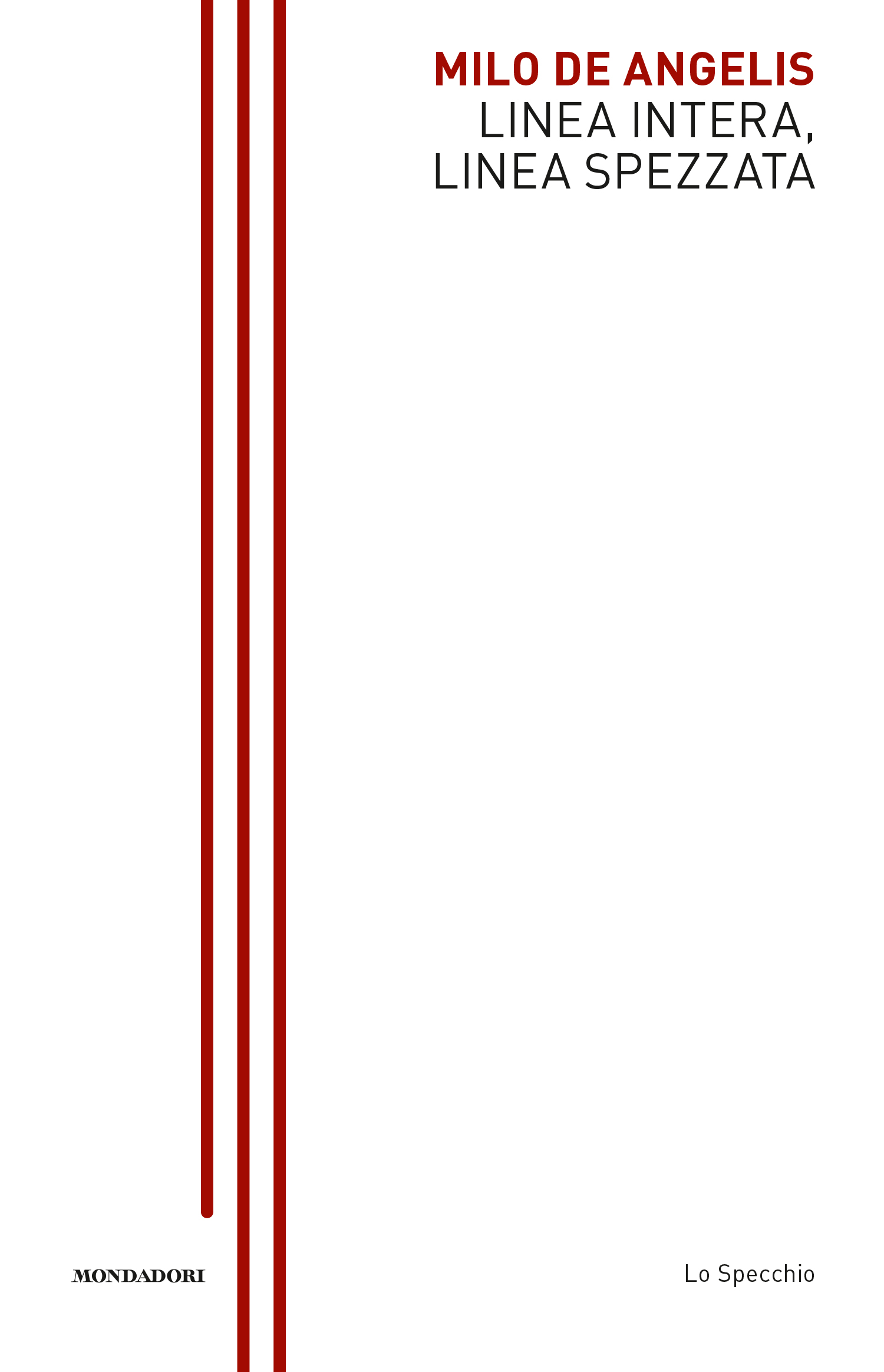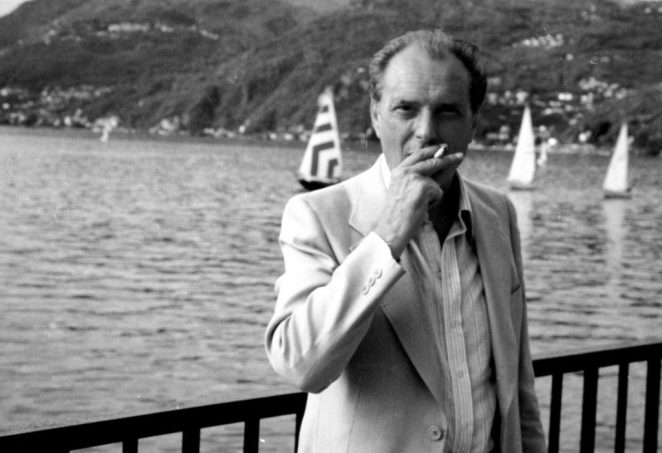Paolo Volponi
NOTA DI LETTURA DI ELEONORA RIMOLO
I versi inediti recentemente ritrovati del giovane Volponi, recentemente pubblicato da Einaudi (Poesie giovanili, 2020), risalgono alla seconda metà degli anni Quaranta, alle soglie del Ramarro e arrivano fino ai primi anni Cinquanta, epoca della pubblicazione dell’Antica moneta.
Questi testi colgono il poeta in un atteggiamento molto lirico e poco ermetico, a metà tra simbolismo e naturalismo: prevalgono stilisticamente parlando la frantumazione sintattica, antieroica e antidannunziana e la tensione poetica si concentra sul tentativo di costruire un dialogo sincero con la realtà circostante e con un mondo ancora troppo misterioso per un giovane seppur talentuoso poeta.
Volponi è divorato dall’angoscia della fuga da Urbino, così agognata e così temuta allo stesso tempo e da un immobilismo interiore che arde e infiamma il verso, in bilico tra eros e repulsione.
Protagonista assoluta e cornice di questi versi è la natura: alberi, colline, animali, campi, diventano parte del paesaggio intimo del poeta che canta il suo tumulto attraverso immagini di rara potenza espressiva.
Il tema della terra natale, quella adriatica, tra monti e mare, venata da un senso di nostalgia e di corruzione dell’esistenza è dunque al centro della riflessione volponiana in questo particolare periodo della sua vita, precedente all’incontro con Pasolini e con i sodales di «Officina» che modificherà radicalmente stili e contenuti del suo fare poetico e ancora lontano dalla sensibilità verso il mondo operaio e la meccanizzazione dell’umano.
da “Poesie giovanili” di Paolo Volponi, a cura di Salvatore Ritrovano e Sara Serenelli
Dieci spighe
intorno a un melo.
Le mele cadendo
scrollerebbero le spighe.
Avrei di che mangiare.
Un verme
tra i denti
mi servirebbe
per non esser solo. Continua a leggere




























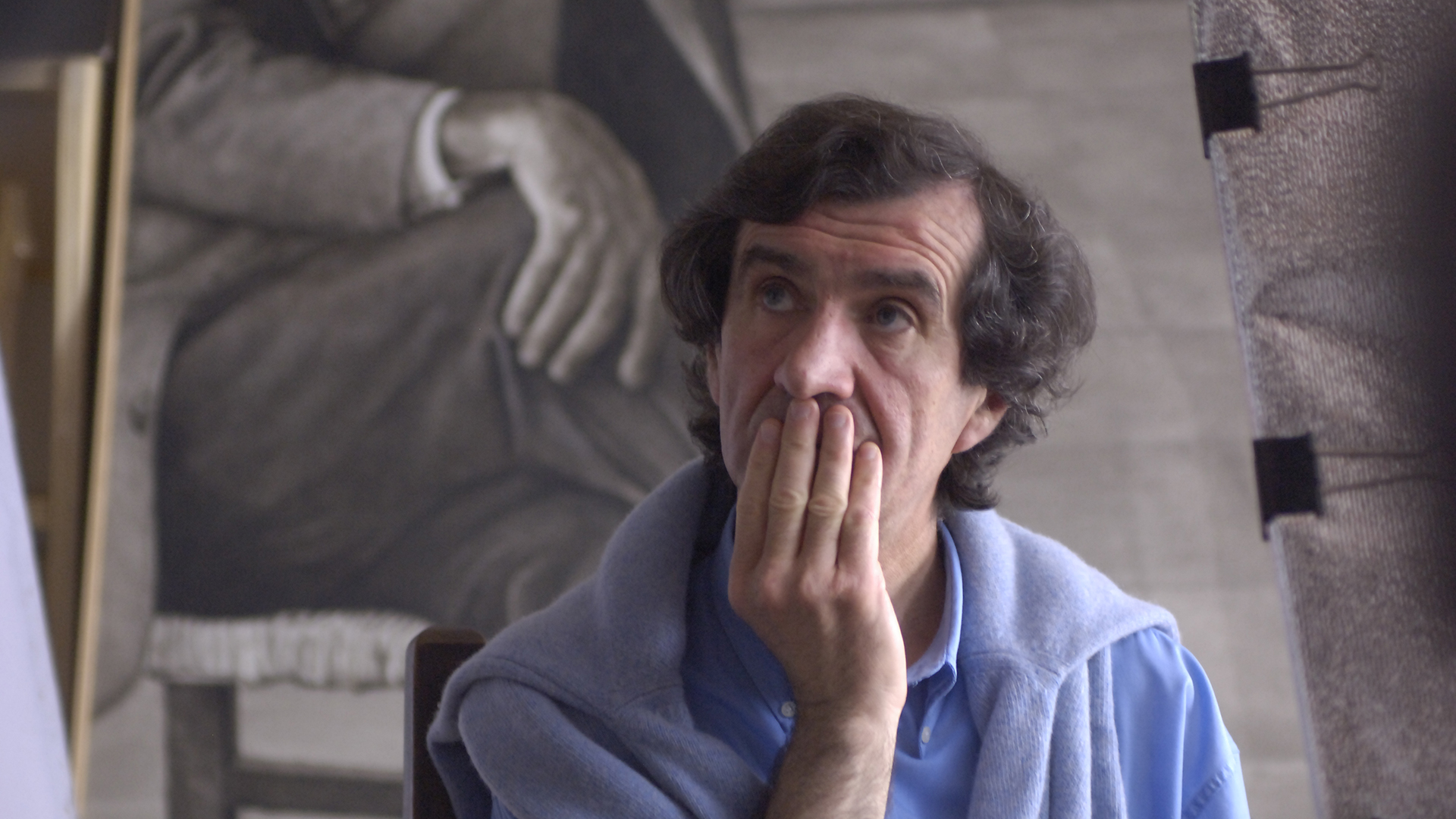





 Sandro Penna, fotografato a Roma nella sua casa in Via della Mola de’ fiorentini, sul lungotevere
Sandro Penna, fotografato a Roma nella sua casa in Via della Mola de’ fiorentini, sul lungotevere