Mattia Tarantino a due anni dalla morte di Gabriele Galloni si rivolge a lui per la prima volta con una lettera scritta dalla Grecia: “Abbiamo riso da morire”.

Mattia e Gabriele a Napoli da “Michele” in uno scatto fotografico di Simona Russo, 21 marzo 2019
Nota di Luigia Sorrentino
Oggi ricorrono due anni dalla morte del poeta Gabriele Galloni (1995-2020).
In questa speciale ricorrenza abbiamo scelto di ricordare Gabriele con una lettera scritta da Mattia Tarantino all’amico fraterno, Gabriele che ha diretto con Mattia la rivista Inverso fino al 2020.
E’ una lettera speciale per diverse ragioni: la prima e forse la più importante è che la lettera ci è arrivata dalla Grecia, dal Patras World Poetry Festival, un’importante manifestazione poetica internazionale con un ricco programma di eventi che si sono svolti in diverse sedi culturali dal primo al quattro settembre 2022. Un Festival al quale Gabriele avreva desiderato dì partecipare per vivere questa esperienza con Mattia e i loro amici poeti.
Per una strana coincidenza, Mattia proprio da Patras ricomincia a “parlare” con Gabriele, prima non era riuscito a farlo, e lo fa rivolgendosi direttamente a lui nella forma della epistola.
“Sono due anni che Gabriele mi parla con i suoi versi – ha detto Mattia Tarantino – sono due anni che mi invia segni, presagi, li semina sul mio percorso, segni che solo adesso sono riuscito a decifrare”.
Nella lettera indirizzata all’amico, Mattia ricorda che Gabriele facendo riferimento alla loro amicizia, aveva più volte invitato Mattia a leggere un libro I detective Selvaggi, di Roberto Bolaño, edito da Adelphi. Gabriele cioè aveva invitato Mattia a cogliere il legame che li univa: un “viaggio infinito di uomini che furono giovani e disperati, ma non si annoiarono mai”. I due protagonisti del romanzo di Bolaño sono Arturo (con il quale si identifica Mattia) e Ulises (con il quale si identifica Gabriele).
Fra i segni di questa particolarissima lettera sono poi richiamati molti altri protagonisti reali della vita di Gabriele Galloni e Mattia Tarantino: amici poeti, simpatici e allegri, ma già segnati dalla sconfitta e dalla follia di una generazione esaltante e allucinata. Fra essi ricorrono i nomi dei poeti Ilaria Palomba, Ilaria Grasso, Giorgio Ghiotti e poi Julia Gianferri, Ludovica Bernazza, Nicola Barbato e Giovanni Ibello.
Decifrare i segni, dirottare il presagio
Atene, settembre 2022
A Villa Kolla, Sotirios e Vanguelis si sono abbracciati. Uno poggiato all’altro hanno camminato insieme fino alle sedie, per prendere posto. Ridevano. “Da quanto tempo vi conoscete?” – “Ah, Mattia, non lo ricordo neanche…”.
Tornato in albergo, mi sono seduto al piccolo scrittoio davanti allo specchio. Dalla finestra, Patra era un crocevia tra i mondi.
Qualcuno cantava in cretese – lingua perduta, lingua irrimediabile – qualcuno in macedone. Qualcuno parlava della guerra, dei nonni, dei bombardamenti.
Due ragazzi, all’angolo della strada, suonavano la chitarra e bevevano un’ultima birra.
La sera prima di partire non ho preso sonno. Pensavo a Bolaño, a I Detectives Selvaggi. “Bello mio, devi proprio leggerlo; sì, si, parla di noi questo libro!”. Per tutta l’estate avevi detto che mi sarebbe piaciuto: capitava, in piena notte, me ne inviassi qualche pagina, oppure me la leggessi. Anche Julia lo stava leggendo, pochi mesi prima.
Ricordo che avevamo litigato, che per settimane non ci eravamo parlati, che c’era voluto tanto tempo per chiederci scusa. Alla fine, però, avevamo scelto di non lasciarci, di continuare insieme, “come Arturo e Ulises”: “Davvero, è pazzesco – c’è qualcosa della tua lirica, e di William Blake; i medesimi angeli vedete voi”.
Alla fine il libro l’ho letto nei giorni del tuo funerale.
Lo ricordo in cucina, a casa di Ilaria, accanto a un pacchetto di Winston. Blue 100’s, rigorosamente.
Ne parlai anche con Giorgio, e con mio padre. Eravamo strani, è vero. Mi chiedevi spesso cosa gli altri ne pensassero di te e io mi chiedo, adesso, cosa pensassero di noi.
L’anno prima diverse riviste e quotidiani parlarono di noi, di noi due insieme, e ci divertivamo, la mattina, a leggerli e immaginare cosa sarebbe successo se uno dei due fosse morto.
Su Carteggi Letterari, Giulio ci aveva chiamati Lucifero e Trismegisto, “compagni di merendine avvelenate. Quel giorno eravamo felici, proprio felici.
Insomma, dicevo, non ho preso sonno.
“Secondo me se andiamo in Grecia se divertimo, oh, ce tocca, là ci vogliono tutti bene”.
Mi sono alzato, ho preso le mie pillole, poi ho vomitato.
Ho acceso una sigaretta sul balcone, sulla Torre. Tu lo sapevi: la Torre nei miei libri non era un Arcano, non lo è mai stata; piuttosto il mio balconcino, il balconcino che conoscevi, con l’ulivo e le piante grasse, lo stesso di cui parlavo tanto spesso a Letizia, lo stesso in cui lessi a Ilaria Bonnefoy.
“Movimento e immobilità di Douve” è ancora il mio libro preferito.
Sulla Torre ci ho passato tutta l’estate – e che estate. Ho avuto paura, per la prima volta e a lungo, per mesi. Ho dovuto imparare a dormire con la porta aperta. Per qualche ragione ero convinto che così non mi sarei gettato, che mia madre avrebbe capito tutto un minuto prima che accadesse, che mi avrebbe fermato. In qualche modo, ho avuto ragione.
Devi sapere che, da alcuni mesi, la mia lingua è una geografia sotterranea – una “Mesopotamia dell’invisibile”, direbbe Giovanni – di cunicoli, scorci, trapezi. La prima parola, appena prima dell’estate, è stata “Passaggio”. Poi, “Porta”.
Ora c’è qualcosa che ha a che fare con il mondo di un dio-gufo, con un traghetto per Buenos Aires, con San Lazzaro e gli armeni.
Ho baciato la croce di Sant’Andrea, pochi giorni fa. Il bacio dell’Icona… Dimitris mi ha detto che ho fatto bene, che la croce è una sola e che qualcosa, nella liturgia, è stato tradito per sempre.
Abbiamo a che fare con la calce del sacro, con la sua crosta. Al posto dei capelli abbiamo delle candele accese con bastoncini d’incenso e al posto delle mani qualche rotolo di preghiere indifese, sconsolate, nervose. Qualcosa come una macchina-divina, come un’Asina che scalcia e prende il posto dell’Orsa:
Notte irrimediabile. La stella crepita, scortica, rischiara.
Fuori, qualcosa chiede un nome: è un dio dalla testa d’asino. Mascella robusta, pupilla trasparente e spiraloide. Dio Carnevale. Ascoltami: siamo di passaggio. Quel pane, la strada per la porta, cosa significa il cerchio che portiamo. Non chiediamo altro.
[…]
Vieni a me. Signore del ferro battuto, della sabbia arsa. Signore del latte alle ginocchia, dei merli di cenere. Qui la notte è bianca e io ti chiamo. Noi chiamiamo.
Quando sei morto era un anno che non scrivevo versi.
Solo tu, all’improvviso, avevi fatto in modo che rompessi il silenzio. Come un congedo, un dono d’addio.
Ora i quaderni non bastano, invece, ma i versi sono sciatti, quotidiani, giallognoli – proprio come quelli dei poeti che non ci sono mai piaciuti. I poeti che piacciono ai critici ma che non hanno un lettore, quelli a cui si chiedono dei versi inediti per l’autunno ma non riceveranno mai una lettera da qualcuno all’orlo, all’Orlo.
L’Orlo: se un’aldilà esiste, ed esiste, questo è il nome della stanza che ti è stata assegnata. Ne sono certo. A vent’anni ho capito questo, della vita, e che sono innamorato di tutte le cameriere del mondo e un cioccolatino lo accetterò sempre.
Penso anche che mentre scrivo l’Orlo si sia manifestato e abbia preso posto, ora, alla fine del Passaggio, appena dopo la Porta.
Occorre decifrare i segni, Gabriele, dirottare il presagio. L’ho detto anche a Ludovica, qualche giorno fa. L’ho detto anche Nicola. “Attendo il tempo in cui il miracolo riscriverà / la storia, la spalancherà, lascerà traballanti / le colonne del mondo”, scrive lei, e lui risponde che “Siamo il raggio di un mondo / che cigola. Una lettera al posto / di un’altra che le somigli ma parli / un’altra lingua”.
Entrambi sono nella mia stanza, lei suona il tamburo, lui fuma una sigaretta, guardano la fotografia che Simona ci ha scattato a Napoli.
Avrei voluto scattarla, una fotografia, a Sotirios e Vanguelis. Avremmo potuto essere noi, lo sai. Avremmo potuto camminare insieme fino alle sedie, poi sederci, ridere. Avremmo potuto dire che no, non riusciamo a ricordarlo da quanto tempo ci conosciamo. Magari a un giovane poeta greco, in qualche paesino accanto Roma. Magari a San Lorenzo.
Ti piaceva tanto, San Lorenzo. È un santo ed è un quartiere, è una notte ed è una piazza.
Poco prima che morissi ti avevo fatto il verso. Lo avevo fatto alle quartine sui morti. Continua a leggere→
 Dopo lo Strega Europeo, lo Strega Giovani e lo Strega Ragazze e ragazzi arriva un premio dedicato alla valorizzazione dei poeti troppo spesso trascurati dai media, dai lettori e talvolta anche dalla critica, ma che stanno guadagnando sempre più spazio sui social grazie agli instapoet e ad altri fenomeni.
Dopo lo Strega Europeo, lo Strega Giovani e lo Strega Ragazze e ragazzi arriva un premio dedicato alla valorizzazione dei poeti troppo spesso trascurati dai media, dai lettori e talvolta anche dalla critica, ma che stanno guadagnando sempre più spazio sui social grazie agli instapoet e ad altri fenomeni.

 Lingua, cultura e poesia yiddish, testimoni dell’ebraismo in Europa
Lingua, cultura e poesia yiddish, testimoni dell’ebraismo in Europa Dall’XII al XVIII secolo la letteratura in quella lingua comprendeva soprattutto commentari religiosi e pochi testi di narrativa.
Dall’XII al XVIII secolo la letteratura in quella lingua comprendeva soprattutto commentari religiosi e pochi testi di narrativa. Anche il pittore Marc Chagall (Lëzna, 1887 – Saint-Paul-de-Vence, 1985) scrisse poesie in yiddish, mentre l’artista Jacob Vassover (Łódź, 1926 – Tel Aviv, 2008) ebbe il merito di rappresentare in una notevole serie di dipinti a olio (di cui un nucleo consistente e significativo è conservato presso il Thesaurus Memoriae della Cittadella della musica concentrazionaria di Barletta) la vita negli shtetl, sia per osservazione diretta, negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, sia a rappresentazione dell’immaginario tratto dai romanzi e dai racconti di Sholem Aleichem.
Anche il pittore Marc Chagall (Lëzna, 1887 – Saint-Paul-de-Vence, 1985) scrisse poesie in yiddish, mentre l’artista Jacob Vassover (Łódź, 1926 – Tel Aviv, 2008) ebbe il merito di rappresentare in una notevole serie di dipinti a olio (di cui un nucleo consistente e significativo è conservato presso il Thesaurus Memoriae della Cittadella della musica concentrazionaria di Barletta) la vita negli shtetl, sia per osservazione diretta, negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, sia a rappresentazione dell’immaginario tratto dai romanzi e dai racconti di Sholem Aleichem.



 Dalla prefazione
Dalla prefazione




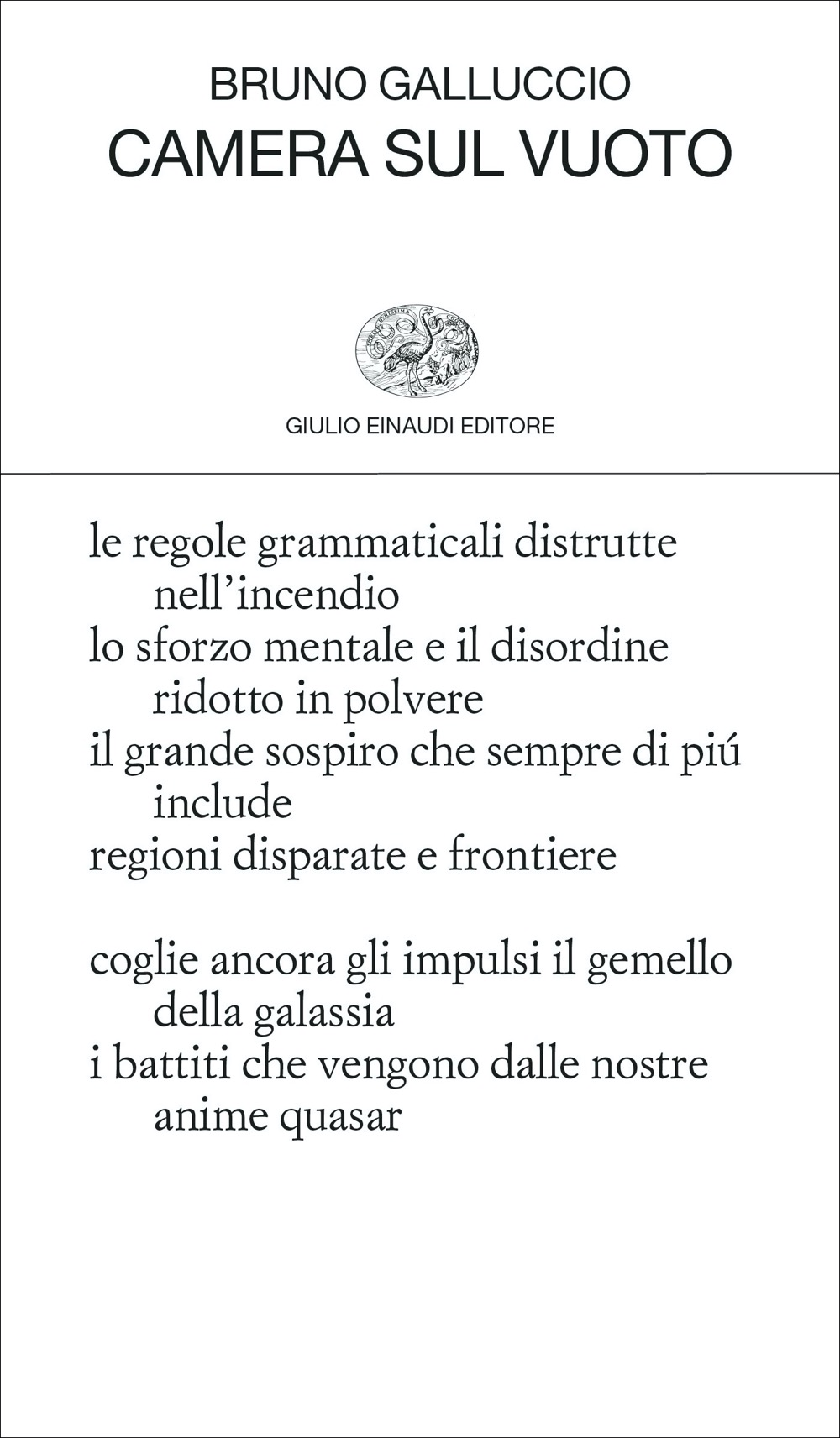










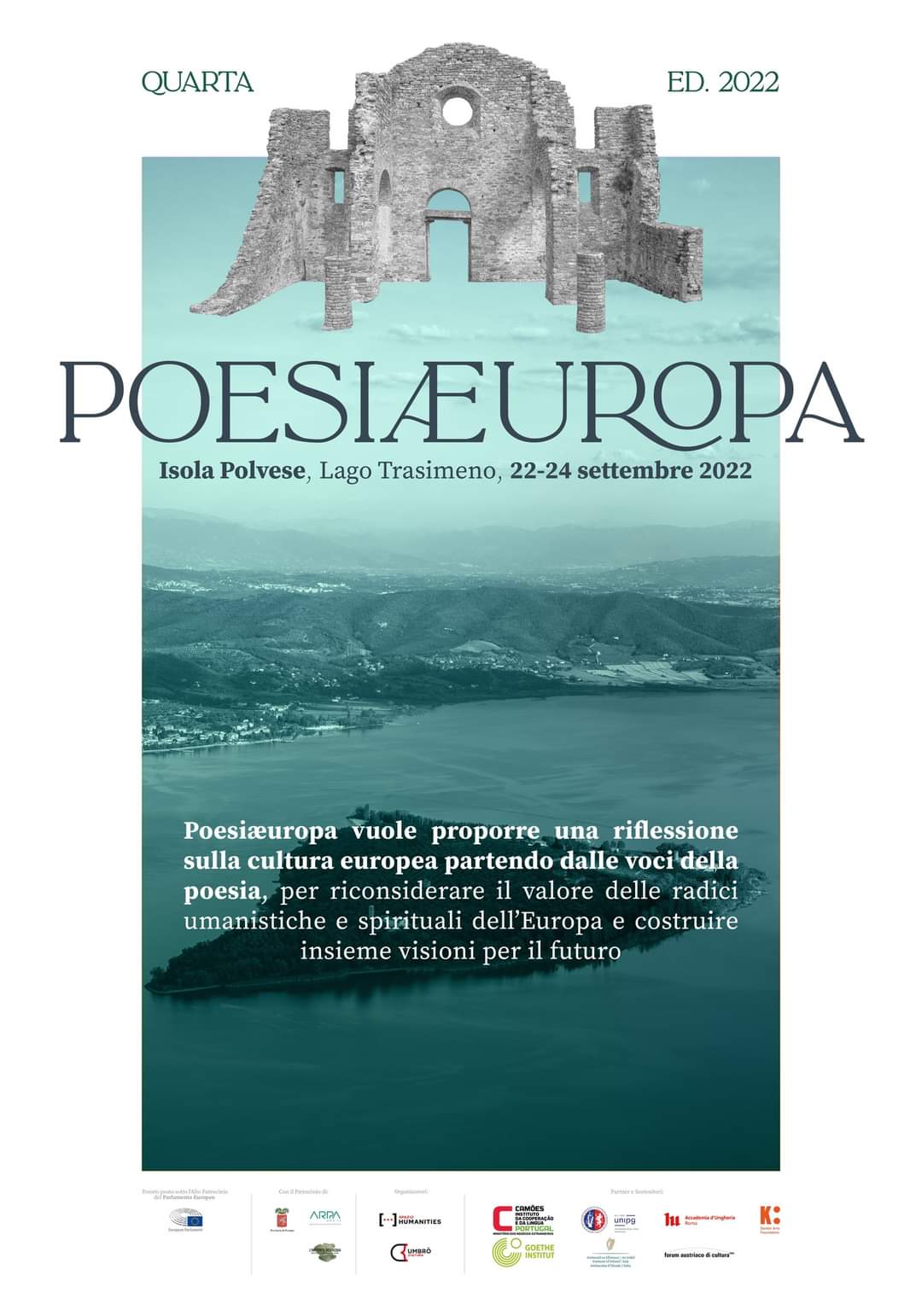


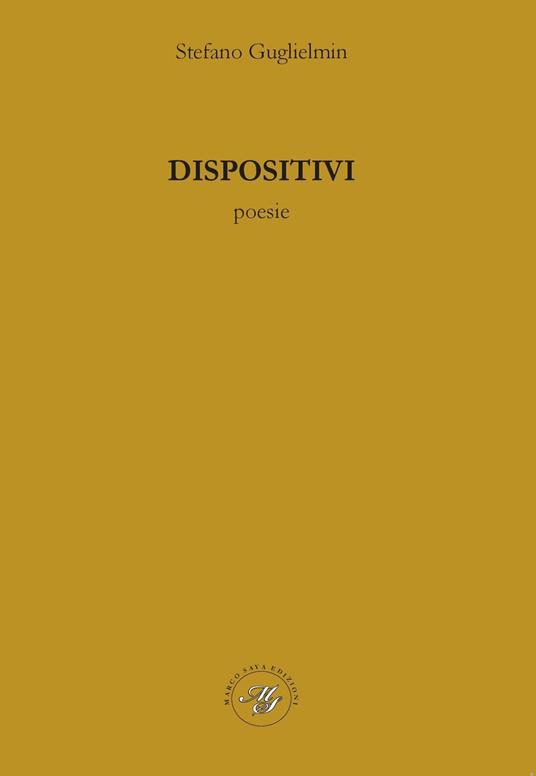 Proteggersi dall’osceno
Proteggersi dall’osceno





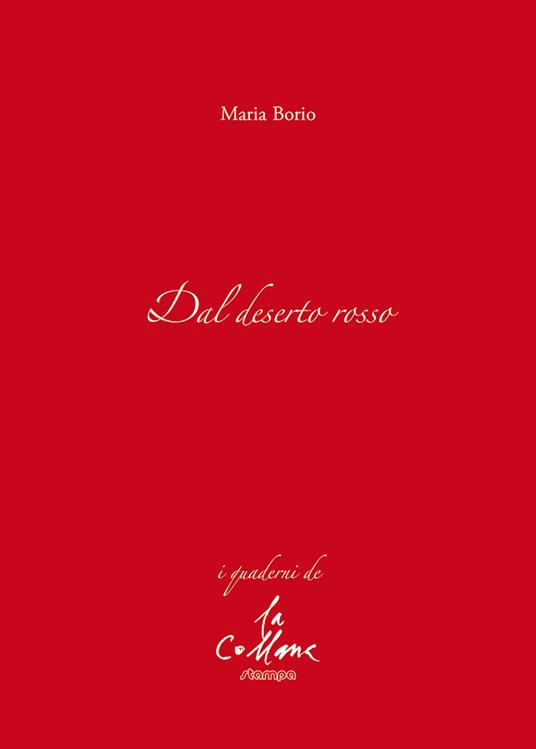

 La sua narrazione esprime un forte disagio sociale che vivono alcune donne oggi all’interno della famiglia. Anche se le madri che uccidono i propri figli ci sono sempre state e infatti i suoi racconti sono ambientati in epoche differenti. Essere madre oggi come ieri è una responsabilità che incombe principalmente sulla donna nella relazione con il figlio, ma anche con il marito, o con il proprio compagno. Ci sono donne che hanno una storia difficile alle loro spalle, non sufficientemente elaborata dalla donna stessa, altre donne, invece, quelle che hanno avuto la possibilità di elaborare il proprio vissuto riescono nella maternità perché non riflettono sui figli i propri fallimenti, la propria autodistruzione. Insomma il figlicidio può celare il dubbio che la responsabilità non sia soltanto delle madri che lo commettono ma anche della società che ha inculcato loro di dover essere madri a tutti i costi?
La sua narrazione esprime un forte disagio sociale che vivono alcune donne oggi all’interno della famiglia. Anche se le madri che uccidono i propri figli ci sono sempre state e infatti i suoi racconti sono ambientati in epoche differenti. Essere madre oggi come ieri è una responsabilità che incombe principalmente sulla donna nella relazione con il figlio, ma anche con il marito, o con il proprio compagno. Ci sono donne che hanno una storia difficile alle loro spalle, non sufficientemente elaborata dalla donna stessa, altre donne, invece, quelle che hanno avuto la possibilità di elaborare il proprio vissuto riescono nella maternità perché non riflettono sui figli i propri fallimenti, la propria autodistruzione. Insomma il figlicidio può celare il dubbio che la responsabilità non sia soltanto delle madri che lo commettono ma anche della società che ha inculcato loro di dover essere madri a tutti i costi?  Da Poesie di Vera Lùcia de Oliveira
Da Poesie di Vera Lùcia de Oliveira





 Nota
Nota [Nota a Margine ]
[Nota a Margine ]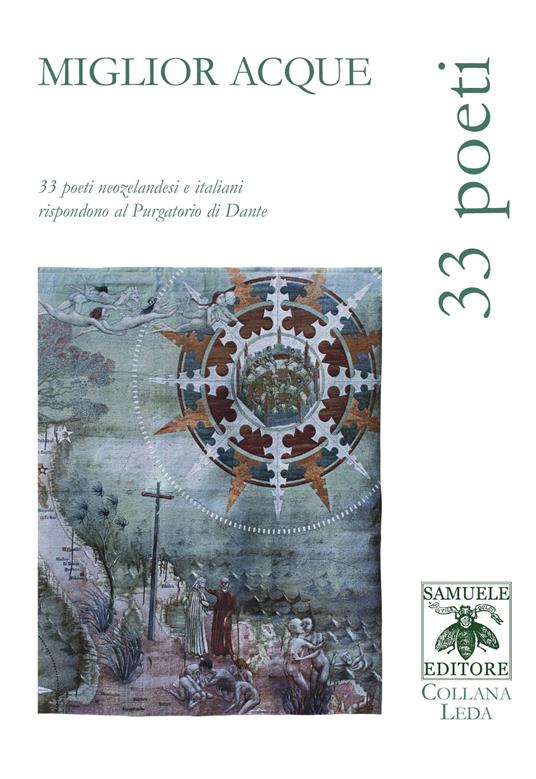


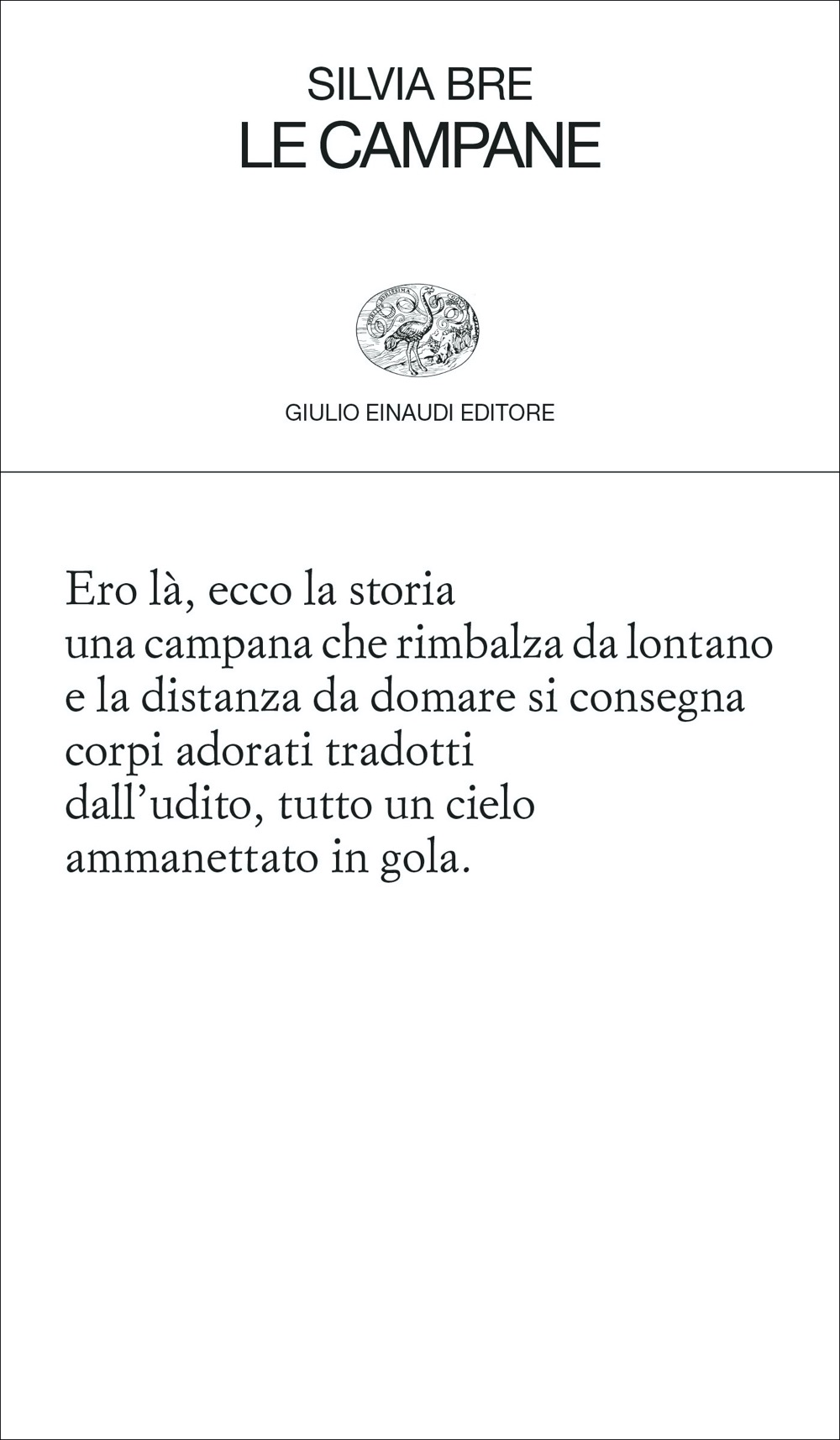



 Finiscono qui i legami tra The Hill We Climb e la Bibbia? Certo che no. Se strizziamo i versi, notiamo che gocciolano di sintagmi, parole-tenda, elementi morfologici i cui detergenti e additivi sono Vecchio e Nuovo Testamento. Ecco una rapida carrellata: «Nasce il giorno» (nell’originale «When day comes») corrisponde a Giovanni 14,20 «When that day comes», secondo la Bibbia di Re Giacomo fruibile in USA; nella formula idiomatica «il ventre della bestia» allignano Giona 2,1 «Giona restò nel ventre del pesce» e Apocalisse 13,1 «vidi salire dal mare una bestia»; l’«unione perfetta» richiama 1Corinzi 1,10 «siate in perfetta unione di pensiero e di intenti»; «alziamo i nostri sguardi non / su ciò che si frappone tra noi» è parallelo a 2Corinzi 4,18 «perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili»; in «un’ora di così grande terrore» riecheggia Luca 22,53 «ma questa è l’ora vostra e il potere delle tenebre». Si va avanti a lungo smerigliando la Genesi, Geremia, la Lettera ai Romani. Ma facciamo soltanto due esempi che riguardano la chiusa.
Finiscono qui i legami tra The Hill We Climb e la Bibbia? Certo che no. Se strizziamo i versi, notiamo che gocciolano di sintagmi, parole-tenda, elementi morfologici i cui detergenti e additivi sono Vecchio e Nuovo Testamento. Ecco una rapida carrellata: «Nasce il giorno» (nell’originale «When day comes») corrisponde a Giovanni 14,20 «When that day comes», secondo la Bibbia di Re Giacomo fruibile in USA; nella formula idiomatica «il ventre della bestia» allignano Giona 2,1 «Giona restò nel ventre del pesce» e Apocalisse 13,1 «vidi salire dal mare una bestia»; l’«unione perfetta» richiama 1Corinzi 1,10 «siate in perfetta unione di pensiero e di intenti»; «alziamo i nostri sguardi non / su ciò che si frappone tra noi» è parallelo a 2Corinzi 4,18 «perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili»; in «un’ora di così grande terrore» riecheggia Luca 22,53 «ma questa è l’ora vostra e il potere delle tenebre». Si va avanti a lungo smerigliando la Genesi, Geremia, la Lettera ai Romani. Ma facciamo soltanto due esempi che riguardano la chiusa. 


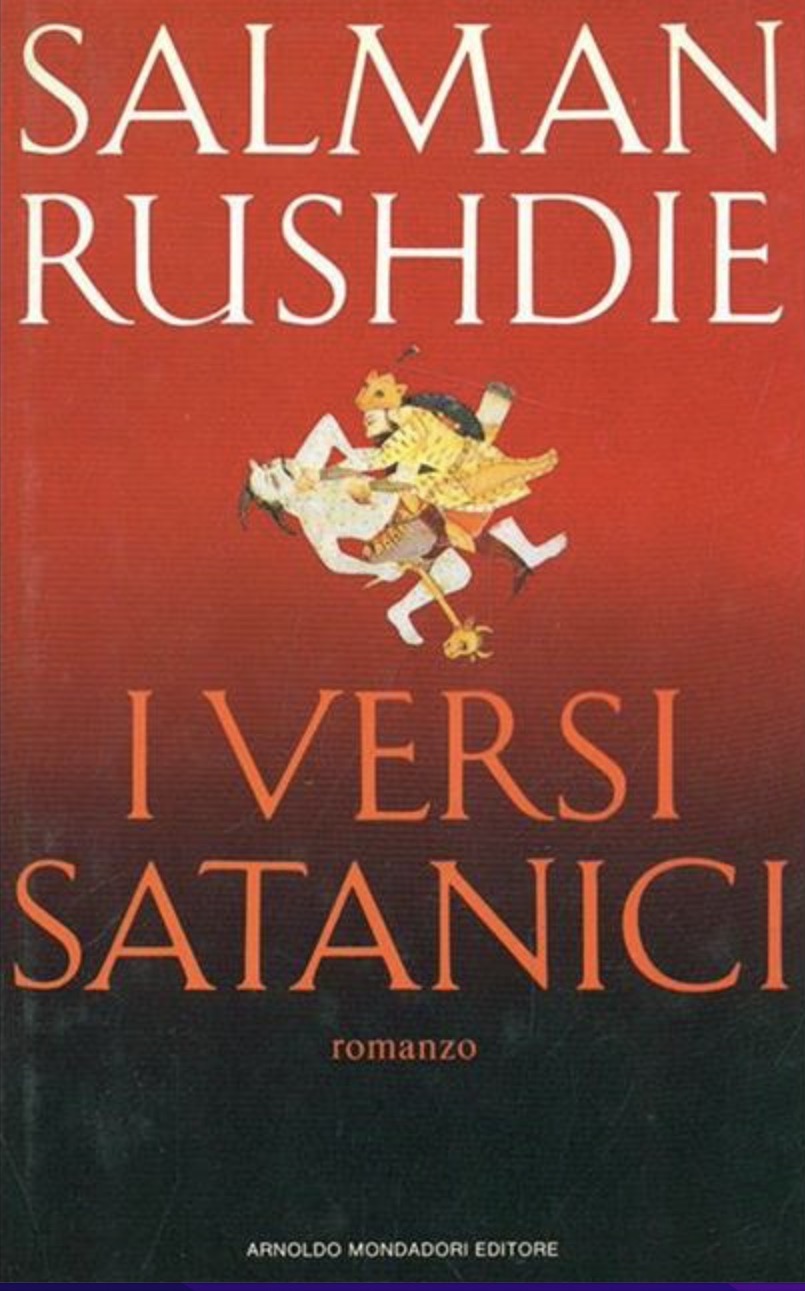 La Fatwa emessa nel 1988 dall’ayatollah Khomeini è piombata su di lui a causa del suo romanzo “I versi satanici” pubblicato in Italia da Mondadori.
La Fatwa emessa nel 1988 dall’ayatollah Khomeini è piombata su di lui a causa del suo romanzo “I versi satanici” pubblicato in Italia da Mondadori.