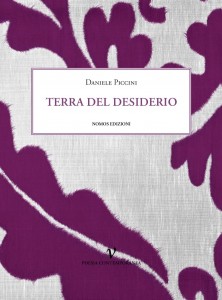Daniele Piccini
NOTA DI LETTURA DI ALBERTO FRACCACRETA
La poesia di Daniele Piccini è rivolta allo sgorgare primigenio della lingua, quasi al pieno raggiungimento del punto di confluenza tra logos e sorgente lirica. È dunque una poesia del culmine, al contempo deferente e dimessa, che considera gli hölderliniani «tempi di povertà» come occasione per affermare contra res l’assoluta centralità della parola nella vicenda umana. Il verso di Piccini nasce così da due snodi concettuali importanti: l’idea che la letteratura abbia nel suo DNA il desiderio, ossia l’irrinunciabile tensione indirizzata a un compimento massimo delle potenzialità (si veda il collected di saggi Letteratura come desiderio, Moretti & Vitali 2008); il proposito di rendere la poesia stessa come un luogo del santo — non del sacro — attraverso la glorificazione degli strumenti espressivi (qui il riferimento precipuo è La gloria della lingua, Morcelliana 2019): «Al posto del mito della gloria, l’assillo della testimonianza; in luogo della riprova sancita dal riconoscimento, la prova insuperabile, e in sé dotata di senso, del martirio-offerta».
Il compito del poeta è quello di testimoniare il proprio «martirio-offerta» nella considerazione agapica del suo magistero. Il poeta sembra quasi chiamato a vivere, in un momento storico così ostile, la prova della sua santità, asserendo senza sosta la parola che salva. Desiderio e martirio. Desiderio di martirio. I due tronchi teoretici della riflessione di Piccini non sono così distanti dall’Ungaretti del Dolore e dal Luzi di Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini: non sono così distanti, cioè, da un esercizio della lirica che, pur mantenendo vivo il nocciolo «metafisico» (si ricordi la jonction montaliana Baudelaire-Browning), possiede anche i crismi della poésie pure di Mallarmé.
 In un libro come Inizio fine, uscito da Crocetti nel 2013 e ristampato dal medesimo editore in questi giorni, possiamo osservare queste due grandi linee carsiche (la purezza del dettame e lo sguardo per l’oltranza) sintetizzate in un décor asseverativo che assomma in sé la fraternità leopardiana nel dolore e il senso di creaturalità di Francesco d’Assisi. Diviso in sette sezioni, alla cui sommità vi è un proemio slegato a mo’ di incipit («non eravamo nati come parte/ della materia muta che obbedisce»), Inizio fine è il richiamo alla coincidenza dell’«ultimo avamposto/ dell’inverno» e dei «fiori dentro l’erba» in una dizione stentorea e nitida. Coincidenza tanto più stringente quanto più orientata a svelare il mistero delle cose, la «quiete» o il «fuoco» della «comunione», lì dove si conosce per ardore: come nell’intensa elegia dedicata a Leopardi, la «nuova Nerina» viene a cercare il poeta che arde «in tutte le cose che ragionano». Continua a leggere
In un libro come Inizio fine, uscito da Crocetti nel 2013 e ristampato dal medesimo editore in questi giorni, possiamo osservare queste due grandi linee carsiche (la purezza del dettame e lo sguardo per l’oltranza) sintetizzate in un décor asseverativo che assomma in sé la fraternità leopardiana nel dolore e il senso di creaturalità di Francesco d’Assisi. Diviso in sette sezioni, alla cui sommità vi è un proemio slegato a mo’ di incipit («non eravamo nati come parte/ della materia muta che obbedisce»), Inizio fine è il richiamo alla coincidenza dell’«ultimo avamposto/ dell’inverno» e dei «fiori dentro l’erba» in una dizione stentorea e nitida. Coincidenza tanto più stringente quanto più orientata a svelare il mistero delle cose, la «quiete» o il «fuoco» della «comunione», lì dove si conosce per ardore: come nell’intensa elegia dedicata a Leopardi, la «nuova Nerina» viene a cercare il poeta che arde «in tutte le cose che ragionano». Continua a leggere




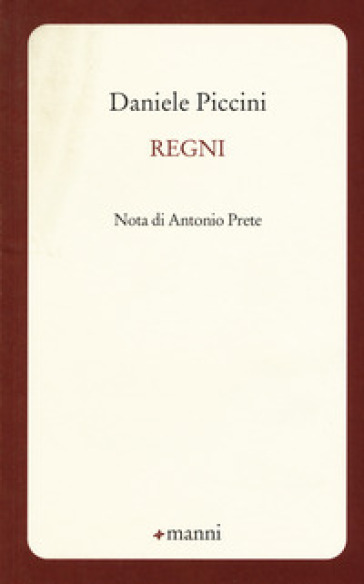 Dalla Nota di Antonio Prete
Dalla Nota di Antonio Prete